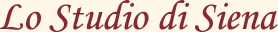|
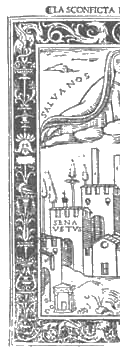 Su richiesta della Balía, che chiamava lo Studio “occhio principalissimo della reputazione” di Siena, il successore
di Francesco I, Ferdinando, introdusse alcune importanti riforme nel corpo docente, che fu distribuito nei collegi
dei medici, dei giuristi e degli “artisti”, comprendenti filosofi e teologi prima organizzati autonomamente. Furono
poi introdotti i concorsi a cattedre, al fine di evitare nomine “politiche” dei docenti e nel 1591 furono attribuiti
nuovi poteri giurisdizionali al Rettore dello Studio, eletto non solo dai rappresentanti degli scolari, ma anche dai
più alti magistrati cittadini. Il Rettore doveva essere, di preferenza, uno studente forestiero e la sua elezione
veniva festeggiata con balli, mascherate e recite di commedie per quasi un mese. Durante il rettorato del tedesco
Giorgio Fuccaro (1593), appoggiato dal primo Lettore di Lingua toscana Diomede Borghesi, furono approvate nuove
norme per disciplinare le attività didattiche e fu richiesta l'abolizione dei protezionismi scolastici a favore
dell'Ateneo pisano.
Su richiesta della Balía, che chiamava lo Studio “occhio principalissimo della reputazione” di Siena, il successore
di Francesco I, Ferdinando, introdusse alcune importanti riforme nel corpo docente, che fu distribuito nei collegi
dei medici, dei giuristi e degli “artisti”, comprendenti filosofi e teologi prima organizzati autonomamente. Furono
poi introdotti i concorsi a cattedre, al fine di evitare nomine “politiche” dei docenti e nel 1591 furono attribuiti
nuovi poteri giurisdizionali al Rettore dello Studio, eletto non solo dai rappresentanti degli scolari, ma anche dai
più alti magistrati cittadini. Il Rettore doveva essere, di preferenza, uno studente forestiero e la sua elezione
veniva festeggiata con balli, mascherate e recite di commedie per quasi un mese. Durante il rettorato del tedesco
Giorgio Fuccaro (1593), appoggiato dal primo Lettore di Lingua toscana Diomede Borghesi, furono approvate nuove
norme per disciplinare le attività didattiche e fu richiesta l'abolizione dei protezionismi scolastici a favore
dell'Ateneo pisano.
Il rapido declino delle funzioni rettorali agli albori del XVII secolo avviò un processo di municipalizzazione
dello Studio, dove l'istituto dei concorsi a cattedra fu abolito nel giugno 1621 e dove mutarono gli organi
direttivi, ormai monopolio esclusivo dell'aristocrazia senese fedele al granduca. Insieme ai molti lettori
appartenenti a questo nucleo oligarchico locale, insegnarono a Siena fra il Sei e il Settecento anche alcuni
maestri di fama internazionale, come – ad esempio – Pirro Maria Gabrielli, fondatore nel 1691 dell'Accademia
dei Fisiocritici, sorta a Siena a somiglianza della fiorentina Accademia del Cimento.
Superata la difficile situazione economica in cui si era venuto a trovare al momento dell'estinzione della
dinastia medicea nel 1737, l'Ateneo senese acquisì sotto il governo dei Lorena
la grande biblioteca di
|
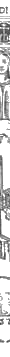
|
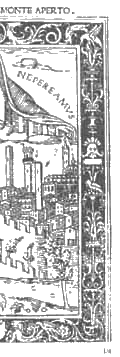 Sallustio Bandini, l'illustre economista precursore dei Fisiocrati, e rinnovò la sua amministrazione, guidata
da un Provveditore nominato dal granduca. Con l'occupazione francese della Toscana nel 1808, lo Studio di Siena
fu soppresso e il suo Provveditore fu nominato commissario della nuova Scuola medica, unico surrogato napoleonico
dell'antica Facoltà di medicina. Ripresa poi l'attività sotto il restaurato Ferdinando III, lo Studio, suddiviso
in quattro Collegi (legale, medico-fisico e teologico, cui si aggiunse in seguito quello filosofico), fu
trasferito dalla Casa della Sapienza nei locali dell'ex-convento dei Vallombrosani, vicino
alla chiesa di san Vigilio.
Sallustio Bandini, l'illustre economista precursore dei Fisiocrati, e rinnovò la sua amministrazione, guidata
da un Provveditore nominato dal granduca. Con l'occupazione francese della Toscana nel 1808, lo Studio di Siena
fu soppresso e il suo Provveditore fu nominato commissario della nuova Scuola medica, unico surrogato napoleonico
dell'antica Facoltà di medicina. Ripresa poi l'attività sotto il restaurato Ferdinando III, lo Studio, suddiviso
in quattro Collegi (legale, medico-fisico e teologico, cui si aggiunse in seguito quello filosofico), fu
trasferito dalla Casa della Sapienza nei locali dell'ex-convento dei Vallombrosani, vicino
alla chiesa di san Vigilio.
Fin dal 1832, in occasione dei primi moti risorgimentali, molti studenti senesi, incuranti della repressione
granducale, si iscrissero alla Giovine Italia e parteciparono con entusiasmo a varie manifestazioni patriottiche.
Nel luglio del 1847 uno di essi, Ludovico Petronici, appartenente al Collegio medico e noto come liberale, fu
ucciso in uno scontro con la polizia. Dopo questo tragico episodio i rapporti fra autorità e scolaresca divennero
sempre più tesi, finché nell'aprile 1848 tre professori, un assistente e cinquantacinque studenti dell'Ateneo
senese costituirono la compagnia della Guardia universitaria e parteciparono, a fianco dei colleghi pisani, alla
decisiva difesa dell'esercito sardo nei campi lombardi di Curtatone e Montanara. Col decreto del 28 ottobre 1851
Leopoldo II stabilì che a Siena rimanessero solo le Facoltà di giurisprudenza e teologia, mentre a Pisa dovevano
essere concentrate medicina, filologia e filosofia, scienze matematiche e scienze naturali. Otto anni dopo, il
governo provvisorio insediato al posto del granduca, che era stato costretto ad abbandonare Firenze, riorganizzò
le due Università, privilegiando però quella pisana, soprattutto riguardo alle Facoltà umanistiche.
|