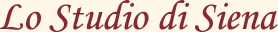|
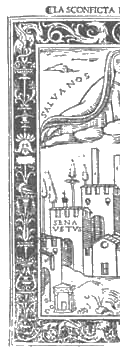 Ciò non capitò col grande umanista Francesco Filelfo, chiamato ad insegnare lettere greche e latine nel 1434
con un premio altissimo e con lo stipendio annuo di 350 fiorini d'oro, la cifra più alta fino ad allora offerta
dallo Studio senese. Col Filelfo altri cultori delle humanae litterae soggiornarono a Siena nella prima
metà del secolo XV: qui, infatti, il Marrasio, innamorato di Angelina Piccolomini, scrisse l'Angelinetum;
qui Enea Silvio – il futuro Pio II – esordì con la sua Cinthia e qui Antonio Beccadelli detto il
Panormita compose gli epigrammi poi raccolti sotto il titolo di Hermaphrodytus e ispirati alle esperienze
goliardiche dell'autore, che nei suoi versi definisce Siena molles – cioè morbida, dolce,
lussuriosa – una civitas Veneris, per dirla con un altro famoso umanista, dove la tradizione ludica
degli studenti era strettamente legata alle rappresentazioni teatrali e ad altre forme di pubblico spettacolo,
culminanti nella "serra degli scolari" durante il carnevale. Allo Studio si collega anche l'introduzione a
Siena dell'arte della stampa: furono infatti tre giovani docenti di diritto a chiamare nella città un tipografo
tedesco, Enrico di Colonia, che iniziò il suo lavoro pubblicando nel 1484 la Lectura super VI libro
Codicis di Paolo di Castro.
Ciò non capitò col grande umanista Francesco Filelfo, chiamato ad insegnare lettere greche e latine nel 1434
con un premio altissimo e con lo stipendio annuo di 350 fiorini d'oro, la cifra più alta fino ad allora offerta
dallo Studio senese. Col Filelfo altri cultori delle humanae litterae soggiornarono a Siena nella prima
metà del secolo XV: qui, infatti, il Marrasio, innamorato di Angelina Piccolomini, scrisse l'Angelinetum;
qui Enea Silvio – il futuro Pio II – esordì con la sua Cinthia e qui Antonio Beccadelli detto il
Panormita compose gli epigrammi poi raccolti sotto il titolo di Hermaphrodytus e ispirati alle esperienze
goliardiche dell'autore, che nei suoi versi definisce Siena molles – cioè morbida, dolce,
lussuriosa – una civitas Veneris, per dirla con un altro famoso umanista, dove la tradizione ludica
degli studenti era strettamente legata alle rappresentazioni teatrali e ad altre forme di pubblico spettacolo,
culminanti nella "serra degli scolari" durante il carnevale. Allo Studio si collega anche l'introduzione a
Siena dell'arte della stampa: furono infatti tre giovani docenti di diritto a chiamare nella città un tipografo
tedesco, Enrico di Colonia, che iniziò il suo lavoro pubblicando nel 1484 la Lectura super VI libro
Codicis di Paolo di Castro.
Anche i libri usciti in seguito dai torchi dei prototipografi senesi si rivolgevano soprattutto a una
clientela di studenti che, negli ultimi decenni del XV secolo,
|
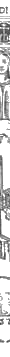
|
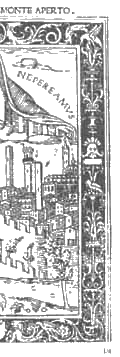 raggiungevano il numero di 600 per addottorarsi in Arti (Medicina e Filosofia) dopo sette anni di corso, o in
Diritto Civile e Canonico dopo cinque. Durante l'anno accademico – che iniziava il 18 ottobre e terminava alla
fine di giugno – i professori dovevano tenere lezione almeno a cinque studenti, pena una multa, e dovevano poi,
dopo la lezione, trattenersi a discutere in piazza, con l'abito dottorale, per una buona mezz'ora. Queste ed
altre regole persero con l'andar del tempo il loro vigore e lo Studio senese attraversò, lungo l'arco del
Cinquecento, alcuni periodi di crisi, dovuti innanzitutto alla concorrenza dell'Ateneo pisano, protetto da
Cosimo I de'Medici, poi alle conseguenze della guerra di Siena, conclusa con la resa di quest'ultima alle truppe
imperiali nell'aprile del 1555.
raggiungevano il numero di 600 per addottorarsi in Arti (Medicina e Filosofia) dopo sette anni di corso, o in
Diritto Civile e Canonico dopo cinque. Durante l'anno accademico – che iniziava il 18 ottobre e terminava alla
fine di giugno – i professori dovevano tenere lezione almeno a cinque studenti, pena una multa, e dovevano poi,
dopo la lezione, trattenersi a discutere in piazza, con l'abito dottorale, per una buona mezz'ora. Queste ed
altre regole persero con l'andar del tempo il loro vigore e lo Studio senese attraversò, lungo l'arco del
Cinquecento, alcuni periodi di crisi, dovuti innanzitutto alla concorrenza dell'Ateneo pisano, protetto da
Cosimo I de'Medici, poi alle conseguenze della guerra di Siena, conclusa con la resa di quest'ultima alle truppe
imperiali nell'aprile del 1555.
Solo sotto il reggente Francesco de'Medici, che nel 1569 creò una nuova commissione, formata da membri della
Balía, per provvedere alle necessità dello Studio, questo riprese a svilupparsi, come dimostra il notevole
incremento di laureati nel periodo del Principato rispetto agli ultimi decenni del periodo repubblicano.
Divenuto granduca nel 1569, Francesco approvò in quello stesso anno gli statuti della numerosa "nazione" degli
studenti tedeschi a Siena, dimostrando così di non essere disposto ad avallare le accuse di luteranesimo
frequentemente formulate dall'Inquisizione contro di essi e favorendo la loro affluenza nella città.
|