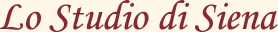|
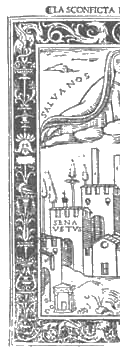 Questo documento permetteva di conferire i gradi accademici in tutte le Facoltà, esclusa quella teologica, e
ribadiva, per professori e scolari, alcuni importanti privilegi, sull'osservanza dei quali doveva vigilare il
vescovo di Siena, investito anche dell'autorità di concedere le lauree. E proprio dal vescovo della città
venne, nel dicembre 1392, il suggerimento di fondare una Casa di Sapienza per “mantenere e perpetovare” lo
Studio, come già avevano fatto Bologna e Perugia. Il suggerimento fu ben accolto, ma le difficili condizioni in
cui si trovava la città – oppressa da carestie, pestilenze ed esose pretese delle compagnie di ventura e costretta
infine nel 1399 a sottomettersi al duca di Milano Gian Galeazzo Visconti per meglio difendersi da Firenze – non
permisero una rapida realizzazione del progetto, di cui si tornò a parlare nel 1408, quando il Concistoro senese
rivolse una supplica al papa Gregorio XII per trasformare i locali di un'antica istituzione caritativa, chiamata
Casa della Misericordia, in Casa della Sapienza. Gregorio XII, così bisognoso di mantenersi amici i senesi, emanò
ben otto bolle, che – nel loro complesso – costituirono una concreta base per la nascita della Sapienza e, più
in generale, per lo sviluppo dello Studio: non solo decretò, infatti, che la Misericordia fosse destinata ad
ospitare trenta scolari poveri di Siena e del contado, ma che le sue rendite fossero incrementate e assegnate al
mantenimento del Collegio. Quando, tuttavia, fra il 1416 e il 1418 vi furono finalmente ammessi i primi trenta
scolari; fra di essi non c'era neppure un senese e tutti pagavano cinquanta fiorini all'anno per il soggiorno.
L'aver mutato radicalmente i requisiti dei destinatari di quel nuovo servizio creato dal Comune di Siena a
vantaggio dell'organizzazione scolastica si deve all'oligarchia allora al potere, preoccupata
soprattutto di due cose: prima
Questo documento permetteva di conferire i gradi accademici in tutte le Facoltà, esclusa quella teologica, e
ribadiva, per professori e scolari, alcuni importanti privilegi, sull'osservanza dei quali doveva vigilare il
vescovo di Siena, investito anche dell'autorità di concedere le lauree. E proprio dal vescovo della città
venne, nel dicembre 1392, il suggerimento di fondare una Casa di Sapienza per “mantenere e perpetovare” lo
Studio, come già avevano fatto Bologna e Perugia. Il suggerimento fu ben accolto, ma le difficili condizioni in
cui si trovava la città – oppressa da carestie, pestilenze ed esose pretese delle compagnie di ventura e costretta
infine nel 1399 a sottomettersi al duca di Milano Gian Galeazzo Visconti per meglio difendersi da Firenze – non
permisero una rapida realizzazione del progetto, di cui si tornò a parlare nel 1408, quando il Concistoro senese
rivolse una supplica al papa Gregorio XII per trasformare i locali di un'antica istituzione caritativa, chiamata
Casa della Misericordia, in Casa della Sapienza. Gregorio XII, così bisognoso di mantenersi amici i senesi, emanò
ben otto bolle, che – nel loro complesso – costituirono una concreta base per la nascita della Sapienza e, più
in generale, per lo sviluppo dello Studio: non solo decretò, infatti, che la Misericordia fosse destinata ad
ospitare trenta scolari poveri di Siena e del contado, ma che le sue rendite fossero incrementate e assegnate al
mantenimento del Collegio. Quando, tuttavia, fra il 1416 e il 1418 vi furono finalmente ammessi i primi trenta
scolari; fra di essi non c'era neppure un senese e tutti pagavano cinquanta fiorini all'anno per il soggiorno.
L'aver mutato radicalmente i requisiti dei destinatari di quel nuovo servizio creato dal Comune di Siena a
vantaggio dell'organizzazione scolastica si deve all'oligarchia allora al potere, preoccupata
soprattutto di due cose: prima
|
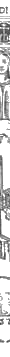
|
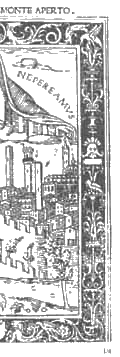 di creare un solido punto d'appoggio amministrativo e finanziario per lo Studio, che era stato sospeso
nel 1411 a causa della peste e duramente contestato dal Rettore dell'Ospedale S. Maria della Scala, convinto
che i fondi pubblici destinati ai professori dovessero essere usati in gentibus armorum e non gettati via
per pagare chi faceva lezione solo propriis famulis. In secondo luogo la Sapienza avrebbe dovuto costituire
uno degli elementi di conservazione di uno Stato, che aveva bisogno di un gruppo d'intellettuali legati a vari
potentati stranieri. L'esservi ammessi era quindi un privilegio e le raccomandazioni che imperatori, papi, cardinali
e altri importanti personaggi ripetutamente spedirono al governo senese per far entrare nel collegio i loro protetti
furono vagliate sempre alla luce dello specifico interesse politico che in quel momento Siena poteva trarne.
di creare un solido punto d'appoggio amministrativo e finanziario per lo Studio, che era stato sospeso
nel 1411 a causa della peste e duramente contestato dal Rettore dell'Ospedale S. Maria della Scala, convinto
che i fondi pubblici destinati ai professori dovessero essere usati in gentibus armorum e non gettati via
per pagare chi faceva lezione solo propriis famulis. In secondo luogo la Sapienza avrebbe dovuto costituire
uno degli elementi di conservazione di uno Stato, che aveva bisogno di un gruppo d'intellettuali legati a vari
potentati stranieri. L'esservi ammessi era quindi un privilegio e le raccomandazioni che imperatori, papi, cardinali
e altri importanti personaggi ripetutamente spedirono al governo senese per far entrare nel collegio i loro protetti
furono vagliate sempre alla luce dello specifico interesse politico che in quel momento Siena poteva trarne.
La Sapienza, avendo ereditato un patrimonio davvero imponente, costituito soprattutto da case e botteghe in
città, da una fattoria e da oltre cento poderi nel contado, divenne il "membro principale" dello Studio
senese, com'è scritto nel verbale del Consiglio generale del 25 febbraio 1438 e come ricorda anche oggi il
sigillo universitario, dove una grande "M" sovrastata da una croce e sorretta dalla mano di S. Caterina
d'Alessandria, indica il legame fra l'Ateneo e l'antica domus Misericordiae. Nel 1472, al momento
della costituzione del Monte di Pietà, la Sapienza vi contribuì con trecento fiorini e l'anno seguente il
governo decise che a spese del collegio dovessero essere costruite due case ogni anno per un decennio.
La Sapienza aveva quindi un ruolo significativo nella vita economica urbana, ma alla sua fortuna non sempre
corrispose il buon funzionamento dello Studio, che a volte si lasciava sfuggire l'occasione di
avvalersi di buoni maestri.
|