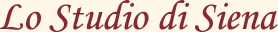|
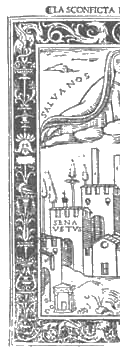 Per provvedere alle chiamate dei docenti e alla conseguente affluenza degli scolari, il Concistoro senese
nominò – all'inizio del XIV secolo – tre Savi, poi divenuti sei, che avevano l'incarico di proporre gli stipendi
dei professori in base alla loro fama. Un atto notarile sanciva i termini della “condotta” di un maestro, che si
impegnava a stabilirsi a Siena a ad insegnare fideliter et bona fide. Se esso avesse tradito questa
fiducia, la sua caricatura avrebbe campeggiato sulle mura della città, offrendolo così al pubblico ludibrio.
Per provvedere alle chiamate dei docenti e alla conseguente affluenza degli scolari, il Concistoro senese
nominò – all'inizio del XIV secolo – tre Savi, poi divenuti sei, che avevano l'incarico di proporre gli stipendi
dei professori in base alla loro fama. Un atto notarile sanciva i termini della “condotta” di un maestro, che si
impegnava a stabilirsi a Siena a ad insegnare fideliter et bona fide. Se esso avesse tradito questa
fiducia, la sua caricatura avrebbe campeggiato sulle mura della città, offrendolo così al pubblico ludibrio.
Fra i numerosi giuristi che illustrarono le cattedre senesi di Decretali, di Diritto Civile e Canonico e di
Notaría nel XIII secolo sono da ricordare Pepo Salvani, Giacomo Pagliaresi e quel Benincasa d'Arezzo
che – trasferitosi a Roma a fare il giudice – fu ucciso, come ricorda Dante nel VI canto del
Purgatorio, “da le braccia fiere di Ghin di Tacco”. Un altro fatto di sangue e un altro maestro di diritto
segnano, nel 1321, una tappa importante nella vita dello Studio di Siena: la condanna a morte inflitta in
quell'anno dai magistrati bolognesi ad uno scolaro, reo di avere rapita una fanciulla della città,
provocò, infatti, una migrazione in massa degli studenti di quella Università verso l'Ateneo senese, dove li
aveva indirizzati Guglielmo Tolomei, allora lettore di Legge a Bologna.
|
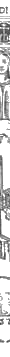
|
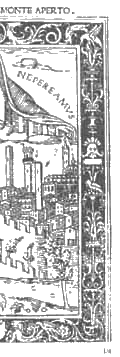 Il Comune di Siena decise di stanziare subito ingenti somme per accogliere nel migliore dei modi questi scolari
e furono loro accordati numerosi privilegi, esenzioni di tasse e franchigie. La reazione bolognese non
tardò a far sentire i propri effetti, ma intanto la fama dello Studio di Siena era notevolmente aumentata
e quando Guglielmo Tolomei morì, i concittadini riconoscenti posero sulla sua tomba nella chiesa di San Domenico
una lapide – poi trasportata nel cortile dell'Università – dove si ricorda il contributo da lui dato alla storica
migrazione. Frequentato da molti scolari stranieri – soprattutto tedeschi, spagnoli, portoghesi e borgognoni – lo
Studio senese riuscì a mantenere in cattedra, anche dopo la riconciliazione con Bologna e nonostante la rivalità
di Firenze e Perugia, valentissimi insegnanti, come il canonista Federico Petrucci, il civilista Giovanni
Pagliaresi, il poeta e giurista Cino da Pistoia. Alcuni brevi periodi di crisi, dovuti a questioni di bilancio, non
interruppero il lavoro diplomatico del Concistoro di Siena, teso a ottenere un autorevole riconoscimento giuridico
per lo Studio, che fu finalmente annoverato fra le Università del Sacro Romano Impero in un diploma concesso a
Praga dall'imperatore Carlo IV il 16 agosto 1357.
Il Comune di Siena decise di stanziare subito ingenti somme per accogliere nel migliore dei modi questi scolari
e furono loro accordati numerosi privilegi, esenzioni di tasse e franchigie. La reazione bolognese non
tardò a far sentire i propri effetti, ma intanto la fama dello Studio di Siena era notevolmente aumentata
e quando Guglielmo Tolomei morì, i concittadini riconoscenti posero sulla sua tomba nella chiesa di San Domenico
una lapide – poi trasportata nel cortile dell'Università – dove si ricorda il contributo da lui dato alla storica
migrazione. Frequentato da molti scolari stranieri – soprattutto tedeschi, spagnoli, portoghesi e borgognoni – lo
Studio senese riuscì a mantenere in cattedra, anche dopo la riconciliazione con Bologna e nonostante la rivalità
di Firenze e Perugia, valentissimi insegnanti, come il canonista Federico Petrucci, il civilista Giovanni
Pagliaresi, il poeta e giurista Cino da Pistoia. Alcuni brevi periodi di crisi, dovuti a questioni di bilancio, non
interruppero il lavoro diplomatico del Concistoro di Siena, teso a ottenere un autorevole riconoscimento giuridico
per lo Studio, che fu finalmente annoverato fra le Università del Sacro Romano Impero in un diploma concesso a
Praga dall'imperatore Carlo IV il 16 agosto 1357.
|