Altezza/nota
La notazione delle altezze
Come è stato evidenziato nella sezione dedicata alle qualità
del suono, l’altezza è una caratteristica
che è funzione della frequenza fondamentale di ogni suono. Tale qualità
è stata la più studiata nella teoria acustica della cultura
occidentale, a partire dai teorici di scuola pitagorica (V secolo a.C.). La
differenza di altezza fra due suoni, detta intervallo,
è infatti percepita come differenza in acutezza o gravità, e
tale fenomeno è a sua volta esprimibile attraverso parametri numerici,
dunque scientificamente determinati. Lo studio dell’acustica musicale,
configurandosi nella cultura greca come disciplina scientifica, comportò
la necessità di scrivere i suoni, ovvero
di trovare un sistema simbolico mediante il quale fosse possibile indicare
le differenze di altezza, così da poter organizzare i suoni in un sistema
intervallare, ovvero in una scala musicale.
La scala musicale pitagorica aveva una funzione teorica, serviva cioè ai filosofi e agli scienziati che si occupavano di teoria armonica, ma non ai musicisti, perché la musica nell’antichità non veniva scritta. Il sistema di notazione, cioè il modo ‘scritto’ per individuare l’altezza dei suoni, era utile soprattutto ai teorici, per la determinazione degli intervalli e delle scale musicali. In tal senso si sfruttava l’alfabeto greco, poi – grazie al filosofo Severino Boezio, che trasmise nel 500 la cultura musicale greca nel mondo latino – cominciò ad essere impiegato l’alfabeto latino, sostituendo le lettere greche con le prime quindici dell’alfabeto latino (da A a P) finché in età alto medievale, attorno al secolo X, le prime sette lettere dell’alfabeto A, B, C, D, E, F, G, furono adottate per indicare sette gradi della scala, in ordine crescente (ove alla lettera A corrisponde l’attuale la).
Notazione neumatica e pentagramma
Fu grazie alla cristianizzazione dell’Europa, e dunque alle crescenti esigenze liturgiche, che cominciò a diffondersi un modo nuovo di segnalare le altezze dei suoni. Monaci ed ecclesiastici avevano bisogno di fissare l’andamento melodico dei canti liturgici per insegnarli ai novizi e tramandarli ai posteri. Le parole della liturgia che venivano intonate cominciarono così a coprirsi nei manoscritti di accenti che indicavano il profilo melodico del brano, ma senza indicazioni di altezza assoluta e durata: si trattava, piuttosto, di indicazioni di intonazione e flessione della voce per i quali la notazione alfabetica era, in pratica, inutilizzabile. Probabilmente questo nuovo modo di ’scrivere’ la musica si era sviluppato a partire dai segni accentuativi della prosodia (accenti, spiriti dolci e aspri ecc.) e originariamente era forse riferito alla gestualità del maestro che delineava l’andamento del canto con la mano (chironimia). Da queste premesse si sviluppò la notazione neumatica, i cui segni essenziali erano la virgola (virga) che indica un suono più acuto e il punto (punctum) che indica un suono più grave, mentre gruppi di due, tre o più suoni erano indicati da particolari legature. Questo tipo di notazione ebbe uno sviluppo alquanto differenziato nei vari paesi europei, tanto da dare origine a molte famiglie neumatiche, fra le quali si impose la notazione quadrata, sviluppata in territorio aquitano. Gradualmente i copisti, scrivendo nelle pergamene in cui erano tracciati i righi a secco, iniziarono a scrivere a righi alterni le parole dei testi liturgici da intonare, utilizzando il rigo rimasto vuoto per organizzarvi intorno i vari accenti e segni notazionali. Tale prassi, trasmessa con crescente precisione e abilità, portò alla notazione neumatica diastematica, che nella sua graduale evoluzione comportò al raddoppio, poi la quadruplicazione del rigo, consentendo così di indicare le altezze relative dei suoni con maggiore dettaglio. Il tetragramma, un insieme di quattro linee e tre spazi, fu universalmente utilizzato per scrivere la musica gregoriana, secondo la prassi stabilita dal teorico musicale Guido d’Arezzo (+1050); ma fu solo nel corso del ’500, e soprattutto con l’invenzione della stampa, che si stabilizzò la prassi di scrivere la musica nel pentagramma, un insieme di cinque linee e quattro spazi, il sistema utilizzato ancora oggi.
Contestualmente all’aver organizzato i neumi su righi
e spazi, emerse la necessità di fissare un’altezza di riferimento rispetto
alla quale ’leggere’ i neumi impiegati: nacque così la chiave
musicale. La chiave altro non è che un simbolo per indicare quale suono deve
essere suonato o cantato sul rigo cui la chiave si riferisce: tutti gli altri
suoni sono riferiti in senso ascendente e discendente sui righi e sugli spazi.
Nel medioevo le prime chiavi ad essere utilizzate furono quelle di F=fa e
C=do. La chiave di fa, detta
anche chiave di basso,
deriva da una F stilizzata, che rappresenta il suono di altezza F indicato
da quel rigo. Stessa cosa per la chiave di do,
corrispondente al suono di altezza C. La scelta di questi due suoni dipese
dal fatto che F e C erano preceduti nella scala da un semitono: gli intervalli
E-F (mi/fa) e B-C (si/do) sono entrambi di mezzo tono. Non avendo possibilità
di determinare l’altezza assoluta di una nota, il semitono serviva infatti
da orientamento per l’organizzazione melodica, e dunque anche per la
lettura del brano in notazione. Gradualmente fu introdotta anche la chiave
di sol (G=sol), detta oggi anche chiave di violino.
Analogamente a quelle di fa e di do, anche la chiave di sol (G) non è altro
che una G, che indica l’altezza che chiamiamo sol. In pratica, l’abbinamento
del sistema della chiave a quello della notazione diastematica consentiva
di unire il sistema scalare della notazione alfabetica latina con quello neumatico.
Nello schema sono indicate le quattro chiavi musicali oggi maggiormente impiegate
per la musica vocale e strumentale: la necessità di utilizzarne più di una
deriva dal registro (l’estensione in altezza) dello strumento
o della voce per i quali la musica è pensata. La linea
rosa indica la posizione del do3, il do centrale della tastiera del pianoforte,
relativamente a pentagrammi organizzati sulle principali chiavi.
Oggi si tende a semplificare l’impiego delle chiavi. Per le partiture degli strumenti a tastiera vengono usati due pentagrammi sovrapposti contrassegnati l’uno dalla chiave di fa, l’altro di sol. Per le voci e strumenti acuti viene impiegata la chiave di sol, mentre per voci e strumenti gravi quella di fa.
Le note vengono collocate nel pentagramma e la loro altezza si riferisce alla chiave dello stesso pentagramma: una volta stabilita la chiave, ad esempio quella di sol, ne consegue che ogni nota, collocata in una determinata posizione, cioè sugli spazi o sui righi superiori o inferiori, indica un grado specifico della scala.
Per altezze che eccedono in acutezza o gravità rispetto alla collocazione nel pentagramma vengono impiegati tagli addizionali, o segni che indicano l’ottava inferiore o superiore. Nel seguente grafico è indicata la posizione in pentragramma delle note che coprono quattro ottave della tastiera, da do1 a do5:
I nomi delle note
Per completare il quadro della rappresentazione grafica delle altezze dei
suoni occorre accennare al processo che permise di dare un nome a ciascuna
altezza, il nome ancora oggi in uso nelle lingue neolatine: do,
re, mi, fa,
sol, la, si.
Il primo sistema adottato per indicare questi gradi consisteva nell’usare
la notazione alfabetica (A, B, C, D, E, F, G), e nella cultura anglosassone,
ancora oggi, le prime sette lettere dell’alfabeto corrispondono ai sette
suoni della scala. Ma nel mondo latino, grazie agli sforzi pedagogici del
monaco Guido d’Arezzo, si diffuse un modo
diverso di nominare le note. In effetti, la notazione alfabetica non rifletteva
l’organizzazione modale del canto gregoriano, la quale si basava su
strutture intervallari di quattro suoni (tetracordi), caratterizzate dalla
posizione del semitono (secondo l’impostazione tipica della modalità).
Il principio base del metodo guidoniano si basava sull’impiego di una
melodia di facile memorizzazione che permetteva di individuare con la voce
e con una sillaba corrispondente le altezze di una gamma di suoni. Fissare
nella mente il suono corrispondente ad una determinata nota, ad esempio il
suono di altezza F era impossibile, dato che non esisteva uno strumento ad
intonazione fissa che potesse fare da punto assoluto di riferimento. Come
fare, allora, per leggere o scrivere un brano sul tetragramma svincolando
la musica dalle parole che accompagnavano i canti? Guido si servì delle prime
sillabe dei sei emistichi di un inno largamente conosciuto, l’inno
a San Giovanni Ut queant laxis, che aveva una particolare caratteristica:
la nota corrispondente alla prima sillaba di ogni emistichio saliva di un
grado della scala, cominciando dal suono C, corrispondente alla sillaba ut,
per finire al suono A, corrispondente alla sillaba la. In questo modo era
possibile determinare una successione di altezze: bastava intonare la prima
sillaba di ogni verso dell’inno per avere una scala di sei suoni ut=C,
re=D, mi=E, fa=F, sol=G, la=A.
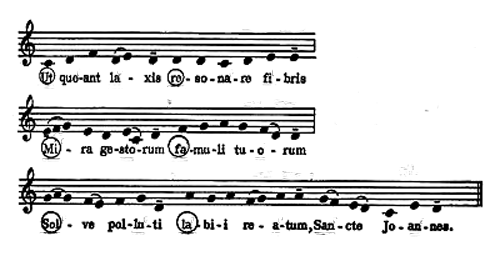
Si trattava, in sostanza, di una ‘scala’ di suoni utile ai cantori, che rispecchiava le esigenze di un repertorio modale monodico, basato sulla centralità di un solo semitono. Essa infatti fissava nelle sillabe mi-fa l’intervallo di semitono (S) mentre gli altri intervalli dell’esacordo sono intervalli di tono (T), secondo la successione:
ut -- re -- mi -- fa -- sol -- la
---T----T-----S----T-----T---
L’origine dei nomi dei sette suoni della nostra scala
musicale derivò da quest’inno. Nel corso del rinascimento al nome ut
fu sostituito il nome do (ma nella lingua francese è rimasto ut), e
infine fu introdotto il si, prendendo la sillaba dalle iniziali di Sancte
Iohanne dalle parole conclusive dell’inno. La necessità di aggiungere
la nota si dipese dall’evoluzione della prassi musicale, che si volgeva
verso la sensibilità armonica tonale, fondata sulla scala
diatonica provvista di due semitoni.
Nel corso del Due e Trecento, gli sviluppi della polifonia resero necessario
modificare l’aspetto dei neumi in base al valore ritmico loro attribuito
(si veda ritmo). Con questo passaggio, il sistema
di notazione era infine precisato tanto in relazione all’altezza quanto
alla durata di ciascun suono. Con pochi adattamenti è quello tuttora
impiegato.
Le alterazioni o accidenti
Le note do, re, mi, fa, sol, la, si non esauriscono tutte le possibili altezze
della gamma dei suoni impiegata nella musica di tradizione occidentale. Infatti,
come specificato sopra, solo due note consecutive della serie, cioè
mi-fa e si-do, sono a distanza di un semitono,
mentre le altre sono a distanza di tono, che
nel moderno sistema musicale temperato corrisponde a 2
semitoni (v. intervallo).
Per consentire l’impiego di queste altezze intermedie sia temporaneo
(nelle note di passaggio delle melodie e in funzione ornamentale) sia strutturale
(cioè nelle definizioni delle scale e delle tonalità del sistema
tonale) è invalso l’uso di impiegare due simboli specifici: il
diesis (#) che indica
l’innalzamento di un semitono e il bemolle
(b) che indica l’abbassamento di 1 semitono
della nota che segue in partitura. Infine, il bequadro annulla l’alterazione
precedentemente segnalata. La prassi musicale impiega dunque un totale di
sei alterazioni:
Il segno b del bemolle ed il suo nome derivano dalla notazione alfabetica, in cui la lettera B, che indica il suono si, se abbassata in senso discendente era scritta arrotondata (molle), mentre era squadrata, da cui il nome bequadro, se era intesa nella sua posizione naturale. Il diesis deriva invece, per quanto riguarda il nome, da un particolare intervallo di semitono teorizzato e impiegato nella musica greca antica, mentre per quanto attiene alla funzione deriva dalla prassi di alterare in senso ascendente note di abbellimento e/o funzionali alle cadenze nella musica tardo medievale e rinascimentale. (CP)