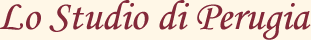|
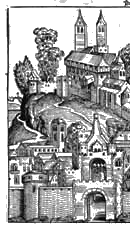 Nello Studio delle origini, pur dominato dai giuristi, grandi personalità illustrarono anche gli insegnamenti
di medicina: primo fra tutti, ma non isolato, Gentile da Foligno († 1348). Nel Quattrocento e nel Cinquecento
la scuola medica ha certamente un profilo più modesto; e tuttavia l'ambiente dei medici perugini, meno studiato
finora rispetto a quello dei maestri di diritto, offre numerosi spunti di interesse storiografico: nel Quattrocento
occupano le cattedre dello Studio personaggi che all'impegno didattico e scientifico uniscono un'intensa attività
professionale, al servizio delle città e delle corti oltre che per la clientela privata (anche per questo le loro
carriere sono spesso segnate da una grande mobilità). Specialmente dalla metà del secolo si accentua l'apertura
della medicina agli interessi letterari propri della nuova nuova cultura umanistica. Medici e umanisti sono, nel
Quattrocento, Nicolò Rainaldi e Mattiolo Mattioli; nella prima metà del Cinquecento, Lucalberto Podiani, docente
nello Studio, attivo al servizio della città come medico e insieme come cancelliere e ambasciatore, si guadagnò per
la vastità della cultura gli appellativi di maximus orator, summus logicus, maximus philosophus et
excellentissimus medicus.
Nello Studio delle origini, pur dominato dai giuristi, grandi personalità illustrarono anche gli insegnamenti
di medicina: primo fra tutti, ma non isolato, Gentile da Foligno († 1348). Nel Quattrocento e nel Cinquecento
la scuola medica ha certamente un profilo più modesto; e tuttavia l'ambiente dei medici perugini, meno studiato
finora rispetto a quello dei maestri di diritto, offre numerosi spunti di interesse storiografico: nel Quattrocento
occupano le cattedre dello Studio personaggi che all'impegno didattico e scientifico uniscono un'intensa attività
professionale, al servizio delle città e delle corti oltre che per la clientela privata (anche per questo le loro
carriere sono spesso segnate da una grande mobilità). Specialmente dalla metà del secolo si accentua l'apertura
della medicina agli interessi letterari propri della nuova nuova cultura umanistica. Medici e umanisti sono, nel
Quattrocento, Nicolò Rainaldi e Mattiolo Mattioli; nella prima metà del Cinquecento, Lucalberto Podiani, docente
nello Studio, attivo al servizio della città come medico e insieme come cancelliere e ambasciatore, si guadagnò per
la vastità della cultura gli appellativi di maximus orator, summus logicus, maximus philosophus et
excellentissimus medicus.
|
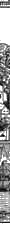
|
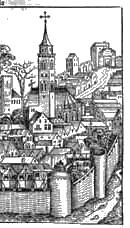 Nel complesso, il Cinquecento rappresenta nello Studio perugino un periodo di crisi per l'insegnamento della
medicina, che solo episodicamente mostra segni di rinnovamento: nell'emergere di un interesse per gli studi
naturalistici e botanici (che si manifesta anche nell'stituzione di una cattedra dei semplici), e soprattutto, tra
la fine del secolo e l'inizio del Seicento, nell'introduzione dell'anatomia.
Nel complesso, il Cinquecento rappresenta nello Studio perugino un periodo di crisi per l'insegnamento della
medicina, che solo episodicamente mostra segni di rinnovamento: nell'emergere di un interesse per gli studi
naturalistici e botanici (che si manifesta anche nell'stituzione di una cattedra dei semplici), e soprattutto, tra
la fine del secolo e l'inizio del Seicento, nell'introduzione dell'anatomia.
La teologia fa istituzionalmente la sua comparsa nello Studio perugino dalla fine del Trecento, ma di fatto
l'insegnamento continua per lungo tempo ad essere impartito nelle scuole degli Ordini. Solo nel Cinquecento
si può parlare per l'Ateneo perugino di cattedre stabili di teologia. Affidata sempre a docenti provenienti
dal clero regolare, la teologia universitaria conosce da questo momento una rapida e significativa
affermazione: gli stessi insegnamenti filosofici (nell'ambito dei quali, prima, la teologia era saltuariamente
insegnata) tendono sempre più ad essere condizionati dalle tendenze monopolistiche dei teologi che, a partire
dalla riforma cattolica, incominceranno addirittura a contestare ai loro colleghi della Facoltà di Arti il
diritto di laureare in filosofia.
|