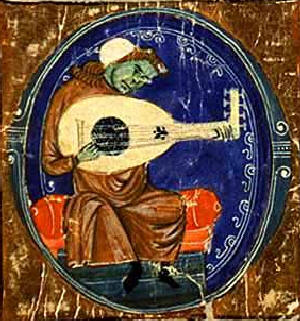|
Che cos'è TraLiRO
Il progetto TraLiRO
(Repertorio ipertestuale della tradizione lirica romanza
delle Origini) intende
realizzare un repertorio on-line dedicato alla
tradizione manoscritta dei testi lirici medievali nelle
diverse aree romanze. Rispetto alle recenti molteplici
iniziative di catalogazione on-line del materiale
testuale relativo alla tradizione lirica medievale,
TraLiRO si propone come momento di sintesi, a
coronamento e rilancio della lunga stagione della
«filologia dei canzonieri», che risale fino agli
incunaboli degli studi romanzi. L'obiettivo è quello di
collocare gli antichi testimoni di testi lirici nella
tradizione testuale, costituendo una rete integrata che
comprende le principali aree linguistiche e tradizioni
testuali romanze.
L'estensione della ricerca
dall'ambito italiano alle principali aree del dominio
romanzo permetterà di ampliare la prospettiva di analisi
e di misurare in senso diacronico lo sviluppo di un
fenomeno culturale di amplissima portata e d'influenza
duratura. Tale impostazione della ricerca consentirà
inoltre di mettere in luce l'importanza della tradizione
italiana nel contesto europeo per la produzione e
diffusione dei testi lirici: per limitarsi ad alcuni
esempi, va ricordato che per l'area provenzale molti dei
testimoni furono copiati in Italia; che buona parte
dell'esigua tradizione galego-portoghese residua si deve
ad un filone di diffusione che emerge soltanto
nell'officina di un umanista come l'italiano Angelo
Colocci; che una costellazione importante di manoscritti
della lirica castigliana ebbe la sua genesi presso la
corte napoletano-aragonese di Alfonso il Magnanimo.
Dal punto di vista
dell'estensione cronologica del dominio della ricerca,
si concentrerà l'attenzione sulla fase iniziale dello
sviluppo della lirica in ciascuna delle aree
considerate, caratterizzando il processo di
trasferimento dei modelli lirici tra le aree
linguistiche, dando significato e valore alla sfasatura
cronologica che sussiste fra le origini delle varie
tradizioni liriche.
Lo studio comparato della
lirica romanza del medioevo, del resto, vanta una ricca
tradizione di studi, che anche di recente ha prodotto
risultati di rilievo. Oltre alle singole tradizioni di
studi concernenti le fasi antiche della produzione
lirica di ciascun dominio linguistico, possono essere
considerati un punto di partenza per definire lo stato
dell'arte due recenti convegni (La lirica romanza del
Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni, Atti del
VI convegno triennale della Società Italiana di
Filologia Romanza, Padova-Stra, 27 settembre - 1 ottobre
2006, a cura di F. Brugnolo e F. Gambino, Padova,
Unipress, 2009; La tradizione della lirica romanza nel
medioevo romanzo. Problemi di filologia formale. Atti
del Convegno internazionale, Firenze-Siena, 12-14
novembre 2009, a cura di L. Leonardi, Firenze, Edizioni
del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2011).
Soprattutto il secondo, ispirato a una esplicita
riflessione metodologica di ambito filologico, ha
sollevato una serie di questioni di rilevanza generale
che fungeranno da stimolo e momento di riflessione
costante nello svolgimento delle attività del progetto,
a cui partecipano, fra l'altro, non pochi dei relatori
di quel convegno.
Le unità
di ricerca
Il progetto si articola in
quattro unità di ricerca che coinvolgono specialisti per
le principali aree romanze: Università di Siena
(Alessio Decaria, Coordinatore scientifico del
progetto), Università di Milano (Simone Marcenaro),
Università della Calabria (Fabrizio Costantini),
Università La Sapienza di Roma (Isabella
Tomassetti).
L'unità capofila (Siena),
sotto la responsabilità del Coordinatore, è dedicata
specialmente all'area italiana, quella più ricca in
termini di testi e di manoscritti considerati nel
repertorio. Ad essa si affiancano altre tre unità che
affronteranno le altre aree linguistiche. Della stagione
fondativa della lirica romanza, che si sviluppò in area
occitanica, si occuperanno due unità di ricerca (Cosenza
e Milano) [? solo Cosenza, mi pare di ricordare, oppure
specificare meglio], mentre il dominio francese sarà
oggetto di studio dell'unità di Milano salvo che per il
caso specifico dei testi in versi citati nei romanzi in
prosa di argomento arturiano e tristaniano, appannaggio
dell'unità di Siena. Per questo peculiare ambito, si
limiterà l'indagine ai cicli arturiani in prosa, e in
particolar modo al
Tristan
en prose e al Guiron le Courtois
(ca. 1230 - ca. 1250), le cui attestazioni si
distribuiscono tra Francia e Italia lungo un periodo di
circa tre secoli, dalla metà del sec. XIII agli anni '30
del sec. XVI (anche in questo caso si prenderà in
considerazione soprattutto la tradizione più antica).
Le altre due aree incluse
nel progetto sono quella galego-portoghese (Milano) e
quella castigliana (Roma), che permetteranno di
arricchire il quadro tramite l'analisi di tradizioni
caratterizzate, l'una, da un numero particolarmente
ristretto di testimoni (la gallego-portoghese), l'altra,
da una tipologia di trasmissione del tutto singolare per
lo sviluppo cronologico più tardo e per la presenza di
una rilevante tradizione a stampa.
Il
repertorio
Il risultato principale
del progetto consisterà nella compilazione di un
repertorio, nella forma di un database di tipo
relazionale, che incroci elaborazioni di dati relativi
ad autori, testi e manoscritti al fine di ricostruire la
specificità dei modelli che determinarono la prima
grande stagione della poesia lirica in volgare e il suo
significato per lo sviluppo della poesia nell'Europa
moderna.
Verranno pertanto
analizzate, autore per autore, le caratteristiche
peculiari della trasmissione manoscritta, offrendo i
dati necessari alla sua conoscenza e affrontando anche
alcuni aspetti trascurati nella bibliografia critica
esistente. Saranno oggetto di particolare attenzione le
questioni relative al canone e all'ordinamento dei
testi, la definizione delle linee principali della
morfologia della diffusione dei testi, i problemi di
stratificazione redazionale e di perturbazione della
tradizione. La redazione del repertorio costituirà,
insomma, la sede più indicata per tentare di risolvere
alcune questioni ancora aperte e oggetto di discussione.
Per il corpus testuale
relativo a ciascuno degli autori presi in esame si
fornirà inoltre la lista completa delle testimonianze
manoscritte e si procederà a uno spoglio sistematico
delle edizioni di testi lirici e degli studi filologici
pertinenti, al fine di costituire una bibliografia
ragionata, in cui ogni voce sarà dotata di abstract.
Il gruppo di ricerca del
progetto TraLiRO vuole insomma costituire uno strumento
di ricerca analogo a quelli già esistenti per l'analisi
della tradizione manoscritta di testi di altri ambiti
letterari, in particolare la serie
Te.Tra.
La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval
Latin Texts and their Transmission, a cura di P.
Chiesa e L. Castaldi, pubblicata dalla SISMEL a partire
dal 2004 e a sua volta modellata sull'esempio di
Texts and Transmission: a Survey of the Latin Classics,
a cura di L. D. Reynolds (Oxford, Clarendon Press,
1983), relativo alla tradizione dei testi latini
classici.
Altre
ricerche puntuali
A integrazione
dell'attività volta alla compilazione del repertorio si
prevede di intraprendere alcune ricerche puntuali su
aspetti particolari di singoli autori, testi o settori
delle varie tradizioni oggetto di studio.
Lo stadio bibliografico o
editoriale particolarmente carente o lacunoso
costringerà in qualche caso, ad intraprendere
un'ulteriore campagna di ricerche, i cui risultati si
concretizzeranno in saggi filologici e in edizioni
critiche (almeno alcuni di questi materiali saranno resi
accessibili su questo sito). Tra i settori privilegiati
di queste indagini ancora vergini si possono già
indicare, per l'area italiana, la tradizione delle rime
di Cino da Pistoia, quella di alcuni epigoni dello
stilnovismo (Tommaso de' Bardi, Ventura Monachi,
Riccardo degli Albizzi, Matteo Frescobaldi), l'intero
genere della frottola, particolarmente trascurato negli
studi sulla lirica trecentesca.
Per quanto concerne
l'ambito francese e franco-italiano, l'analisi dei testi
in versi presenti nella tradizione arturiana in prosa, a
partire dai manoscritti del Tristan en prose e del ciclo
di Guiron le Courtois, imporrà innanzitutto un capillare
censimento delle attestazioni manoscritte, finora
rilevate in maniera assai rapsodica (dalla fondamentale
panoramica di Eilert Löseth sulla tradizione dei due
cicli, e poi con i lavori di Eugène Vinaver e Emmanuèle
Baumgartner sul Tristan e di Roger Lathuillère sul
Guiron).
Resta quasi integralmente
da indagare il Guiron, complessivamente inedito e finora
esplorato, quanto alle inserzioni in versi, solo in modo
assai parziale. Conosciamo senz'altro meglio la parte
tristaniana del corpus, che è stata oggetto di almeno
tre importanti interventi: due edizioni complessive del
romanzo (secondo le versioni note come V.I e V.II)
dirette da Philippe Ménard ed un'edizione consacrata
alle inserzioni liriche nella prosa, ad opera di Tatiana
Fotitch (che prescinde però da uno studio della
tradizione). Inoltre il Tristan si è offerto
all'attenzione dei musicologi (Ruth Steiner, in
particolare) per il fatto di tramandare, in alcuni
testimoni, la melodia insieme ai testi, e in altri le
righe lasciate in bianco per la portata musicale. Si
tratterà, in questo caso, di riunire le varie
rilevazioni e integrarle con la dovuta sistematicità, e
soprattutto cercare di definire meglio la geografia di
queste tradizioni, che dalla Francia si estende a tutta
l'Italia.
Per quanto riguarda,
invece, la lirica dei trovieri, la compilazione del
repertorio costituirà occasione propizia per sottoporre
alla verifica dei dati propriamente testuali il sistema
generale della trasmissione manoscritta della poesia
oitanica delineato ormai ben oltre un secolo fa da
Eduard Schwan sulla base di criteri di matrice
inevitabilmente gröberiana. La superficialità
dell’indagine ecdotica che caratterizza le edizioni
critiche di molti trovieri renderà necessaria la
riconsiderazione complessiva delle singole situazioni
testuali, operazione da condursi nella maggior parte dei
casi analizzando
ex novo la recensio:
lo studio al quale si sottoporrà la tradizione degli
autori inclusi nel repertorio permetterà così di
individuare episodi meritevoli di ulteriore
approfondimento per via delle loro peculiarità nel
contesto delle dinamiche manoscritte trovieriche, oltre
che di reinterpretare singoli problemi testuali ed
esegetici alla luce del dato ecdotico.
Relativamente all’area
galego-portoghese l’analisi complessiva della tradizione
manoscritta porterà ad approfondire elementi fino ad
oggi trascurati dagli specialisti, come il ruolo delle
note marginali nel canzoniere più antico posseduto, il
‘Cancioneiro da Ajuda’, che potranno permettere di
dedurre le sue fonti e, in certi casi, di collazionare
le lezioni alternative con il ramo ‘italiano’ della
tradizione (canzonieri B, V). Un secondo punto
essenziale sarà la pubblicazione del corpus poetico di
autori che ad oggi non hanno ancora beneficiato di
edizioni critiche soddisfacenti; due primi frutti della
ricerca sono in procinto di apparire (Pero
Garcia Burgalés, Canzoniere – Canzoni d’amore,
d’amico e di scherno, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2012; Osoiro Anes, Cantigas,
Roma, Carocci, 2012)
e si prevede, nel corso dei tre anni, di pubblicare le
‘cantigas’ di altri autori quali Afonso Mendez de
Besteiros, Estevan Faian e Afons’Eanes do Coton.
Per l'area trobadorica,
l'analisi repertoriale consentirà la prospezione e lo
studio comparatistico di aspetti ecdotici non secondari,
come per esempio le strategie di razionalizzazione
stemmatica nelle edizioni critiche dei principali autori
o il vaglio degli apparati (fino alla verifica sui
testimoni), mirando a coniugare il dato linguistico, e
in special modo lessicale, con quello squisitamente
ecdotico; allo stesso tempo, sono previsti anche
approfondimenti calibrati su specifici testi o
corpora
di autori, con nuove proposte editoriali per loci
critici o,
quando necessario, con l'allestimento di edizioni
integrali: in tale prospettiva si pongono i già avviati
cantieri di ricerca su autori quali Alegret, Marcoat (R.
Viel) o Elias de Barjols (G. Barachini).
Per quel che riguarda il
settore castigliano, l’allestimento del repertorio
propozierà lo sviluppo di alcune ricerche che potranno
essere approfondite negli anni successivi. Tali studi
riguarderanno innanzitutto il materiale linguistico
offerto dai canzonieri esaminati, il cui esame si
profila di estrema importanza nell’ottica di uno studio
della lirica castigliana delle origini; un altro aspetto
che si intende approfondire è quello
dell’intertestualità metrica fra i poeti delle
generazioni esaminate, fenomeno particolarmente diffuso
in questo ambito lirico ma che sinora è stato
sorprendentemente trascurato dalla critica.
L’allestimento repertoriale, infine, favorirà anche la
preparazione di edizioni critiche ancora non
disponibili: sono in programma, per il momento, le
edizioni di Fray Diego de Valencia, Arcediano de Toro e
Pero González de Mendoza.
|
|