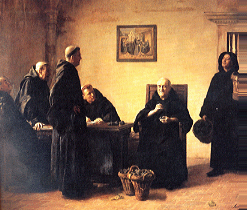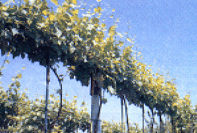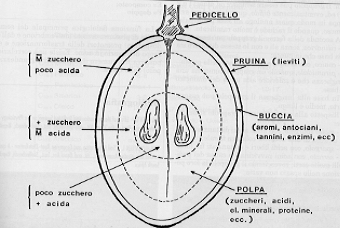Il presente: l’Enogastronomia.
Dom Pérignon.
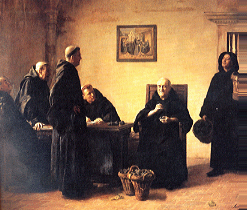
Tra tutti i grandi vini del mondo ce n’è uno buonissimo e preziosissimo,
si chiama Champagne, e l’uomo a cui si attribuisce il merito di averlo
inventato era un monaco benedettino. Dom Pierre Pérignon, tesoriere
dell’abbazia di Hautviller, ascetico e pignolo, guardava le colline dell’abbazia
ammantate di viti. Hautvillers fu fondata nel 650 nello spirito di Colombano,
era un luogo di preghiera e di lavoro per instancabili asceti, la santità
del luogo era assicurata dal possesso dei resti di S.Elena madre dell’Imperatore
Costantino. Perignon divenne col tempo un santo protettore dello champagne.
Nel 1668 quando aveva 29 anni, lo champagne della zona era avvilito da
guerre e carestie, Perignon decise di potenziare la produzione vinicola,
nel 1661 l’abate ordinò la costruzione di una nuova grande cantina
a volte, hautvillers possedeva solo una decina di ettari di vigne ma riceveva
decime pagate in natura cioè con pinot, dai villaggi confinanti.
Le uve erano nere. Le regole auree della vinificazione stabilite ai tempi
di Dom Perignon probabilmente da lui stesso, vennero esposte nel 1718 tre
anni dopo la sua morte. Primo usare solo pinot noir, i vigneti della regione
contenevano anche pinot meunier, pinot gris (o fromenteau) pint blanc (o
morillon) chasselas e forse chardonnay. Dom Perignon era contrario all’uva
bianca in parte perché incoraggia una tendenza latente del vino
a rifermentare. Secondo potare a fondo le viti in modo che non superino
mai il metro di altezza e producano poca uva. Terzo vendemmiare con ogni
precauzione in modo che gli acini restino intatti, attaccati ai raspi,
e il più freddi possibile. Lavorare al mattino presto, Scegliere
i giorni di temporale quando fa caldo, scartare tutti gli acini rotti o
anche solo ammaccati. Gli acini piccoli sono migliori di quelli grossi,
Stendere delle stuoie di vimini sull’aia e controllare il raccolto, eliminando
gli acini guasti, le foglie e tutto ciò che è indesiderabile.
Stendere un telo bagnato sull’uva per proteggerla dal sole. L’uva deve
rimanere fresca a tutti i costi. Se possibile lavorare vicino al torchio,
in modo da potervi portare l’uva a mano, ma se si può evitare di
usare animali, scegliere se mai i muli, perché sono meno eccitabili
dei cavalli. In mancanza di muli usare gli asini. Quarto non pigiare l’uva
con i piedi per nessuna ragione e non permettere nessuan macerazione delle
vinacce nel mosto, Usare un torchio efficiente e veloce, (perciò
i contadini non avrebbero mai potuto fare questo tipo di vino), usareil
torchio ripetutamente per tempi brevi, tenendo i mosti separate delle diverse
spremiture. Il primo vino che scaturisce dalla pressa cioè il vin
de goutte, viene spremuto dal solo peso della trave di legno. Il suo vino
è troppo delicato per essere bevuto da solo: gli manca il corpo.
Il secondo e terzo chiamato primo e secondo taille, perché la massa
di uva deve essere tagliata a pezzi e rimessa nel torchio, danno mosti
di buona qualità, Il quarto, o vin de taille, è raramente
accetabile, e tutti i tagli successivi sono vins de pressoir, ma ormai
sono decisamente colorati e quindi privi di interesse per il cantiniere
professionista. Dom Perignon sapeva sapientemente accostare le uve migliori,
provenienti da vigneti diversi. L’esperienza dimostrò che più
il vino era leggero e tendente al verde, più diventava frizzante
in primavera. Il vino di uva bianca era frizzante: questo era uno dei motivi
per cui Perignon usava soltanto uve nere, ed il vino di uva nera era anche
più durevole e si poteva maturare e mantenere anche per molti anni.
Quando Dom Perignon aveva circa sessanta anni, la preferenza del pubblico
si orientava verso quei vini frizzanti che egli aveva tutta la vita cercare
di evitare, i produttori esagerarono con le uve bianche ed acerbe che conferivano
al vino maggiore frizzantezza. Bertin de Rocheret, commerciante di champagne,
defini uno di questi vini “verde e rozzo come un cane, secco come il diavolo”.
Comunque la cantina era un fattore importante, specialmente con i vini
frizzanti. Una cantina profonda con temperature costanti poteva essere
il fattore decisivo per evitare che le bottiglie esplodessero. Dom Perignon
sapeva che sotto la città di Reims esistevano enormi caverne scavate
dai romani per ottenere pietra da costruzione. Nel 1716 compare Claude
Moet, un produttore di Epernay, ora la produzione dello champagne era diventata
complicata, e richiedeva capitali per comprare il vino e per l’imbottigliamento.

Louis Pasteur
I dispiaceri
Intorno al 1862 Louis Pasteur fu convocato dal Re di Francia Luigi
Napoleone. Molte bottiglie di champagne e vino francese che tra l’altro
erano esportate numerose, dopo un certo periodo si guastavano e diventavano
aceto. Pasteur si rese conto che la fermentazione era attuata da organismi
e lieviti che si riproducevano casualmente. La vera ragione era dovuta
al propagarsi dell’oidio. Le viti indebolite dalla malattia producevano
vino soggetto ad ammalarsi. L’equilibrio dei vini si alterò: nulla
da questo momento sarà come prima. I batteri che si propagavano
numerosi potevano essere inibiti solo dalla mancanza di ossigeno, Pasteur
con il microscopio ottico ed i suoi vetrini dimostrò che un vino
chiuso ermeticamente con il suo tappo di sughero, immesso in un bagnomaria
caldo per un tempo sufficiente ad uccidere i batteri, rimaneva inalterato.
L’operazione si sarebbe chiamata pastorizzazione, e poteva essere applicata
anche ad altre sostanze come latte, conserve e marmellate. I risultati
ottenuti da Pasteur fecero di lui un eroe nazionale della Francia.
Dopo circa un anno, apparve un altro nemico della vite, pericolosissimo
e temibile, era la fillossera, dopo di questa arrivò la peronospora.
Questi parassiti non si limitarono a devastare quasi tutti i vigneti d’Europa,
ma causarono cambiamenti radicali nei metodi di coltivazione della vite.
Da questo momento il vino perse la sua “innocenza”, era finita definitivamente
l’età dell’oro.
L’oidio è un fungo parassita, che attaccava all’inizio dell’estate
i grappoli d’uva, e li rendeva inservibili per la produzione vinicola,
dalla Francia dal 1851 la malattia gradatamente si spostò in Italia,
causando una forte caduta della produzione, la malattia si rilevava attraverso
una polvere bianca, che si addensava sul chicco delle uve, e poteva colpire
anche altre piante da frutto. In alcune località italiane attraversate
dalle prime linee ferroviarie, i contadini credevano che la malattia fosse
causata dai fumi delle locomotive. Dopo lunghi tentativi finalmente in
Toscana l’accademia dei Georgofili prese in mano la situazione, i rimedi
proposti da studiosi ed appassionati erano vari, si andava dall’uso della
calce, a quello della cenere, dal sapone sciolto nell’acqua ad altri miscugli
stravaganti, ma la situazione stava precipitando. Fortunatamente l’uso
della polvere dello zolfo si rivelò positiva, naturalmente non mancavano
timori relativi all’alterazione dei gusti. In Toscana il consumo medio
giornaliero di vino era molto elevato; ogni toscano bevevo circa un terzo
di fiasco, circa mezzo litro. Sempre in Toscana ci fu Bettino Ricasoli
che stava meditando di abbandonare Brolio per acquistare nella Maremma
toscana terreni da grande coltura. Comunque fin dal 1855 fu visto
che il metodo della zolfatara era il mezzo per sconfiggere definitivamente
l’oidio delle viti.

Le piccolissime dimensioni della fillossera ed il complesso ciclo vitale.
La Fillossera, è un parassita praticamente invisibile
all’occhio umano, coltivatori viticoli americani non riuscivano nell’intento
di propagare le viti importate dal vecchio continente, era una malattia
endemica delle Americhe. Intorno al 1850 le nove velocissime navi a vapore,
utilizzate per le traversate atlantiche abbatterono la durata dei tempi
di navigazione, bastavano nove giorni ad una nave che partiva da new York
per arrivare in Francia e portare il parassita della fillossera vivo. Da
un piccolo numero di insetti importati si formò ben presto una popolazione
ragguardevole. Le foglie delle viti ammalate si avvizzivano e cadevano,
le nuove radici che la pianta emetteva erano prive di vigore, i frutti
rimanevano acerbi, tre anni dopo i primi sintomi la pianta moriva. L’aspetto
più appariscente della vite morta, quando viene sradicata per essere
esaminata, è il fatto che il suo apparato radicale è praticamente
morto e scomparso. Le radici delle viti ammalate e sradicate sembravano
una massa brulicante di piccolissimi afidi, grandi quanto una punta di
spillo e talmante numerosi che le radici sembravano dipinte di giallo.
L’insetto aveva anche una forma alata, è un altro afide con ali
piatte e trasparenti, per il grande numero di parassiti che colpivano contemporaneamente
la vite il parassita fu chiamata dal botanico francese Jules-Emile
Planchon, Philloxera vastatrix. I danni provocati da questo afide
sono differenti in base alla specie di vite colpita: sulle viti europee
(Vitis vinifera, Vitis silvestris) la fillossera provoca danni limitati
al solo apparato radicale e non sulla chioma (anche se ultimamente sono
stati riscontrati numerosi casi di danni fogliari anche su viti europee);
sulle viti americane (Vitis rupestris, Vitis berlandieri, Vitis riparia)
provoca danni limitati all'apparato aereo e non sulle radici. Sulle radici
si formano tuberosità e nodosità in seguito alle punture
effettuate dall'insetto. In questo modo viene compromessa la normale funzionalità
dell'apparato radicale, che va incontro a disfacimento. Inoltre l'afide
penetra all'interno della radice stessa dove produce sostanze ormonali
che rendono il tessuto più debole e facilmente attaccabile da funghi
e batteri, responsabili di infezioni letali (ad es. cancri). Sulle foglie
le punture della fillossera provocano la formazione, in prossimità
della pagina inferiore, di "galle" all'interno di ognuna delle quali sono
alloggiate in media 500 uova. Anche i piccioli fogliari, i viticci ed i
tralci erbacei vengono interessati dall'attacco dell'afide. La lotta alla
fillossera consiste essenzialmente nel ricercare le varietà americane
più adatte a fungere da portinnesto per quelle europee. Nella costituzione
di nuovi impianti, vengono cioè utilizzate piante innestate in cui
l'apparato radicale (portinnesto o piede), resistente alla fillossera,
viene fornito da specie americane; mentre la porzione epigea (varietà
innestata) appartiene a specie europee. Nelle zone, invece, dove ancora
vengono utilizzate viti non innestate, la lotta alla fillossera viene fatta
tramite alcuni importanti accorgimenti quali: impiantare su terreni sabbiosi,
che ostacolano la diffusione dell'afide; disinfestare il terreno prima
di un nuovo impianto. Alla fine dell’Ottocento la superficie italiana colpita
dalla fillossera ammontava a circa 300.000 ettari. In Italia la generale
ricostruzione della viticoltura pose il problema della scelta tra il sistema
a viti basse ed a sostegni secchi o delle viti alte alberate. In generale
la viticoltura nazionale, vide progredire la viticoltura specializzata.
Nella vigna specializzata tutti i lavori si effettuavano con maggiore
facilità e con meno dispendio di energie, e talvolta per i trattamenti
anticrittogamici poteva significare la salvezza del prodotto. All’espandersi
del parassita, vi fu comunque la necessità di salvare le viti europee
non innestare su vite americana, alcuni ricorsero a mezzi chimici. Il chimico
Paul Thenard ad esempio scoprì che una sostanza chiamata bisolfuro
ci carbonio, che si ottiene facendo passare vapori di zolfo su un letto
di carbone rovente, era estremamente tossica per la fillossera e per quasi
tutti gli esseri viventi. Iniettata nel suolo alla base delle viti, eliminava
qualsiasi segno di vita. Nei primi esperimenti Thenard usò dosi
troppo massicce uccidendo anche le viti, inoltre i fumi provocavano malesseri
agli operai. La routine della viticoltura era a questo punto diventata
irriconoscibile, da una operazione abbastanza semplice, consistente nel
potare, dissodare, strappare le erbacce, rimpiantare le viti ogni
tanto, ed alla fine della stagione vendemmiare, la viticoltura si era trasformata
in una serie infinita di applicazioni di sostanze chimiche e maleodoranti.
Le tecniche di propagginazione fu abbandonato, a tal proposito alcuni vigneti
antichissimi di Pinot noir nella Champagne, appartenenti alla ditta Bollinger,
inspiegabilmente sopravvissuti alla fillossera ancora oggi propagati per
propagginazione, hanno una certa qualità e profondità di
sapore che li distingue dagli altri.
Le enormi importazioni di viti americane, aveva portato con se dal
nuovo continente una nuova e vorace crittogama, la peronospora.
La peronospora. Come l’oidio, la peronospora riduceva notevolmente
i raccolti ed indeboliva il vino che se ne otteneva. In soli quattro anni,
la facoltà di scienze di Bordeaux trovò il modo di prevenirla
con la famosa “poltiglia bordolese”, una combinazione di calce e solfato
di rame in forma liquida. Nonostante ciò l’ultimo decennio dell’Ottocento
fu contraddistinto da interi raccolti rovinati. Per i disonesti si aprivano
ottime opportunità, mentre vini che prima erano considerati adatti
esclusivamente per l’aceto, o per la distillazione, ora trovavano ottimo
mercato. Oltre a annacquare il vino, alcuni facevano vino con l’uva passa,
importata soprattutto dalla Grecia e dalla Turchia. Un libro pubblicato
a Marsiglia era semplicemente intitolato: “Come fare il vino con l’uva
passa”, in sei anni ne furono pubblicati dodici edizioni. Ecco la ricetta:
prendete cento chili di uva passa tritata, aggiungete 300 litri di acqua
riscaldata a trenta gradi centigradi, lasciate fermentare per dodici giorni.
Spremete e avrete trecento litri di vino a dieci o undici gradi.
Fin dagli inizi del Novecento in Italia già si parlava dell’esigenza
di proteggere i vini tipici, vini dalle qualità superiori, In Francia
dal 1905 si era parlato di Appellation d’origine controlée, in Italia
nel 1902 il sindacato vinicolo Piemontese che comprendeva Camera di Commercio,
Comuni, Enti Morali, Province, associazioni ed istituti agrari aveva messo
tra i sui scopi quello di tutelare il commercio dei vini pregiati del Piemonte.
Nello stesso periodo in Toscana per opera dei Comizi agrari di Siena e
Firenze, si era tentato di dare vita ad una associazione Chiantigiana,
di produttori di vino chianti.
Il vino italiano ottocentesco.
Il vino per l’Italia occupa una posizione primaria, I greci chiamavano
la penisola Terra del vino. Fu lo stesso Garibaldi a convincere gli agricoltori
italiani a combattere l’oidio con o zolfo. Gli italiani del 1800 coltivavano
la maggior parte delle viti come aveva descritto Plinio. Crescevano in
altezza con sostegni vivi, la felicità del contadino ottocentesco
era quella di sedersi a riposare con moglie e figli all’ombra della propria
vigna, con i grappoli maturi a portata di mano. Goethe nei lunghi peregrinagli
italiani aveva descritto i paesaggi fertili italiani, e la compassione
verso i contadini italiani, essi diceva “sono completamente alla mercé
dei mercanti, che negli anni cattivi prestavano loro il denaro per tirare
avanti, ma poi negli anni buoni comprano il loro vino a prezzi ridicoli”.
Nel XIV° secolo, Venezia era stata uno dei centri del commercio dei
vini, il rinascimento aveva visto il vino in fiaschi toscano esportato
in tutta Europa, nel XVIII° secolo il vino italiano apprezzato era
il lacrima cristi del Vesuvio. I vini italiani si dividevano in due categorie:
quelli delle alberate con sostegni vivi, e quelli delle viti sostenute
da pali, che già duemila anni prima indicavano le zone di influenza
greca. Erano quest’ultimi pochi vini che gli stranieri ricercavano, erano
dolci e molto alcolici, di tradizione greca. Anche la robusta vernaccia
Toscana era molto ricercata. Famiglie toscane come degli Antinori
o i banchieri Frescobaldi, commerciavano ed esportavano normalmente anche
vino. Vi sono anche fonti che riportano pareri di inglesi; secondo sir
Edward Barry, un tempo il vino toscano era molto apprezzato in Inghilterra,
ma quello della seconda metà dell’Ottocento aveva perso tutto il
suo sapore, e carattere, i fiaschi fiorentini erano importati, ma raramente
erano bevuti, erano invece usati per fare Borgogna artificiale, o per dare
più leggerezza a un porto pesante. L’Italia aveva migliaia di vini
locali, ma raramente il vino era fatto con cura e perizia. I due stati
che seguivano scrupolosamente dei metodi di coltura codificati era il Granducato
di Toscana e il Regno di Sardegna. I primi tentativi di riforma si ebbero
ad opera di Pietro Leopoldo, che era un discendente degli Asburgo, ed un
degno successore della stirpe medicea. In toscana vigeva il sistema mezzadrile,
ed anche se i proprietari avessero voluto cambiare il sistema, i contadini
lo avrebbero considerato come una manovra per privarli del loro antico
godimento della terra. Quando le guerre napoleoniche finirono, e la Toscana
tornò in mano agli Austriaci, il barone Bettino Ricasoli ereditò
la tenuta di Brolio, che allora era immersa nei debiti. I Ricasoli discendevano
direttamente dai baroni lombardi dell’undicesimo secolo. Quando il barone
si trasferì da Firenze alle sue trascurate terre di famiglia (secondo
alcuni per sottrarre la moglie alle tentazioni della società), la
riforma della sua proprietà e del suo vino divenne la grande passione
della sua vita. Altezzoso ed ascetico egli dedicò tutto se stesso
e sua moglie, figli, contadini e vino della regione, all’educazione e alla
riforma. Importò innumerevoli vitigni diversi, il chianti classico
emerse dai suoi esperimenti e all’ottimizzazione ed armonizzazione dei
vecchi vitigni. Ricasoli dichiarò che il chianti riceve buona parte
del suo bouquet dal sangioveto, dal canaiolo prende una dolcezza che ne
modera l’asprezza del sangioveto, la malvasia bianca tende ad accentuarne
il sapore, allo stesso tempo rendendo più fresco il vino e più
adatto all’uso quotidiano. Ricasoli non ammetteva il trebbiano, una varietà
leggermente aspra, neutra e molto amata dai produttori poiché molto
produttiva. Nel 1848 sua moglie morì e nel dolore perse ogni interesse
per le sue terre e per le riforme in atto. Egli aveva scoperto la nuova
vocazione politica, cosi nel 1850 dopo l’arrivo dell’oidio, i mezzadri
abbandonarono in massa le terre, si trasferirono in città o andarono
in America. Il Risorgimento culminò nel 1860, il viticoltore Ricasoli
che nel frattempo aveva incorporato circa trecento piccole fattorie abbandonate,
era diventato il dittatore della Toscana, ed era deciso ad unirsi con i
Cavour per unificare la toscana allo stato del Piemonte. In maggio Garibaldi
salpò da Genova, con le sue camice rosse alla volta della Sicilia,
per mettere fine al regno Borbonico. A giugno Garibaldi era padrone della
Sicilia e in settembre di Napoli. La metà meridionale dell’Italia
era unita al regno di Sardegna e la Toscana votò per l’unione seguendo
le direttive di Ricasoli. Cavour mori e Ricasoli divenne primo ministro
della nuova Italia. Il governo italiano alle prese con il problema dell’oidio,
e poi della fillossera, non tardò a creare degli Istituti per la
cura e la sperimentazone di nuove tecniche viticole.
Novecento.
L’esempio del nuovo mondo.
Le varie congiunture economiche, l’ultima guerra, il cambiamento del
gusto dei giovani e delle economie nazionali, hanno cambiato radicalmente
gli standard di vinificazione attuali, i principi di autenticità,
e perfino il nostro modo di gustare ed apprezzare il vino. In Italia, tra
le economie sommerse vi era anche quella del vino, che lo faceva circolare
del “contadino” ma che produceva anche ignobili intrugli fatti passare
sotto nomi rispettabili. Oltre a ciò vi erano i vigneti del nuovo
mondo, dall’Australia, California, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina;
arrivavano in Europa vini all’altezza dei migliori vini Europei. Negli
anni Trenta, in California usavano metodi estremamente primitivi, i primi
viticoltori trattavano il vino con metodi drastici, l’uva appena colta
veniva spruzzata con valanghe di zolfo, finché alla fine era completamente
candeggiata; quando un vino di fermentazione raggiungeva una temperatura
pericolosa, l’unico rimedio era quello di buttarci dentro grossi blocchi
di ghiaccio per raffreddarlo, e tutte queste operazioni erano fatte nella
massima segretezza. Ai primi del Novecento la Napa Valley aveva prodotto
vini che vincevano regolarmente premi in Europa, i vecchi vigneti di cabernet
che erano sopravvissuti all’invasione delle varietà ordinarie
producevano ancora dell’ottimo vino, ma negli anni trenta gli stessi americani
continuavano a disprezzare il proprio vino. Il segreto era nella temperatura
e la differenza tra i vigneti Europei e quelli del nuovo mondo era legata
al clima. Il famoso clima mediterraneo fresco e collinare è quello
che ci vuole per avere una naturale produzione di ottimo vino. In America
la scelta di vitigni adatti alle condizioni climatiche fu la grande impresa
del dipartimento di viticoltura ed enologia dell’università della
California, dove Albert Winkler enunciò il principio della “sommatoria
del calore”, consistente nel sommare le temperature medie di tutti i giorni
della stagione vegetativa in cui il termometro supera i dieci gradi centigradi.
A dieci gradi la vita è attiva, quindi la sommatoria del calore
esprime le ore di attività della pianta. Questa misura permette
di fare paragoni diretti fra i vigneti di tutto il mondo. Nella Napa Valley
i valori variano tra duemilatrecentoquaranta e duemilaseicentodieci, perciò
sarà il cabernet a crescere perfettamente in questa regione. Quste
previsioni diventavano difficilissime nelle catene costiere dove tutto
dipendeva dall’aria fresca dell’oceano. La rinascita vinicola della Napa
Valley venne nel 1966, ad opera dell’azienda Robert Mondavi. Il suo nuovo
impianto dai grandi cilindri in acciaio inossidabile con temperatura controllata
fino all’ultimo grado da camice di fluidi refrigeranti.

Erano investimenti notevole, e lanciavano ai grandi produttori la sfida
della tecnologia. I vitigni che si prestavano meglio alle nuove tecniche
di produzione era lo Chardonney, prodotto nei climi freschi francesi, che
divenne il vino preferito dalla nazione, per la prima volta nella storia
i californiani bevevano più vino che liquori. Gli americani che
avevano fatto la guerra in Europa rivolgevano ora il loro interesse al
vino. Sulla scia dei numerosi film di Holliwood, gli americani comunque
non bevevano vino, lo assaporavano con un certo senso snobistico, per loro
vi era un solo vino giusto, con la sua temperatura ed una sola osservazione
brillante da rivolgere all’impacciato sommelier.
Il dopoguerra: la risposta della Toscana.
Dopo la fine della guerra e della nuova ondata fillosserica il settore
vinicolo toscano era in ginocchio. L’incremento demografico, le riforme
agrarie e gli interventi di bonifica effettuati per incentivare la formazione
della piccola proprietà contadina, determinarono un sostanziale
mantenimento delle superfici coltivabile. Negli anni Cinquanta cominciarono
le prime lotte sindacali dei mezzadri, e prese avvio il processo che portò
ad un progressivo, inarrestabile abbandono da parte dei coloni dei prodotti
dei poderi. Non ebbero praticamente nessun effetto le agevolazioni creditizie
e fiscali e le norme sulla prelazione a favore dei coltivatori diretti
introdotte tra il 1965 ed il 1971 dal cosiddetto ‘lodo De Gasperi’. La
legge n°765 del 15.09.1064 proibì la stipula di nuovi contratti
mezzadrili e, il ‘lodo Restivo’ ne mitigò la rigidità e sancì
la fine della millenaria mezzadria. L'abbandono dei poderi da parte dei
mezzadri fu dovuto a profondi cambiamenti avvenuti nel tessuto sociale
della nostra regione, quali ad esempio lo sviluppo dell’industria e del
terziario, che offrivano opportunità convenienti all’attività
agricola. La spinta verso i centri urbani venne determinata anche dalle
possibilità offerte dall’istruzione, con la prospettiva possibile
di una elevazione sociale, economica e sociale. La famiglia contadina si
frazionò e con essa la tradizionale struttura patriarcale. Il nuovo
singolo nucleo doveva liberarsi dell’incertezza salariale, esigeva un profitto
fisso mensile per far fronte ai nuovi acquisti rateali di beni mobili utili
per la famiglia. Veniva inoltre considerato con attenzione anche il più
favorevole trattamento previdenziale offerto dal lavoro dipendente. Dal
1951 al 1971 il numero di attivi in agricoltura passò da una densità
di 27 a 6 unità per Kmq. Le operazione colturali ora erano supportate
dalla nuova meccanizzazione agricola, gli animali da lavoro furono utilizzati
esclusivamente per l’allevamento, mentre le piccole prese e terrazzamenti
di difficile transitabilità con i nuovi mezzi meccanici furono rinnovati
ed ampliati. La realtà di fine anni Cinquanta era caratterizzata
da una notevole dispersione e frammentazione fondiaria, che ostacolava
la costituzione di vigneti di superficie sufficientemente ampia per rendere
agevole ed economicamente conveniente l’impiego delle macchine e l’impiego
di moderne attrezzature di cantina. In più nei fondi condotti
a mezzadria mancava la cultura imprenditoriale, molti dei proprietari avevano
una scarsa preparazione ed erano privi di qualsiasi senso innovativo.

Nelle aree collinare toscane la viticoltura era realizzata con ciglionamenti
e terrazzamenti secondo la natura e la pendenza del terreno o la disponibilità
di pietrame. Tali sistemazioni le cui origini risalgono alla fine
del Settecento, costituivano ammirevoli opere di ingegneria agraria di
grande efficacia per la conservazione del territorio e la regimazione delle
acque superficiali e profonde, in più erano e sono elemento caratterizzante
del paesaggio collinare toscano. Richiedevano peraltro notevoli quantità
di lavoro manuale rese possibili esclusivamente dalla conduzione agricola
mezzadrile.

Generalmente le forme colturali adottate nei terrazzamenti del chianti
erano costituiti da filari di acero o testucchio, posti a due, tre
metri, che sostenevano i tralci della vite. Le varietà dei vitigni
era notevole: Malvasia nera, Canaiolo nero, Prugnolo gentile, Mammolo,
Morellino di scansano, Colorino, Foglia tonda, ciliegio, Mazzere, Trebbiano,
Malvasia, Canaiolo bianco, Greco, Vermentino bianco, Moscato bianco,
Vernaccia di San Gimignano. Vi erno inoltre numerose varietà locali
talvolta di origine molto antica, che erano state conservate e trasmesse
attraverso i tempi nei tradizionali poderi mezzadrili.
La produzione vinicola era divisa in due grandi fasce. Una era basata
da vini eterogenei, poco tipicizzati, destinati al consumo locale o diretto
del produttore, l’altro da vini tradizionalmente molto apprezzati nei mercati
interni ed esterni, quali il chianti, il vino nobile di Montapulciano,
il Brunello, la Vernaccia di San Gimignano.
La fillossera continuava ad infestare molte delle campagne toscane,
mentre il reimpianto di nuove vigne non era per i proprietari economicamente
vantaggiosa. Vi erano anche frodi, industrie vinicole anche con buone reputazioni
che tagliavano o manomettevano chimicamente il vino. Oltre a ciò
vi era da parte del governo una ingiustificata pressione fiscale e i giovani
stavano assaporando bevande diverse dal vino. Nel 1957 l’accademia dei
Georgofili di Firenze in occasione dei festeggiamenti del proprio bicentenario,
organizzò un convegno per discutere le cause della crisi della viticoltura.
Emerse che il degrado dei fabbricati colonici, le insufficienti vie di
comunicazione e dei servizi igienici, il basso livello di retribuzione
del lavoro agricolo, avevano causato lo spopolamento delle campagne toscane
ed una diminuzione della produzione di vino rispetto al 1900 del 50%.
Di fronte a questa crisi molti proprietari non seppero trovare efficienti
rimedi. La ripresa doveva arrivare intorno agli anni settanta, in alcune
zone del chianti pregevoli sotto l’aspetto paesaggistico, storico e culturale,
poderi ed intere fattorie vennero comprati da stranieri, attirati
dalla bellezza della natura. Questo passaggio delle antiche proprietà
fondiarie ad una categoria di persone caratterizzate da mentalità
e preparazione manageriale moderne, costituì un importante fattore
di rinnovamento e di innovazione tecnica e strutturale soprattutto nel
settore della viticoltura.
A partire dagli anni cinquanta iniziò un profondo rinnovamento
della viticoltura toscana, che passò da coltura consociata a coltura
specializzata, in modo da sfruttare l’impiego di macchine per la lavorazione
del terreno, per la concimazione, per i trattamenti fitosanitari, per il
trasporto veloce ed efficace dell’uva alle cantine, per la potatura e la
vendemmia. Furono costituiti vigneti di ampia superficie, realizzati su
superfici di terreni interessati da profondi rimodellamenti con pesanti
macchinari. Questi scassi rendevano la superficie fertile e meno
impervia, furono abbandonate le coltivazioni delle viti di montagna e del
fondovalle, dove in passato la viticoltura era stata spinta per soddisfare
le esigenze dell’autoconsumo. I nuovi vigneti furono modellati adottando
distanze tra i filari di circa 3 metri, palature di cemento e fili di ferro.
Il rinnovamento comportò anche una sensibile modifica dell’assortimento
varietale, con una riduzione del numero di vitigni ed il conseguente abbandono
di numerose varietà locali, le quali furono esposte al pericolo
di una totale scomparsa, aggravando un processo di erosione genetica e
di riduzione della biodiversità che si era già manifestata
nella ricostituzione viticola postfillosserica. Il vivaismo viticolo toscano
si trovò anche ipreparato a rispondere alle richieste dell’elevata
quantità di barbatelle necessarie per i nuovi vigneti, questo contribuì
a favorire l’introduzione da altre regioni di materiale poco controllato
spesso scadente anche sotto il profilo genetico. Il CNR (Consiglio Nazionale
della Ricerca), promosse una intensa attività sperimentale, svolta
soprattutto nel settore della meccanizzazione. Fecero ben presto la comparsa
nei nuovi vigneti le prime macchine per la potatura, le vendemmiatrici,
forbici pneumatiche, legatrici. I risultati che derivarono furono pessimi,
mentre l’introduzione di monoculture vinicole cambiarono radicalmente l’estetica
dei paesaggi toscani.

Nel settore enotecnico, fecero la loro comparsa anche le cantine sociali;
agli inizi degli anni ottanta erano in Toscana 33, esse svolsero
un importante ruolo come fattore di evoluzione tecnica, ma anche nell’aggiornamento
e diffusione di moderne conoscenze di tecnica vinicola.
Importanti innovazioni furono introdotte nel miglioramento delle
condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature di cantina. Furono
impiegati nuovi materiali nelle attrezzature enologiche come vetroresine,
acciai inossidabili. Furono introdotti macchinari per l’imbottigliamento
ad elevata automazione, per il condizionamento tecnico dei locali e dei
contenitori per il vino. Sempre più ampio divenne l’uso di lieviti
selezionati, per il controllo della fermentazione. In definitiva la vecchia
cantina del proprietario o del mezzadro, fu cancellata e sostituita dalla
attrezzatissima cantina sociale, dirette da personale specializzato in
enologia. La produzione venne collocata sul mercato nazionale ed internazionale
mediante sistemi razionali di commercializzazione.
Le politiche comunitarie.
Le politiche comunitarie hanno regolato la produzione dei vini. L’introduzione
nel 1963 della Denominazione di origine dei vini ha contribuito alla tutela
ed alla valorizzazione delle produzioni. Il rinnovamento viticolo è
stato favorito anche dagli interventi finanziari supportato dalla CEE.
Le nuove normative intendevano evitare che vini di scarsa qualità,
con caratteristiche organolettiche non tipiche o prodotti in aree viticole
non precisate fossero commercializzati col nome di vini pregiati. Il riconoscimento
della Denominazione di Origine Controllata ebbe come prima conseguenza
l’aumento dei prezzi di mercato dei vini riconosciuti. In un primo momento
alcuni vini riconosciuti non ottennero le produzioni di uva per ettaro
ammesse dai disciplinari DOC. Interventi finanziari pubblici nel periodo
1975-83, furono erogati per aumentare la produzione vinicola. Sotto questa
spinta furono estirpati 14.000 ettari di vigneti sia specializzati che
consociati anche relativamente giovani, e reimpiantati 12.000 ettari di
nuovi vigneti specializzati. Gli interventi degli enti pubblici svolsero
un ruolo di notevole importanza per il rinnovamento della viticoltura Toscana,
non mancarono tuttavia carenze di natura tecnica che portarono a scassi
troppo profondi che in certi casi hanno compromesso la stabilità
dei versanti collinari o l’affioramento di strati di terreno sterile, diffusione
di materiale di piantagione di origine non controllata sotto il profilo
genetico e sanitario, scelta dei portinnesti non diversificati in rapporto
alle specifiche situazioni tecnico-agrarie, applicazione di distanze e
di densità di piantagione determinate dall’esigenza della meccanizzazione
che hanno introdotto nella vite un equilibrio vegeto-produttivo precario.
Il rinnovo dei vigneti è stato accompagnato anche da un progressivo
e notevole cambiamento della tipologia enologica, questo orientamento ha
gradualmente portato ad un allontanamento dei tradizionali vini dalle loro
originarie caratteristiche organolettiche. Nel chianti è difficile
trovare vini di “pronta beva” prodotti in passato, sono stati creati vini
nuovi, utilizzando vitigni di uva quali “Cabernet, Merlot, Pinot, Sauvignon,
Chardonnay, Riesling”. Alla fine degli anni settanta si sviluppò
in Toscana un certo interesse verso la produzione di vini bianchi freschi,
leggeri, poco colorati, frizzanti, adatti ad incontrare il gusto dei giovani,
l’emblema dei quali fu il Galestro. La Toscana si è inserita anche
nella produzione del “vino novello”, iniziata a Cuneo con il “Vinot” e
a San Casciano con il “San Giocondo”, e si è sviluppata rapidamente
fino a raggiungere verso gli anni Novanta centoventi etichette.
L’ultimo decennio.
Gli anni Novanta videro l’orientamento dei mercati verso la richiesta
di prodotti di elevata qualità, nel contempo nei paesi quali Italia,
Francia, Spagna, Germania, si registrava una sensibile diminuzione del
consumo di vino pro-capite determinato dal cambiamento degli stili di vita
e dal diffondersi delle diete salutistiche che penalizzavano il vino per
il suo elevato livello calorico. All’interno della UE, il consumo dei vini
pregiati è aumentato del 18%, mentre quello di tutti gli altri vini
è diminuito del 28%. Dal boccale o bicchiere (gotto) delle bettole,
il vino è passato alla bottiglia vestita di sgargianti colori, servito
in sofisticati bicchieri, dalla forma particolare, studiati per esaltarne
il colore e gli aromi. È stato accertato che un moderato consumo
di vino riduce il rischio di cardiopatie, di ischemie, di alcune forme
tumorali, del morbo di Alzheimer, potenzia la memoria, rallenta i processi
di invecchiamento, esercita azione antibatterica ed antiossidante. Notevoli
sono le innovazioni di carattere tecnico. I nuovi vigneti sono piantati
elevando la densità di piantagione, sono utilizzati terreni drenati
al fine di conseguire il massimo controllo delle acque profonde e superficiali.
Allo scasso viene preferito la lavorazione del terreno per il nuovo impianto,
medianti escavatori, utilizzando il pietrame trovato in profondità
per costruire fosse di drenaggio, o muri a secco per interrompere il declivio
delle acque superficiali. Spesso è anche curata l’estetica del vigneto,
preferendo l’uso dell’armatura di sostegni in legno, oppure impiegando
pali in cemento di colore marrone e talvolta piantando all’inizio dei filari
cespugli di rosa. L’inerbimento del terreno in sostituzione delle lavorazioni
pesanti o dei diserbanti chimici, hanno apportato maggiore equilibrio della
fertilità del suolo, sulla difesa dall’erosione, sullo stato sanitario
delle piante, sulla stessa qualità dell’uva. Oltre a questo la concimazione
più equilibrata e la difesa fitosanitaria attuata secondo criteri
della massima salvaguardia possibile sull’ambiente hanno prodotto uve di
elevata qualità in Toscana.
Negli ultimissimi anni il vino è stato inserito come elemento
essenziale nell’evoluzione culturale. Il nostro patrimonio storico, artistico
e culturale non può fare a meno dell’enologia come elemento indispensabile
nella conservazione e valorizzazione del territorio toscano. Nei primi
anni del 2000 in Toscana abbiamo avuto circa 10 milioni di turisti all’anno
interessati a strutture agrituristiche attrezzate per l’enoturismo. Nel
1996 la legge n° 69 del 13.8.1996, regolava l’introduzione in Italia
di mappe delle strade del vino.
Sempre negli ultimi anni il regolamento CEE n° 822/87, vieta la
costituzione di nuovi vigneti, e regola l’estirpazione di vecchi vigneti
e la ricostruzione secondo nuovi criteri, mediante l’acquisizione dei diritti
di reimpianto.
Da: http://www.tuscanfarm.com/corso_di_viticoltura.htm
Morfologia della vite.
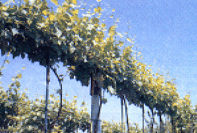
Nella vite si distinguono vari apparati: quello radicale, il fusto
i tralci e poi gemme, foglie, fiori e frutti. Le radici delle
viti normalmente coltivate non provengono da un seme ma da una porzione
di ramo (tralcio) costretto a radicare in vivaio. L'estremità della
radice è ricoperta dalla cuffia che protegge questa zona delicata,
subito dietro si trovano i peli radicali che assorbono le sostanze. Questa
zona è molto breve tutto il resto è struttura di trasporto
ancoraggio e immagazzinamento. Il fusto è costituito nella parte
bassa da un ceppo che si divide in branche e tralci che sono di struttura
lianosa e costituiti da nodi e internodi. Solitamente sul primo e secondo
nodo dei tralci formati nell'anno in corso, si trovano i grappoli, sugli
altri si trovano dei filamenti. Le gemme si sviluppano fra il picciolo
delle foglie e il tralcio (ascella) e si distinguono fra pronte e ibernanti.
Le pronte sviluppano tralci o grappoli nello stesso anno in cui si sono
formate, i quali possono essere dannosi o di scarsa utilità.
Le ibernanti invece, lavorano tutto l'anno per formare il tralcio e i grappoli
in miniatura che si svilupperanno l'anno successivo. La foglia della vite
è utile per riconoscere le diverse varietà. La forma infatti
può ricordare un rene, un cuneo, un pentagono ecc. con piccole differenze
fra le varie specie e fra i cloni (clone=piccola variazione genetica all'interno
della stessa specie) La lamina fogliare è sede della fotosintesi
clorofilliana e quindi della produzione degli zuccheri, la pagina inferiore
ospita delle piccole aperture (gli stomi) che servono per gli scambi gassosi.
La foglia è inserita sul tralcio per mezzo di un picciolo, al sopraggiungere
dell'autunno, prima della sua caduta, la pianta convoglia nella foglia
le sostanze da espellere. Per l'uva da vino il fiore è generalmente
ermafrodita, cioè porta tutti e due i sessi; quello femminile (il
gineceo) che contiene gli ovuli, quello maschile (l'androceo) composto
da cinque stami che distribuiscono il polline. Il frutto di questa infiorescenza
è un grappolo composto da acini e raspo. Il grappolo può
avere forma più o meno cilindrica o a piramide, da esso si dipartono
una , nessuna o due appendici dette ali. L'acino o bacca è rivestito
dalla buccia che contiene molte sostanze utili al vino, la polpa la si
può dividere in tre livelli: quello mediano è il più
ricco di zuccheri, ed è il primo da cui fuoriesce il succo durante
la pigiatura, il più esterno ha una concentrazione media, il centrale
è il più povero e contiene anche i semi solitamente quattro
i quali contengono sostanze e oli che possono dare cattivi odori al vino,
soprattutto se i vinaccioli vengono rotti. Come tutti i frutti, l'acino
d'uva è in realtà una 'confezione' che serve a proteggere
i semi (i vinaccioli) fino alla fine del loro sviluppo. Esternamente troviamo
la buccia costituita da una parte esterna, la cuticola, e una parte interna.
Qui si trovano gran parte delle sostanze coloranti e aromatiche. 'Sfogliando'
l'acino si arriva alla polpa, composta dal mesocarpo, succoso e carnoso,
e dall'endocarpo, esile e molle che contiene i vinaccioli. I vinaccioli
sono ricchi di flavanoidi di natura fenolica (importanti per il colore
nel vino). Sono anche ricchi di tannini ma non vanno schiacciati, perché
fuoriuscirebbe troppo tannino e soprattutto una sostanza oleosa sgradevole
per il vino. La polpa contiene le sostanze che finiranno nel mosto: è
composta da acqua per il 70-80%, da zuccheri, da acidi, da composti azotati,
vitamine, minerali e sostanze coloranti. Nella parte più interna
della polpa, vicino ai vinaccioli c'è meno zucchero e meno acidità,
nella parte media si ha una media acidità e molti zuccheri e nella
parte più esterna si hanno medi zuccheri e pochi acidi.
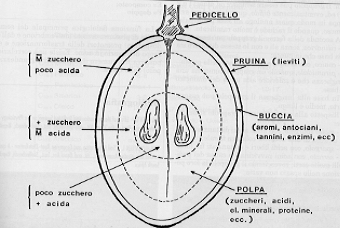
Da: http://www.italcuisine.it/liguria/enologia/malattie/malvite.htm
Malattie della vite e dei vini
Le malattie della vite non sono solo di origine parassitaria, ma comprendono
tutte quelle alterazioni degli organi della pianta dovute ad avversità
atmosferiche e a carenze alimentari che provocano disturbi fisiologici
manifesti, alterazioni che vengono più propriamente chiamate ampelopatie.
L' instaurarsi delle malattie è totalmente legato alle condizioni
che favoriscono lo sviluppo delle piante ed è per questo che la
loro diffusione è associata a diversi fattori: il microclima che
circonda la pianta può permettere lo sviluppo di determinate fisiopati
così come il terreno, l' esposizione, la forma di allevamento, le
varie fasi vegetative e i vari organi della pianta possono facilitare o
meno un determinato patogeno o parassita.
ACINELLATURA
Alterazione consistente nella produzione di acini che non raggiungono
le dimensioni tipiche ma, nel grappolo, appaiono talora più grossi
del diametro normale taluni inferiori o molto piccoli. Di solito l' alterazione
assume maggiore valore negativo per la produzione.
ALTICHE
Questa malattia deriva da ALTICINI, una famiglia di insetti Crisomelidi.
Essi provocano danno in quanto schelettrizzano le foglie. La lotta contro
gli alticini si attua in genere con irrorazioni arsenicali.
FILLOSSERA
La malattia è provocata da un afide (Phylloxera vastatrix) che
sui vitigni europei attacca solo le radici fino a portare la pianta alla
morte. I danni sono gravissimi, in quanto si manifesta il deperimento della
pianta quando ormai l' attacco alle radici è allo stadio finale,
e la vite muore. L' unico mezzo di lotta consiste nell' innestare le viti
europee su piede americano, che resiste meglio alla malattia e non presenta
degenerazioni sulle radici.
MUFFA GRIGIA O BOTRITE
Il fungo (Sclerotinia fukeliana o Botrytis cinerea) colpisce soprattutto
i grappoli, specie in alcuni ambienti e su particolari formedi allevamento
(tipo tendone) dove è difficile la circolazione dell' aria; adottando,
specie nei climi umidi, vitigni con grappoli spargoli e con una notevole
resistenza della buccia (es. Pinot e Tokai); somministrando razionali concimazioni
in cui abbondi il potassio e non ci sia un eccesso di azoto (quindi poco
letame). I prodotti usati per la lotta chimica sono esteri fosforici sistemici
come il benlate, il benonyl che si possono mescolare a trattamenti contro
la peronospora e l' oidio.
OIDIO
Dal greco uovo genere di funghi imperfetti iscritto alle famiglie delle
Moniliali è la più antica fra le più gravi malattie
crittogamiche che hanno colpito i vigneti europei nella metà del
secolo scorso. Questa malattia è di origine americana. Tutti gli
organi verdi della pianta, grappoli, foglie,germogli sono colpiti dal parassita
fungino che è in grado di propagarsi da quando la temperatura dell'
aria inizia a salire ( 4°-5°) e sin verso i 25°. L' umidità
favorisce lo sviluppo. L' oidio si combatte con irrorazioni di zolfo in
polvere puro o rameato. Spesso i trattamenti vengono fatti contemporaneamente
a quelli contro la Peronospora, mescolando gli zolfi bagnabili con solfato
di rame o sali di zinco. Dato che lo oidio colpisce maggiormente il grappolo
la lotta contro di esso è di primaria importanza in viticolture.
PERONOSPORA O PLASMOPARA VITICOLA
Genere di funghi Ficomiceti ascritto alla famiglia delle peronosporacee.
Vi appartengono diverse specie parassite di piante superiori, delle quali
la più diffusa e dannosa è la plasmopara della vite. La specie
è originaria dell' America del Nord, dove, si ritiene fosse un parassita
abituale delle piante selvatiche di vite. La sua prima comparsa in Europa
fu msegnaqlata in Francia nel 1878. La presenza del parassita è
svelata dalla comparsa sulla foglia di zone translucide dette "macchie
d' olio". Il micelio (fungo) si insinua nella parte inferiore della foglia
e in mezzo al grappolo, formando dentro masse di ife; la sua "produzione"
è rapidissima. Il danno è ingente e la produzione di zoospore
è elevatissimo, e sono facilmente trasportabili dal vento. Il danno
al frutto vero e proprio si può notare dal fatto che i chicchi d'
uva rinsecchiscano totalmente. La lotta contro questo tipo di fungo è
attuabile solo quando il parassita si trova all' esterno della pianta,
perciò si pratica irrorando le foglie con anticrittogamici a base
di rame.
PIRALIDI
Vasta famiglia di insetti iscritti all' ordine dei LEPIDOTTERI. Essa
è particolarmente diffusa nei paesi a clima caldo. I piralidi sono
farfalle notturne e per la massima parte dannose, perchè allo stadio
larvale si evolvono a spese di piante di grande interesse e valore agrario,
come ad esempio la vite. Sono farfalle di dimensioni medio piccole, di
costituzione gracile, ali e zampe molto ampie e lunghe rispetto al corpo.
RONCET
O arricciamento della vite. Malattia della vite dovuta ad una infezione
o ad un complesso di infezioni da virus e trasmessa per talea e col terreno.
Questa malattia a cui sono soggetti in particolar modo gli ibridi si manifesta
con aspetto cespuglioso delle piante che si presentano con ramificazioni
dense e brevi per il raccorciamento degli internodi e per lo sviluppo di
molte ramificazioni secondarie. Le foglie sono piccole e deformate da numerose
frastagliature. Tutta la pianta giunge rapidamente ad essiccarsi completamente.
TIGNOLA
Da POLYCHROSIS BOTRANA si tratta di un insetto lepidottero che compie
3 generazioni annuali e sverma allo stato di crisalide, le femmine depongono
cica 200 uova ciascuna 2 o 3 giorni dopo l'accoppiamento e le depositanosui
grappoli florali, sui tralci e sulle foglie. Le larve emettono gli sericei,
si tessono una specie di bozzolo e si nutrono divorando i boccioli dei
fiori. I danni causati alla vite sono ingentissimi nonostante le tignole
abbia molti nemici naturali quali funghi, imenotteri, ditteri, parassiti.
L'uomo difende la vite con la lotta chimica con arseniato di piombo o di
calcio, fluorosilicato di bario e cloroderivati organici molto tossici
e quindi devono essere usati con molta prudenza.
Un'ultima riflessione.
La vite è una pianta rampicante della famiglia delle ampelidacee
o vitacee che a sua volta appartiene dell'ordine dei rhamnales.
Il genere Vitis delle ampelidacee è
quello che interessa dal punto di vista della viticoltura, poiché
la legge impone che sia la specie Vitis Vinifera il solo ceppo utilizzabile
per la produzione di vino.
Le due sottospecie di Vitis Vinifera
sono:
· Vitis Sativa, quella coltivata e utilizzata per vinificare
· Vitis Silvestris, quella selvatica, dei boschi
La pianta della vite ha due cicli biologici.
Il ciclo vitale riguarda le varie età della pianta:
· giovane, fase di improduttività dal 1° al 3°
anno
· adulta, fase di normalità produttiva distinta in
· crescente, dal 4° al 5° anno
· costante, dal 6° al 20-25° anno
· vecchia, oltre i 30 anni (anche se in realtà le viti
con piede-franco possono risultare costanti addirittura fino ai 100 anni)
Il ciclo annuale di una vite è rappresentato dalle fasi che
si succedono ogni anno e si divide in tre sottocicli (fasi fenologiche):
· Attività radicale
· pianto, durante il periodo di dormienza la linfa vitale va
dalle radici alle foglie. Dai tralci escono gocce di linfa (pianto della
vite).
· Vegetativo
· germogliamento, in aprile
· accrescimento dei germogli , sviluppo dei rami normali e di
quelli anticipati (femminelle), va da aprile ad agosto
· agostamento, da agosto a novembre, maturazione del germoglio
che da verde diventa marrone
· riposo, dalla defogliazione di dicembre fino al germogliamento
di aprile
· Riproduttivo
· comparsa grappolini, con sviluppo e formazione dei fiori
· fioritura, nella prima metà di giugno apertura dei
fiori (antési) e fecondazione con il polline (unione)
· allegagione verso la metà di giugno passaggio dal fiore
al frutto
· ingrossamento, fino alla metà di agosto (dipende dalle
varietà) accrescimento degli acini
· invaiatura verso la metà di agosto colorazione delle
bacche (in questa fase si può procedere all'eliminazione dei grappoli
in eccesso per prediligere la qualità rispetto alla quantità)
· maturazione, crescita del rapporto zuccheri/acidi all'interno
delle bacche fino a settembre-ottobre
La vite è purtroppo soggetta ad
alcune avversità che possono influire negativamente sulla produzione
finale. Queste avversità si possono così classificare:
· non parassitarie, sono il gelo invernale, le gelate primaverili,
la grandine, la carenza e/o l'eccesso di minerali, siccità o eccesso
idrico (asfissia radicale), erbicidi, ecc.;
· parassitarie, con malattie provocate da
· virus (arricciamento, accartocciamento fogliare, suberosi
corticale, legno riccio)
· funghi (peronospora, mal dell'esca, oidio)
· animali (ragnetti, tignole, fillossera, nematodi)
Per un vino di qualità la scelta del vitigno è per forza
legata al territorio nel quale si produrrà il vino stesso: i vini
di maggior successo sono quelli prodotti con uve che si sono perfettamente
integrate nell'ambiente pedoclimatico.
La legislazione in materia impone
infatti dei disciplinari dai quali non si può prescindere, perciò
per produrre sotto una denominazione è obbligatorio impiantare i
vitigni autorizzati e/o raccomandati nella misura ammessa dai regolamenti
e soprattutto indirizzarsi verso le cultivar autoctone: la tendenza attuale
è quella di far ricorso ai cosiddetti vitigni internazionali, spesso
più facili da impiantare e più costanti nella produzione,
ma i vitigni qualitativi italiani sono il vero punto di riferimento per
una vitivinicoltura di qualità.
La scelta dei cloni migliori dovrà
portare a una produzione bassa, a grappoli più piccoli e compatti
e ad una maggiore concentrazione di sostanze da estrarre durante la vinificazione.
Intorno alla fine del 1800 la Vitis
Labrusca giunta dall'America nascondeva un grave malanno per i vitigni:
la fillossera, un parassita che attaccava le radici e lentamente distruggeva
la specie europea.
Si verificò una catastrofe ambientale e morì la quasi
totalità dei vigneti.
I tentitativi di arginare il fenomeno
si rivelarono un insuccesso dopo l'altro, finché si cominciò
a reimpiantare i vitigni adottando la tecnica dell'innesto di marza autoctona
europea (la marza è una porzione di tralcio) su portainnesti provenienti
dall'America, perché la fillossera non sembra gradire le radici
americane.
Restano comunque alcuni pregiati vitigni
autoctoni come il Nebbiolo e la Barbera che si sono salvati soprattutto
in alta quota o vicino alle zone sabbiose dove non prolifera la fillossera.
Attualmente l'unico paese al mondo "piede-franco", cioè totalmente
autoctono, è il Cile.
Per la propagazione delle barbatelle di vite si utilizza la tecnica
dell'innesto. Gli elementi sono il portainnesto o piede, cioè la
porzione della pianta provvista di apparato radicale, e poi la marza, una
porzione di tralcio con una o più gemme, che si salda all'innesto.
I metodi di innesto più conosciuti sono due:
· a doppio spacco inglese (ad omega), utilizzato nell'Italia
del Centro/Nord; si esegue al tavolo;
· alla maiorchina (a gemma) utilizzato soprattutto nell'Italia
meridionale e insulare; si esegue direttamente in campo
Per la scelta del vitigno occorre effettuare uno studio delle
caratteristiche ambientali per individuare anche il portainnesto migliore,
nel senso che dovrà resistere e adattarsi al meglio a quelle condizioni
e non altre, come umidità, siccità, calore, freddo, vento,
ecc.
Allo stesso tempo sarà molto importante la scelta della marza
perché risulti fruttifera e sana.
Si definisce:
· selezione clonale la generazione di un clone per via vegetativa,
· selezione massale la creazione di una serie di esemplari dalle
migliore piante di un vigneto,
· selezione individuale la moltiplicazione dei migliori singoli
vitigni.
Situazione geografica-orografica
di Angelo Petracci
La vite dà uve migliori in collina
piuttosto che in pianura: l'inclinazione del suolo, detta giacitura, assicura
un superiore drenaggio, un maggiore impatto dei raggi del sole e conseguentemente
una maggiore attività vegetativa e una migliore maturazione dei
frutti. Più si procede verso nord, più dovrà aumentare
la pendenza.
In pianura l'esposizione è minore
in quanto ripartita su una superficie più estesa, sono più
frequenti le gelate primaverili, assai pericolose in quanto la pianta comincia
a germogliare.
A parità di latitudine e di giacitura
conta poi l'esposizione: i vigneti orientati a sud godono di una maggiore
esposizione al sole e quindi tale condizione dovrà essere ricercata
soprattutto nelle zone nordiche.
Nella scelta della posizione del vigneto
va poi tenuto conto del tipo di vitigno: tanto più il clima è
freddo tanto più verranno scelte uve a maturazione precoce.
Altro elemento che condiziona il clima
locale è dato dalla presenza di montagne, foreste, fiumi e laghi
che proteggono le vigne dai venti freddi, assicurano un serbatoio di umidità
durante la stagione calda e svolgono una importante azione termoregolatrice.
La vite si adatta a qualsiasi tipo di
terreno ma lo stesso vitigno non dà uve uguali se coltivato in terreni
dalle caratteristiche differenti.
Il suolo è costituito da un sottile
strato coltivabile influenzabile dalle culture dell'uomo, e da una parte
sottostante le cui caratteristiche sono date dalla conformazione geologica
originaria. E' qui che la pianta della vite affonda le sue radici principali
e si influenza il carattere del vino.
Le caratteristiche del sottosuolo sono
importanti in primo luogo per il drenaggio che assicurano alla pianta e
per i sali minerali in esso contenuti: il terreno ciottoloso-permeabile
assicura drenaggio, quindi buona maturazione delle uve (vini ad alta gradazione,
fini ed intensamente profumati). Inoltre i ciottoli, poco fertili, obbligano
la pianta ad affondare nel sottosuolo le radici e quindi il vino sarà
ricco di estratti minerali. Se i ciottoli sono di colore bianco riflettono
sulla pianta i raggi solari, i ciottoli scuri accumulano invece il calore
e lo rilasciano di notte permettendo un maturazione a temperature senza
eccessivi sbalzi.
Da non trascurare è il grado
di acidità del terreno: in Europa i vini migliori provengono da
terreni calcarei e alcalini mentre in California provengono da terreni
neutri o acidi.
E' importante anche il colore del suolo:
- suoli di colore scuro si riscaldano e favoriscono la maturazione
del frutto; - quelli chiari sono più freddi, ritardano la maturazione
e quindi favoriscono vini di maggiore acidità.
In sostanza la natura del terreno influisce sulle caratteristiche del
vino:
§ i terreni sabbiosi daranno vini scarichi di colore e di estratto
ma delicati e fini;
§ i terreni calcarei generano vini ricchi di alcol e profumi
§ i terreni ciottolosi danno vita a vini alcolici e di elevata
qualità
§ i terreni un po' argillosi portano a vini longevi, ricchi di
estratto e acidità
Dopo la scelta del terreno e del vitigno in base al clima e all'orografia
si esegue lo scasso del terreno: si tracciano quindi i filari, gli interfilari
e le capezzagne (strade di accesso in terra battuta lungo le testate dei
campi) e si sistemano i tutori e i fili di ferro su cui appoggerà
la vite.
In collina sono utilizzate le sistemazioni
a girappoggio o traverso, cioé filari che sono paralleli alla cima
e frenano il dilavamento; se la pendenza è considerevole (es: Cinque
Terre, Valtellina) si può ricorrere ai terrazzamenti, in caso di
pendenze meno forti (minori del 20%) si può scegliere la sistemazione
a ritocchino che segue in modo perpendicolare la linea da monte a valle.
Ognuna di queste sistemazioni tende ad evitare il dilavamento del terreno
(cioé l'erosione da parte dello scorrimento delle acque) e a favorire
la meccanizzazione delle potature e della raccolta.
Ma a tal fine, oltre alla sistemazione del vigneto i vignaioli adottano
anche altri accorgimenti: la pratica dell'inerbimento consiste nel far
crescere nella vigna erbe che impediscono il dilavamento del terreno e
nei terreni umidi permettono l'utilizzo dei macchinari senza che questi
schiaccino il terreno rendendolo troppo compatto (questo fenomeno favorisce
l'umidità che può produrre lo sviluppo di malattie).
La pacciamatura consiste nel coprire
il terreno con aterilae organico come paglia e pula. Si limita in questo
modo l'evaporazione, si incrementa la struttura del terreno aumentando
così la penetrazione della pioggia.
Altra tecnica è quella del sovescio,
la coltivazione di piante leguminose che seminate tra agosto e dicembre
vengono interrate in primavera.
Un parametro fondamentale per determinare
la densità di impianto per ettaro è il sesto di impianto,
la distanza cioè tra i filari e tra le piante di un filare, che
influisce sulla qualità del vino perché la densità
obbliga le piante ad entrare in competizione e ad affondare le radici nel
sottosuolo per trovare spazio vitale. La pianta vegeta di meno, matura
meglio i grappoli ed il sottosuolo, più ricco di sali minerali,
determina una maggiore qualità del vino. La densità ottimale
per una viticoltura di qualità è comunemente indicata è
di 6-7000 ceppi per ettaro.
Situazione pedoclimatica
di Angelo Petracci
La vite è una pianta molto resistente,
ma nonostante questa capacità di adattamento alcune condizioni climatiche
ne permettono un migliore sviluppo in funzione della produzione di vino
di qualità.
Le temperature medie annue non devono
essere inferiori ai 10°C con una media intorno ai 20°C in estate
e -1°C in inverno. La quantità di calore è molto importante
in quanto è preferibile una maturazione costante delle uve, che
produca vini profumati ed equilibrati. Fondamentale è inoltre il
freddo invernale, in quanto favorisce sia la maturazione del legno che
l'eliminazione dei parassiti.
Altra importante variabile sono le precipitazioni,
perché mantengono il terreno umido e favoriscono la maturazione
dei frutti, soprattutto se si concentrano in inverno e primavera, con temperature
fresche. E' invece dannosa la pioggia che cade durante la fioritura e durante
la vendemmia, quando diluisce la concentrazione del succo degli acini.
Nei paesi dove fa molto caldo si interviene con irrigazioni, una pratica
da noi in Italia ritenuta discutibile e addirittura vietata in Francia
per quanto concerne le AOC.
Per quanto detto finora circa l'importanza
dei fattori climatici e orografici risulta chiaro il motivo per cui ogni
paese si è specializzato nella produzione di determinate tipologie
di vino:
· le zone molto calde danno uve zuccherine e con poca acidità
e quindi vengono prodotti vini liquorosi;
· le zone più fredde danno uve con meno zuccheri e maggiore
acidità, quindi vini meno alcolici e più acidi;
· le zone a clima intermedio, come la Francia centrale e l'Italia
settentrionale si caratterizzano per la produzione di vini rossi e bianchi
di corpo pieno.
L'ultimo parametro da prendere in considerazione
è dato dal microclima che è determinato dal sistema di potatura,
dall'inerbimento del terreno, dalla distanza tra le piante, la distanza
tra i filari e la distanza delle piante dal terreno. Il tendone per esempio
protegge le piante dall'eccessiva insolazione ma allo stesso tempo ne diminuisce
la capacità di maturazione delle uve.
Il microclima rappresenta in sostanza le particolari condizioni climatiche
che si vengono a creare nel singolo vigneto, a poca distanza dal suolo.
Il lavoro in vigna
Altro importante fattore è la
potatura della pianta. Nella scelta della tecnica vanno tenuti in considerazione
il clima, il tipo di terreno, il grado di umidità della zona.
I sistemi di allevamento sono numerosi
e sono classificati per:
· l'altezza del tronco
· bassa,
· media,
· alta
· l'altezza dei capi a frutto
· potatura corta, (cordone speronato, alberello ecc..) forma
in genere più pratica nella gestione (nessuna legatura dei tralci
in fase di potatura) e spesso facilmente meccanizzabile (Gdc, cordoni alti)
· media/mista, tipo che prevede sia tralci lunghi (8-15 gemme)
che tralci corti (2-3 gemme); un esempio di questo tipo di potatura è
quella utilizzata nel Guyot;
· lunga, conserva tralci di lunghezza media di 10-20 o più
gemme; questa forma di allevamento è in genere molto espansa e con
sesti di impianto larghi
· lo sviluppo dei tralci
· orizzontale,
· verticale,
· inclinato
Home