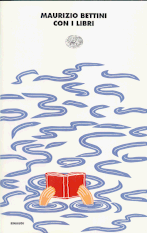
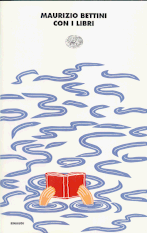
lo so che da tanto tempo
non si usa più rivolgersi direttamente a colei o colui che apre la
prima pagina di un libro.
Sembra quasi di voler cogliere qualcuno di sorpresa, o peggio ancora di
scoprire brutalmente le regole della finzione. Il fatto è, però, che
questo libro
racconta storie di libri, di giornali, di lettere, di diari, di letture
e di scritture in generale. Per cui ho pensato che in un caso del
genere
la vecchia apostrofe al lettore non solo non sarebbe risultata fuori
luogo ma faceva addirittura parte dell'argomento. Avrei tante domande
da rivolgerti. Per esempio sarei curioso di conoscere i tuoi gusti in
fatto di libri e il nome della città in cui abiti. Ma
soprattutto vorrei chiederti: che cosa ci fai, tu, con quello che
leggi? Saperlo mi sarebbe molto utile, perché le storie contenute nel
mio libro
parlano proprio di questo. Cosa significa per te vivere con i libri?
Forse mi stai già rispondendo, magari a fior di labbra, ma anche se ti
mettessi a gridare io non potrei sentirti perché stiamo comunicando
attraverso un libro: che è uno degli strumenti più sordi e imperfetti
che gli uomini abbiano mai escogitato. Io posso comunicare con te -
seppure infrangendo le regole della moda e della buona creanza
letteraria, dato che ti parlo direttamente.
Ma in nessun caso tu potresti comunicare con me. Che strane situazioni
si creano, con i libri.
Naturalmente sarebbe possibile far seguire un
questionario a quest'apostrofe, e tu potresti inviarmi le risposte a
un numero di fax. Ma somiglierebbe a una campagna di promozione
pubblicitaria o a un talk show televisivo. E noi
siamo lettori di libri, non possiamo subire di queste umiliazioni.
Meglio rassegnarsi all'idea che i libri sono fatti così, prevedono un
autore e un lettore. Per fortuna i ruoli sono intercambiabili e
molti lettori sono anche autori, mentre tutti gli autori sono (o
dovrebbero essere) dei lettori. Il resto è completamente affidato al
caso o alla buona volontà della gente. Una volta mi è capitato di
incontrare al mare una persona che stava leggendo un libro scritto da
me.
E' stata la prima e, penso, l'ultima volta nella mia vita. Ho avuto
subito la tentazione di rivolgermi a lui (la famosa "apostrofe al
lettore" sarebbe finalmente diventata una cosa reale) ma mi sono
trattenuto. A me avrebbe fatto piacere conoscerlo, ma che effetto avrei
fatto io, a lui? Mi è parsa una situazione da «lupus in fabula», come
dice il proverbio: quando si parla di una persona e quella
improvvisamente compare. Così si
sarebbe certo sentito il mio lettore vedendosi venire incontro l'autore
del libro che stava leggendo. Ho riflettuto.
Il fatto che in situazioni del genere si usi proprio l'immagine di un
lupo per indicare la persona che compare all'improvviso, mi ha sempre
fatto pensare che questa esperienza non sia considerata particolarmente
piacevole.
Io non avevo nessuna intenzione di fare il lupo e di spaventare il mio
lettore. Ho girato le spalle e me ne sono andato.
Per tutto il tempo in
cui ho continuato a scrivere queste storie non mi è stato possibile
leggere, o sfogliare, se non pochi libri. Intorno a
me ne avevo, seppure meno del solito, salvo che - per una di quelle
circostanze della vita personale che raramente vengono menzionate in un
libro -
non ero in grado di alzarmi e di andarmeli a prendere. Quante volte ho
pensato a tutti coloro per cui i libri sono sempre e irrimediabilmente
fuori mano. Prima di adesso non avrei mai sospettato una cosa del
genere.
E invece come possono essere lontani, anche i libri! La mia condizione
comunque si presentava paradossale.
Volevo scrivere un libro sui libri e non potevo toglierne neanche uno
dallo scaffale. Mi occupavo di libri e non avevo la possibilità di
sfogliarli,
parlavo della lettura e non avevo quasi niente da leggere. E anche
quando ce l'avevo non riuscivo a farlo. Meno male che potevo almeno
scrivere. Questo libro parla dunque di libri visti da lontano, di libri
ricordáti, spesso addirittura immaginati o sognati. Sai lettore? Anche
così sono stati una straordinaria compagnia.
Tutto era cominciato il
giorno in cui Cidippe navigò verso Delo, in pellegrinaggio. La ragazza
aveva solo diciannove anni e dell'isola si diceva che fosse piena di
meraviglie. Il viaggio non durò più di poche ore, alla sera già
attraccavano, e il
mattino seguente la visita cominciò.
Piena di stupore, Cidippe si appoggiò all'albero con le corna di capra,
e a lungo contemplò la palma a cui Latona si era tenuta abbracciata per
partorire Apollo. Un luogo santo per tutte le donne. Ma giunta di
fronte al tempio di Artemide, in pieno mezzogiorno, qualcosa le rotolò
fra i piedi. Era una mela, fresca e lucente come se fosse
appena caduta dall'albero. Cidippe si guardò intorno meravigliata, ma
non c'erano meli attorno a lei, solo marmi e cespugli di ginestra. Dopo
un istante di incertezza la nutrice si decise a raccogliere quel
frutto misterioso e vide che sulla buccia erano incise delle lettere.
La donna non sapeva leggere e porse la mela a Cidippe. "Leggi" le
disse, e la ragazza lesse ad alta voce.
Sulla buccia era incisa questa frase: "Giuro per Artemide di non
sposare altri se non Aconzio". Quando Cidippe capì il significato di
quello che stava leggendo era troppo tardi. Aveva già pronunziato il
giuramento. Il giovane Aconzio osservava la scena di nascosto. Ormai
Cidippe si era
legata a lui per sempre, l'amore a prima vista era riuscito a
realizzarsi con la stessa rapidità con cui era stato concepito.
Com'erano potenti i caratteri dell'alfabeto!
Anche se Cidippe, finito il suo pellegrinaggio e tornata a dai
genitori, avesse dimenticato quello strano episodio, il giuramento che
la mela le aveva
strappato avrebbe comunque continuato a legarla per sempre ad Aconzio.
E così accadde. Perché qualche tempo dopo i genitori della ragazza,
ignorando ciò che era
capitato alla figlia, la promisero a un altro sposo. Ma ecco che,
proprio alla vigilia delle nozze, la povera Cidippe si ammalò per
volere di Artemide.
La dea pretendeva il rispetto del giuramento fatto in suo nome: Cidippe
avrebbe dovuto sposare Aconzio oppure morire. Adesso Cidippe giace nel
suo letto, vegliata dall'ignaro
fidanzato, e non sa se leggere o meno la lettera che Aconzio le ha
mandato per chiederle di soddisfare finalmente il giuramento e di
sposare lui. Solo così potrà scampare alla morte. Ma Cidippe non ha il
coraggio
di leggere quella lettera. E se fosse un altro inganno? e se quelle
frasi servissero solo a vincolarla più strettamente? Aconzio è un uomo
che scrive. Per legare a sé la
persona che ama si è servito dei caratteri incisi sulla buccia di una
mela; per convincerla a compiere finalmente il giuramento che le ha
estorto, le ha inviato una lunga lettera. Il comportamento di
Aconzio è molto strano. Se si era innamorato di Cidippe, come diceva,
perché non le era andato incontro sulle gradinate del tempio di
Artemide?
Avrebbe potuto dichiararle il suo amore con frasi gentili. Era bello,
era ricco, era nobile, la fanciulla non lo avrebbe certo rifiutato e i
suoi genitori avrebbero accondisceso
volentieri al matrimonio. Invece se n'è rimasto nascosto dietro le
colonne del tempio per catturarla con un'esca, come se fosse un pesce o
un passerotto,
e l'ha ridotta in fin di vita. Anche adesso, che Cidippe sta per morire
e lui (almeno a parole) si dispera, non si decide però ad andare a
parlare direttamente con lei o con suo
padre. Ancora una volta preferisce starsene appartato e inviare una
lettera, facendosi rappresentare dai caratteri dell'alfabeto.
Perché? Sospetto che Aconzio abbia altre donne. Per questo non ha il
tempo di andare da Cidippe e rifiuta di parlare con i suoi
genitori.
Scrivere è facile,
quando si ha il dono di saperlo fare, e chissà a quante altre Aconzio
può aver spedito la formula del giuramento. Ho la prova di quel che
dico.
Non si tratta soltanto dell'astuzia della mela - così insolita e
bizzarra da poter essere attribuita solo (si presume) a un seduttore
esperto. La prova della mia supposizione sta
nel modo stesso in cui il giuramento è formulato: "Giuro per Artemide
di non sposare altri se non Aconzio". Non c'è un nome, un soggetto
preciso, ma solo un verbo. La formula non dice "Io, Cidippe, giuro" ma
soltanto "Giuro". Aconzio ha concepito il giuramento come un assegno
non intestato o come il facsimile di una dichiarazione,
in cui sono le circostanze a mettere il nome. Quel giuramento poteva
valere per chiunque altro, non era rivolto esclusivamente a Cidippe:
solo il caso ha fatto di lei il soggetto della frase. Per esempio, se
la nutrice non fosse stata analfabeta, e non avesse passato la mela
alla ragazza, a giurare sarebbe stata lei invece di
Cidippe. E adesso Aconzio si ritroverebbe una vecchia come promessa
sposa. Ma siamo sicuri che questo lo avrebbe messo in imbarazzo?
Aconzio, l'uomo che scrive, appartiene alla razza
degli autori che sanno farsi leggere. Su questo non c'è alcun dubbio.
Somiglia a un romanziere da supermercato, a un industriale della
canzone, a uno psicologo da settimanale. Scrive solo frasi che
gli garantiscano la fedeltà del lettore, chiunque esso sia, non fa
differenza se ottiene l'amore di Cidippe o quello della nutrice.
Aconzio non scrive
per comunicare un messaggio a qualcun altro ma, al contrario, per
ricevere lui stesso quello che ha scritto.
Anche i pubblicitari sono degli Aconzi. Seduti di fronte a modem e
tecnigrafi incidono ogni giorno una mela diversa ma il paradosso che
devono risolvere è sempre il medesimo: "me
lo sono scritto da solo che amo questo prodotto, però facciamo in modo
che a dirlo sia tu". Aconzio è un vero seduttore, non prega, non
implora, non costringe. Non si fa neppure vedere, e nessuno ha mai
udito la sua voce. Lui si limita a scrivere un copione, a parlare sono
solo le sue vittime. Sono loro che giurano e si dichiarano, non lui, e
in un tribunale
sarebbe difficile incastrarlo. La scrittura di Aconzio è il seme di
tutte le scritture astute, e l'unico modo per sottrarsi alla sua
trappola sarebbe quello di non leggerla. Ma
è possibile? Cidippe mi ha sempre fatto simpatia. Molti, forse lei
stessa per prima, avranno pensato che leggere quella frase senza
riflettere fu un atto di
grande leggerezza. Ma anche a me sarebbe accaduto esattamente lo
stesso. Anch'io leggo tutto quello che vedo scritto, e credo che in
realtà ben pochi riescano a sottrarsi alla fascinazione dei caratteri
dell'alfabeto. Non solo a quella provocata dalle scritture astute,
concepite al solo scopo di essere lette, ma anche a quella che emana da
qualsiasi scrittura.
Leggendo la frase incisa sulla mela Cidippe ha reagito come sempre si
reagisce di fronte a ogni scritta: leggendola.
Quando si viaggia con la macchina, per esempio, è
impossibile non leggere la frase "dio c'è" sui segnali stradali, mentre
a piedi, per la via, gli occhi restano infallibilmente catturati dalle
insegne dei negozi ("Farmacia" "Alimentari" "Hardware"...) e dai menù
appesi fuori dalle
pizzerie. Tutto ciò che è scritto da qualche parte, anche la frase più
stupida e inutile, obbliga automaticamente alla lettura. Per questo non
si può neppure evitare di leggere i graffiti sui
muri e i numeri di telefono lasciati dai maniaci nelle toilettes. E'
ovvio che non ha senso accettare questo dialogo cieco e senza ritorno
("Comunisti bastardi" "La Fossa" "Sophie sucks"...) Chi
scrive graffiti non intende rivolgersi a un interlocutore, né desidera
realmente inoltrare un messaggio - tant'è vero che l'autore delle
scritte, per definizione, non sarà in quella cabina telefonica o in
quello scompartimento del treno quando il messaggio verrà finalmente
raccolto. Il graffito materializza la pulsione a un linguaggio segreto,
incomunicabile,
che nessuno dei suoi autori oserebbe mai trasformare in un messaggio
autentico o in un discorso pubblico. Quello che si consuma nella
toilette del treno non è un atto di comunicazione
ma al contrario un atto di ostilità, la creazione di un
vortice comunicativo in cui qualcuno, prima o poi,
possa essere risucchiato. Eppure, anche sapendo tutto questo, si
continua a leggere. Più di una volta capita persino di cadere nella
stupidissima trappola della frase "scemo chi legge", variante più
volgare del giuramento estorto a Cidippe. Chiunque di noi è stato
legato almeno una volta, come la vittima di Aconzio: se non da un
giuramento d'amore, almeno dalla propria ingenuità di lettore. La
lettura è un obbligo,
un'attività compulsiva. Bisogna leggere, tutto e fino in fondo. Per
questo motivo molte persone non riescono neppure a lasciare un libro a
metà.
Una volta che hanno cominciato a leggerlo debbono finirlo, altrimenti
il libro diventa insopportabile come un rimorso.
E se lo hanno rimesso nello scaffale, per non vederlo più, dopo qualche
giorno i loro occhi vengono catturati dal titolo scritto sulla costola
- proprio come accade con
l'insegna "Alimentari" o con la pubblicità delle automobili - e sono
costretti a riprenderlo in mano per finirlo. E' come se ogni libro
iniziato si
trasformasse automaticamente in un debito. Si può pagarlo in contanti,
subito, oppure un tanto al mese. Ma c'è comunque l'obbligo di saldare.
Forse tutto questo accade perché a
leggere si impara a scuola, sotto la sorveglianza di un maestro. I
primi voti, le prime punizioni, i primi elogi li riceviamo in relazione
alla
lettura. Così la capacità di decifrare le lettere dell'alfabeto si
mescola indissolubilmente con il senso del dovere e con l'obbligo di
obbedire ai superiori. Leggere bisogna, leggere si
deve.
La condizione di colui che impara, quella del discipulus, porta il nome
di disciplina, ma disciplina è anche l'educazione all'obbedienza.
Per questo ogni volta che all'orizzonte compare una fila di caratteri
scatta l'obbligo di leggerli: si obbedisce, come se fossimo ancora
sotto l'occhio del maestro. Non lo facciamo per
rispetto alle frasi che si vedono o ai libri che si leggono, spesso del
loro contenuto non ci importa nulla. E anzi, se potessimo prevedere in
anticipo il significato delle frasi che si stanno per leggere spesso
non le guarderemmo neppure. Proprio come Cidippe, che sdraiata sul suo
letto di dolore continua a ripetere "se solo
avessi immaginato che cosa stavo per leggere!" Le ho ben raccontato
della frase "scemo chi legge", e della generale impossibilità di
sottrarsi
a questo stupido trabocchetto. Ma sapere che leggere è una disciplina,
un imperativo a cui è impossibile sottrarsi, non è riuscito a consolare
Cidippe. La
scrittura è una trappola. E colui che la tende, sia esso Aconzio, il
pobblicitario o l'ignoto che scrive graffit i sui muri, non sfrutta
solo la curiosità o la debolezza altrui. Molto spesso fa leva
addirittura sui sentimenti migliori di una
persona, come l'educazione, la franchezza o la generosità.
Tutte le volte in cui si vede una frase scritta da qualche parte è come
se, improvvisamente,
uno sconosciuto si mettesse a parlare di fronte a noi. In questi casi,
la prima reazione è quella di chiedere gentilmente "scusi, sta parlando
con me?" Quando ci si accorge che
l'altro stava semplicemente parlando da solo, o con qualcuno dietro di
noi, è troppo tardi, il contatto è già stabilito. Le frasi scritte sui
muri, le insegne, i manifesti hanno il potere di attirarci in un
dialogo a cui non avevamo nessuna intenzione di partecipare e che in
realtà non riguardava specificamente noi. Ma quando la scrittura è
riuscita ad
acchiappare un interlocutore lo lega a sé, come ha fatto Aconzio con
Cidippe. Anche i libri funzionano alla stesso modo.
I libri legano, proprio come
il giuramento che Cidippe ha pronunziato senza accorgersene e come la
goffa frase "scemo chi legge". Se io ora scrivessi su un muro o su una
mela "Stendhal chi legge", oppure
"Giuro per Artemide di non sposare altri se non Lev Tolstoj", credo che
molti resterebbero meravigliati. O forse offesi. Non si possono
paragonare
i capolavori della letteratura con dei giochetti di innamorati o peggo
ancora con le stupidaggini che qualcuno scrive nelle toilettes. Eppure
sono sicuro che coloro i quali hanno
letto Il rosso e il nero o Guerra e Pace capiscono perfettamente a cosa
mi riferisco. Non si legge impunemente. Chiunque si accinge a leggere
un
libro deve sapere che alla fine avrà contratto un legame indissolubile
con ciò che ha letto, diventandone addirittura prigioniero. Purtroppo
questo accade non solo
con i grandi libri ma anche con quelli piccoli. E persino con i romanzi
da supermercato, che catturano lettori per la stessa assurda
compulsione
che ci costringe a leggere la frase incisa su una mela. Ai libri si
obbedisce come a qualsiasi altra trappola tesa dalla scrittura. Perché
leggere è una disciplina.
Nel frattempo Cidippe è morta.
Nessuno saprà mai di
preciso quante stazioni radio contenga la gamma di un sintonizzatore.
Solo scorrendo da un grado all'altro, nello
spazio di un millimetro, si può passare da un concerto di Mozart alla
pubblicità dei pannolini. Basta ruotare la manopola con la punta del
dito e il mondo cambia
radicalmente. Si fa serio, idiota, allegro, rumoroso, oppure talmente
appassionante che dispiace perdere anche
una sola parola per colpa di un'interferenza. Con i libri è lo stesso.
Specie se c'è di mezzo il sentimento dell'amore. I libri hanno il
potere di sintonizzare, come la manopola della radio. Non credo che
siano in grado di produrre direttamente l'amore, come pensano
alcuni, ma hanno sicuramente il potere di intonarlo. Rendendolo serio,
idiota, allegro, rumoroso, e via di questo passo. Ma non solo. I libri
hanno
il potere di mutare vestiti e cappelli degli amanti, inducono a
passeggiate per vialetti ombrosi o a corse in motocicletta.
Suscitano persino determinate parole che alla fine, sotto la pressione
più o meno conscia dei libri, sono finalmente pronunziate. Che gioia! E
se non sono
effettivamente pronunziate vengono in qualche modo intuite dietro i
discorsi dell'amato, il quale intendeva magari parlare di tutt'altro.
Una lode dei
gabbiani, per favore! Da giorni sto aspettando il momento in cui mi
dirai che tu andrai dove ti porta il cuore o che il tempo ha il
movimento reversibile di uno yo-yo. Naturalmente
la qualità delle parole attese o pronunziate dipende fortemente da
quella dei libri che si leggono. Così, in un mare di discorsi
quotidiani, contraddittori, pratici, i libri hanno la virtù di
sintonizzare la
frase ritenuta giusta facendo dimenticare tutto il resto. Sospetto che
i libri possano persino intonare tratti del viso ed espressioni degli
occhi, per non
parlare di momenti ancora più intimi. Naturalmente, tutto questo accade
anche con le canzoni. Che sono i libri di quelli che non leggono. E se
la sintonia non funziona? E' molto
brutto, come quando l'altoparlante si mette a gracchiare per una
interferenza e non si capisce più quello che si ascolta.
Cominciano allora i malintesi, le incomprensioni, le attese frustrate,
e l'amore finisce in reciproche accuse di volgarità.
Come sei banale, che animo meschino! Cioè diverso dai libri. Quando
vanno a impigliarsi nella vita, i libri possono produrre grande
felicità ma anche molta amarezza. Per forza,
sintonizzare l'amore sui libri equivale ad affrontare un viaggio in
automobile seguendo un bollettino di radio-informazioni relativo ad una
strada diversa
da quella che si sta percorrendo. Qualche indicazione potrà anche
coincidere perché, in una strada come nell'altra, ci saranno pur sempre
degli incidenti o dei lavori in corso. Ma almeno la destinazione finale
sarà per forza diversa da quella che ci si aspettava. Per questo motivo
ho deciso di raccontare una storia in cui l'amor di libri si è svolto
in modo del tutto opposto rispetto a come l'ho descritto finora.
Opposto e molto
più felice. L'ultima volta ci siamo incontrati a Parigi, ammesso che il
nostro possa essere considerato un incontro. Lei infatti non c'era, io
nemmeno. Al
mio posto avevo mandato Odette Swann mentre lei, al suo, aveva inviato
Julien Sorel.
E' sempre stato così fra noi. Ci davamo degli appuntamenti poi,
all'ultimo momento, io mandavo una donna al mio posto e lei mandava un
uomo al suo. Dopo di che entrambi tornavamo a sdraiarci sui nostri
rispettivi lettini, in spiagge remote
e lontane l'una dall'altra, oppure spengevamo la luce per addormentarci
da soli. Come tutte le storie
d'amore anche la nostra ha un inizi o preciso. Si sa sempre quando
l'amore scocca, a volte addirittura dopo mesi o anni che
ci si conosce - può essere in bicicletta, mentre si segue una donna che
pedala in salita; oppure
al ristorante, mentre lui scuote la testa in un certo modo rivolgendosi
al cameriere. Il mio caso però è diverso perché
io mi sono innamorato di lei la prima e unica volta che l'ho vista.
Oltretutto di sfuggita, non sono neppure sicuro del fatto che fosse
davvero lei la
donna che ho incontrato. Quella sera ero andato all'Opera all'aperto,
davano la Lucia di Lammermoor. La notte
era bella, fresca, di metà Luglio, e quando Lucia tese le mani a
Edgardo, nel parco di Ravenswood, lei si alzò
di scatto e volle uscire dalla fila. "Verranno a te sull'aure..." Per
me questo è il momento più bello di tutta l'opera. La sala era sospesa,
come in sogno, al filo
della melodia, ma io guardavo solo lei. Passando mi sfiorò col gomito,
era piccola, sottile, quasi un'adolescente, e aveva il
volto segnato di lacrime. Come l'ho amata, in quel momento! Anche nei
giorni seguenti la sua immagine continuò a ossessionarmi, cercai
persino di telefonarle. Non era in casa. Alla fine le inviai un
biglietto per dichiararle il mio amore. Sono pazzo di te, le dicevo, le
tue lacrime,
all'opera, hanno scavato un solco nel mio cuore. Vediamoci. Quanti anni
hai? Sedici? Trentacinque? Non importa. Ti aspetto in
Scozia, al Castello di Ravenswood, lunedì 25 Novembre alle sei e mezzo.
Non ero mai stato così emozionato. Dentro
di me vissi la scena di quell'incontro - noi due nel parco di
Ravenswood, in una sera umida - almeno mille volte.
Poi non ricordo più che cosa successe, contrattempi, forse addirittura
malumori. Era un periodo
difficile per me. Pensai che l'aria fredda e asciutta delle Alpi mi
avrebbe fatto bene, prenotai una stanza
a Davos Platz e andai una settimana a sciare sulla montagna incantata.
Il volo per la Scozia lo avevo
già prenotato, pensai che al mio posto avrei potuto benissimo mandare
Madame Chauchat, e così feci.
Fu una settimana intensa, la neve, il caldo delle serate in albergo, le
discussioni in sala da pranzo mi avevano
ridato il buon umore. Ma tornato in città, alla vita normale, il
ricordo tornò prepotente. Fu lei a rifarsi viva dopo circa due mesi.
Aveva perso le mie tracce, diceva, e indirizzava la lettera in ufficio
sperando di ricordare bene il nome
della via. Le dispiaceva di non esser potuta venire a Ravenswood, quel
lunedì di Novembre, ma non si era
sentita di fare un passo così decisivo. Amava la Scozia, anzi
l'adorava. Con l'intenzione di
prepararsi al nostro incontro era addirittura arrivata con alcuni
giorni di anticipo e aveva iniziato a visitare i luoghi con
grande diligenza. Poi però erano subentrate l'incertezza e la
malinconia. Giunta a Edimburgo si era
fermata in un Hotel molto gaio, decisa a visitare la città, ma poi le
sue condizioni erano peggiorate. E quel lunedì, invece di
venire a Ravenswood, aveva preferito restare chiusa in camera con i
suoi romanzi preferiti. Al suo posto aveva mandato Tom Jones. Ma
nonostante questo la tempesta nel suo cuore non si era calmata. Adesso
che il tempo era passato, e che il suo ritratto
di signora si era fatto più chiaro, aveva deciso di rivedermi. Sperava
solo che i miei sentimenti per
lei non fossero cambiati, che il tempo non avesse distrutto quello che
lei considerava un amore, l'unico amore,
della sua vita. Sarebbe stata a Trieste, di fronte alla cattedrale di
S. Giusto, giovedì quattordici
Ottobre alle cinque. Per quanto l'avessi amata teneramente, e ancora
continuassi ad amarla, non potevo dire di conoscerla. Per cui, nella
risposta, ritenni opportuno
tacerle il fatto che neppure io ero andato a Ravenswood quel lunedì di
Novembre e che al mio posto avevo mandato Madame Chauchat.
Spero che lei e Tom Jones si siano fatti buona compagnia! mi dissi con
un moto improvviso di ironia. Un sentimento indegno dell'amore, lo so.
Nella lettera che immediatamente le inviai,
all'indirizzo segnato sul retro della busta, le dicevo che i miei
sentimenti erano sempre quelli e che mi sarei precipitato a S. Giusto.
Mancavano
circa quindici giorni all'appuntamento e, come un ragazzo, o un
carcerato, segnai quindici crocette sul calendario.
Mi sembrava che il tempo fosse diventato immobile come un macigno. Quel
giovedì di Ottobre salii sul treno alla sei di mattina, non volevo
rischiare di arrivare in ritardo. La giornata era brutta, fuori dal
finestrino c'erano solo acqua e lampi. Alla stazione di Bologna il
treno si fermò per circa un'ora a causa di una
tempesta di vento, poi fummo deviati verso l'interno. L'idea era che,
giunti che fossimo a Milano, i viaggiatori diretti a Trieste avrebbero
potuto
prendere un espresso diretto a Zagabria e raggiungere finalmente la
loro destinazione. Ma quando il nostro
treno, che per la bufera viaggiava praticamente a vista, entrò nella
Stazione di Milano, l'espresso per
Zagabria era già partito. Tutte le linee erano sconvolte, all'ufficio
informazioni, preso d'assalto da una folla di
disperati, seppero consigliarmi soltanto di aspettare una coincidenza
che, forse, ci sarebbe stata nel pomeriggio.
Ammesso che gli scambi avessero ripreso a funzionare entro un'ora
ragionevole. Cominciai a disperare di poter
raggiungere in tempo Trieste. E lei dov'era, in quel momento? Forse
come me era bloccata da qualche parte,
e provava la stessa ansia che provavo io. La pioggia continuava a
scendere a torrenti, a tratti si mutava
persino in grandine. Mi infilai nella libreria della stazione e
acquistai una copia de La Bufera di Eugenio Montale.
Poi mi chiusi nella sala d'aspetto. Montale mi appassionò. Non
conoscevo che una minima parte delle sue
poesie, le avevo studiate a scuola, da ragazzo, ma quelle che leggevo
adesso mi parevano incomparabili. Erano
poesie dell'assenza, della speranza, della vita che comunque trionfa.
Credo che quel pomeriggio, nella sala d'aspetto della stazione di
Milano, si sia consumata una delle
esperienze più importanti della mia vita. Quando finalmente
annunciarono il treno per Zagabria non ebbi la forza di alzarmi dalla
sedia. Non
pensavo più a lei che, stretta nel suo impermeabile giallo, mi avrebbe
atteso invano passeggiando di fronte a S. Giusto. Al mio posto mandai
Clizia, e non ci pensai più. I nostri rapporti si fecero sempre più
complicati. Lei
tornò a farsi viva ma, contrariamente a quello che mi aspettavo, non
fece menzione dell'appuntamento mancato. In seguito mi avrebbe
confessato che anche lei era rimasta bloccata dalla bufera, quel lunedì
di Ottobre, e al suo
posto aveva inviato Zeno Cosini. In compenso, nel suo biglietto
alludeva con insistenza a una mia lettera che,
diceva, l'aveva sconvolta, eppure le aveva procurato attimi di felicità
inaudita. Rimasi sconcertato: io
non le avevo scritto. Forse mi confondeva con qualcun altro? o lo
faceva per farmi ingelosire? Riportava anche alcune
frasi di quella lettera che indiscutibilmente erano mie, o perlomeno
erano scritte nel mio stile. Ma
soprattutto come faceva a sapere che io, nel frattempo, avevo
conosciuto un'altra donna? Che avevo creduto
di esserne innamorato ma poi, quando si era veramente trattato di
decidere, l'immagine di lei vestita di
un impermeabile giallo mi aveva convinto del fatto che l'altra non
aveva nessuna importanza per me? Cominciai a non capire più. Risposi
con un biglietto molto interlocutorio. Parlavo dell'altra definendola
"quella signora" e suggerendo la
possibilità che si fosse trattato solo di un'amicizia, di una
frequentazione che aveva giovato molto alla mia
educazione sentimentale. Lei mi rispose con un telegramma in cui mi
chiamava Tancredi Falconeri, io ricominciai a frequentare
assiduamente l'altra. Dopo sei mesi la sposai. Adesso la mia vita è
molto più serena di prima, ma questo non è
bastato a farmi dimenticare di lei. Fra noi c'è un rapporto talmente
singolare che per molti anni
non sono stato capace neppure di descriverlo. Ma col tempo e con la
maturità penso di aver capito in che cosa
consiste. La passione è finita, forse è finito anche l'amore, ma io
continuo ad abitare i suoi libri e lei continua ad
abitare i miei, proprio come il primo giorno.
Siamo rimasti imprigionati nei reciproci caratteri a stampa, un po'
come accade quando si sale la scalinata di Trinità dei Monti e si resta
inquadrati, senza saperlo, nelle istantanee dei turisti. Chissà in
quanti album la nostra immagine spunta dietro una sposa, o accanto a un
giapponese col berrettino in testa, e noi non lo sapremo mai. Così è
accaduto a me e a lei fin
dall'inizio. Ci siamo impigliati l'uno nei libri dell'altro e col tempo
le nostre vite si sono strette sempre di più: anche se
di libro in libro io capisco sempre meno chi sono, e lei altrettanto.
"La malattia di Natascia" mi ha scritto
recentemente "non desta più preoccupazioni, e mi sento molto sollevata.
Ieri l'ho udita riprendere i suoi solfeggi,
nella stanza delle bambinaie, erano mesi che non sentivo la
sua voce. Vieni, ti prego, affrettati, lei
non fa che rammentare il suo Pierre..." Perché mai dovrei affrettarmi?
Non so neppure di quale Natascia stia parlando.
Ma non ha importanza, ho deciso che andrò. Tanto so già che, all'ultimo
momento, io
dimenticherò Natascia e, al mio posto, manderò Andromaca o la bella
Hélène. Le nostre immagini vanno ad
impigliarsi sempre più lontano da noi due ma ad ogni equivoco, ad ogni
appuntamento mancato, il nostro amore invece di
indebolirsi si rafforza. Forse è perché noi ci amiamo dovunque e in
qualsiasi momento. Anche nei
ritagli di tempo. "Stasera ti porterei con me in una casa di campagna"
le ho scritto in
un recente messaggio "ma di quelle che conosco io, con il vento che
fischia fra i rovi e la luna gialla. Ti
stringerei fra le braccia in una stanza che odora di pietra, e
accenderei il camino. Là non ci sono
né automobili né sirene, non c'è gente che grida".Credo che lei
leggendomi si sia messa a ridere, come se
fosse contenta. Ma per quanto la conosco in quella casa non
ci verrebbe mai, il buio e la solitudine le hanno sempre fatto
paura. "Anche le lenzuola" ho continuato "sono diverse in case come
quelle. Hanno la trama ruvida del
lino, e benché siano più di dieci anni che le donne non mettono più lo
spigo nell'armadio, un po' di
profumo resta. Ti terrei stretta a me, nel buio, e ascolteremmo i
grilli. Vuoi venire?" Lei continuava a ridere. Tanto era solo
il capitolo di un libro. Anzi, era addirittura la pagina strappata da
un settimanale che lei aveva trovato
in fondo al sacchetto della spesa. "Amore" continuavo "vuoi venire con
me in quella casa?" "Sì" rispondeva lei
finalmente "ci vengo..." Tanto erano solo parole, scritte e lette.
Anche il profumo di spigo, anche il
sussulto del gufo in mezzo ai rovi. Era uno dei tanti frammenti di
lusinga che io le ho concesso - per essere proprio
esatti - fra il negozio del panettiere e la porta di casa
sua.
Robert Woodruff decise di
lasciare la Scozia per l'odio che
portava a un bicchiere. Era un bicchiere di cristallo rosso,
sfaccettato, che abitualmente stava sulla scrivania
vicino a una bottiglia di Porto. Ma ogni volta che Woodruff apriva
l'Odissea e cominciava a leggere, l'immagine
di quel bicchiere gli si piazzava in mezzo alla mente e non se ne
voleva più andare. Woodruff aveva provato
a toglierlo dalla scrivania, aveva persino smesso di bere Porto e aveva
nascosto la bottiglia in un
armadio. Ma non c'era niente da fare, quel bicchiere si era
indissolubilmente legato all'Odissea e, si trovasse o
meno sulla scrivania, tornava a farsi vivo ogni volta che Woodruff
ricominciava a leggerla. Il caso era singolare. Se Woodruff apriva
l'Eneide di Virgilio o le Metamorfosi di Ovidio il bicchiere non si
manifestava. In quei casi poteva
continuare a leggere anche per ore, indisturbato, mentre la sua mente
vagava nel campo dei Troiani o contava
diligentemente le lunghe e le brevi dell'esametro. L'apparizione si
verificava sempre e soltanto in
relazione all'Odissea. Probabilmente era accaduto che l'immagine del
bicchiere, come un sigillo che si imprime
sulla cera molle, aveva impressionato la sua fantasia proprio una volta
che stava leggendo l'Odissea. E
adesso quel bicchiere faceva parte del libro. Ma questa spiegazione,
anche se probabile, non riusciva a
consolare Woodruff. Desiderava leggere l'Odissea, non le Metamorfosi di
Ovidio. Oltretutto, nel caso di
Woodruff il bisogno di leggere l'Odissea era talmente
profondo che per lui l'assenza di quella lettura si era
trasformata in una sorta di consunzione.
Non sorrideva più, non parlava, e Madigan, il suo cameriere, era molto
preoccupato per la salute di
Woodruff. Madigan non immaginava certo che la colpa fosse tutta di quel
maledetto bicchiere. Ma se anche
l'avesse saputo, come avrebbe potuto aiutare il suo padrone? Nonostante
la malinconia causatagli dall'immagine del bicchiere,
Woodruff non riusciva a privarsi completamente della sua Odissea. A
volte provava timidamente a
riprendere in mano il poema, incredulo lui stesso sulla tenacia della
propria mania, ma quando giungeva al momento
in cui il volto di Ulisse si riga di lacrime, alla corte dei Feaci,
accadeva immancabilmente che l'eroe si
nascondesse non dietro il proprio mantello ma dietro un bicchiere; e
quando il Ciclope, ormai cieco,
tastava il suo capro chiamandolo "caro", sotto la pancia dell'animale
non stava aggrappato Ulisse ma un
bicchiere. Persino le riflessioni più care a Woodruff, quelle sulle
formule omeriche e sull'origine orale, non
scritta, del poema, erano continuamente turbate dal caratteristico
lampo rossastro che accompagnava la sua
visione. Prendere appunti gli era diventato impossibile. "La formula «e
quando l'Aurora dalle dita
di rosa» viene ripetuta in contesti diversi" annotava Woodruff a
margine della sua copia dell'Odissea "con lievi
variazioni, e questo significa...." bicchiere, bicchiere, bicchiere.
Era diventata un'ossessione. Lo sfortunato Robert Woodruff stava
scoprendo a sue
spese i pericoli e la fragilità della lettura. Su questo tema cominciò
a riflettere con sempre maggiore attenzione.
Almeno in apparenza leggere un libro costituisce un'operazione banale.
Basta avere una buona confidenza con i caratteri
dell'alfabeto e le parole scorrono sotto gli occhi una dopo l'altra.
Chiunque, sembrerebbe, può
leggere un libro, basta che non sia analfabeta. La realtà delle cose
invece è molto diversa, e il
processo enormemente più complesso. La lettura implica infatti il
trasferimento di un intero mondo, fantastico e astratto,
dentro l'esiguo spazio di una biblioteca o di una stanza privata.
Contemporaneamente essa richiede anche l'oblio
completo di tutto ciò che sta intorno a questo mondo di finzione. Ma
come si può pretendere che la vita
reale non si prenda qualche volta la sua rivincita, e non intrometta i
propri oggetti quotidiani dentro la
lettura? La tradizione editoriale si è sforzata in ogni modo di
trasformare i libri in oggetti piatti, monotoni, ripetitivi, proprio
per far sì che
niente venga a turbare il fragile miracolo dell'esistenza alfabetica. I
caratteri sono tutti rigidamente uguali
l'uno all'altro, il formato dei fogli non muta, e pagina dopo pagina il
numero e la lunghezza delle righe restano sempre gli
stessi. Tutto questo viene fatto con lo scopo di rendere il libro, e lo
scritto, così perennemente identico a sé
stesso da diventare a un certo punto trasparente fino a scomparire. In
questo modo il lettore finisce per dimenticare
che, tutto ciò che vive e sente leggendo, in realtà è solo una
convenzionale costruzione di
caratteri alfabetici.
A volte la monotonia dei caratteri e della loro immutabile successione
può essere interrotta da
alcune illustrazioni - nell'Odissea di Woodruff, per esempio, c'era un
bell'Hermes neoclassico col profilo
netto e le alucce color seppia - ma queste immagini non sono fatte per
distogliere la mente dalla lettura. Anzi,
esse favoriscono la concentrazione sul mondo immaginario che le lettere
laboriosamente costruiscono nella
mente del lettore, suggerendogli l'impressione di vivere e vedere, non
di leggere. Se si può rendere
sottile e trasparente il libro, fino ad annullarlo, è però impossibile
fare altrettanto con il suo contesto. Attorno al
libro staranno pur sempre voci ed oggetti, e per quanto il
bibliotecario imponga il silenzio nella sala o il lettore tenga
ordinata (cioè a dire spoglia) la propria scrivania, qualche cosa, da
fuori, finirà pur sempre per scivolare
dentro. Come quel bicchiere. Il libro è vulnerabile e, in qualche modo,
permeabile perché non ha né contesto né supporto
fuori da se stesso. Si regge solo sull'energia che si sprigiona dalla
successione dei suoi
propri caratteri - una "a" che si oppone a una "m", una "o" a cui segue
una "r", poi una "e", e così all'infinito - come un
complicato castello di carte da gioco che sta in piedi solo perché
ciascuna carta, premendo, impedisce
la caduta dell'altra. Ma non c'è niente all'infuori di questo,
l'impalcatura del libro è tutta interna. E poi,
bisogna pur riconoscere che a volte insensibilmente, e malignamente, il
libro cerca di sua volontà un contesto esterno su
cui appoggiarsi. Specie quando la concentrazione è minore, la lettura
può decidere tacitamente di
puntellarsi sull'imprecazione di un passante o sull'ambiguo odore della
tappezzeria. Oppure sulla superficie brillante di un
bicchiere, come era accaduto a Woodruff, il quale aveva evidentemente
l'abitudine di sorseggiare Porto mentre
leggeva l'Odissea. Il libro non è una creatura così pura ed ingenua
come lo si raffigura.
Rassomiglia piuttosto a un gentiluomo bene educato - anche Woodruff del
resto lo era - che però, di nascosto,
coltiva l'abitudine di frequentare i bordelli. Quando un libro prende
questa via, che è una via di
distrazione e di perdizione, e soprattutto quando il lettore se ne
accorge in modo
così evidente, l'unico rimedio possibile consiste nel prendere una
decisione netta. Per questo Robert Woodruff, incapace
di sopportare oltre l'interferenza di quel bicchiere con la sua lettura
dell'Odissea, abbandonò bruscamente la
Scozia per recarsi in Grecia. Il suo cameriere, Madigan, avvertito
all'ultimo momento, ebbe appena il
tempo di preparare come poteva alcuni bauli e di condurre la carrozza
di fronte alla porta della villa. Era
l'alba, ma Woodruff lo aspettava già nel vialetto con aria cupa e
impaziente. Dalla tasca della sua lunga
giacca da viaggio sporgeva una copia dell'Odissea.
Padrone e cameriere sbarcarono al porto del Pireo in una bella giornata
del Giugno 1776. L'aria era profumata, e in lontananza la luce dei
marmi quasi feriva gli occhi con
il suo candore. Dunque era quella la Grecia, la patria degli dei. Una
terra piena di origano e di sole, dove ogni pietra serba memoria
dell'antico splendore e le api producono il miele
della poesia. Madigan stesso, che per la verità era abbastanza
ignorante, sembrava percepire tutta l'emozione
che quella terra e quel cielo ispirano ad ogni animo sensibile. Per cui
fu doppiamente sorpreso
quando scoprì che il padrone, nonostante la sua passione per l'arte
antica, non aveva nessuna intenzione di
visitare Atene. Scesi che furono sulla banchina del porto, infatti,
Woodruff lo pregò di cercargli al più presto un
imbarco per Itaca. Madigan tentò timidamente di farlo ragionare,
dicendogli che la Scozia era
molto lontana e che diffici lmente nella sua vita gli sarebbe capitata
una nuova occasione per scendere fino ad
Atene e vedere la città. Ma Woodruff non volle sentire ragioni, e
giunse quasi a minacciare il povero
cameriere. Il lungo viaggio e la visione della Grecia, evidentemente,
non avevano esercitato alcun effetto benefico
sulla malinconia del padrone. Madigan, rassegnato, cominciò a cercare
il nuovo imbarco che Woodruff tanto
ansiosamente desiderava. Ma ottenerlo non era facile, perché l'isola
era lontana e nessun marinaio aveva
voglia di spingersi fino laggiù per trasportare due soli passeggeri.
Finalmente si trovò un capitano
che, per una somma di sterline invero abbastanza alta, accettò di
condurre i viaggiatori fino all'isola di
Ulisse. Quando? chiese Woodruff. Non prima di questa sera, rispose il
capitano. Woodruff, che non nascondeva la
sua fretta di salpare, rimase in silenzio per l'intera giornata. E
dedicò il suo tempo a studiare una mappa di
Itaca che aveva portato con sé dalla Scozia. Finalmente giunse la sera.
Cominciò a spirare un vento fresco,
prima leggero poi sempre più intenso, e il capitano dette il segnale di
sciogliere le vele. La piccola nave si
mosse e dopo poco più di un'ora la costa era completamente scomparsa
nel crepuscolo. Attorno non si vedeva altro che
mare. Fu allora che Woodruff, come se si fosse liberato da un peso,
estrasse dalla tasca la sua copia
dell'Odissea e sorrise. Madigan non ricordava che il suo padrone avesse
più sorriso da almeno due
anni. Woodruff sorrideva, beato, e ammiccando verso il capitano gli
chiese quando prevedeva di arrivare.
"Non prima di domani pomeriggio, se il vento tiene" "Va bene" rispose
Woodruff "va molto bene". Poi si
sedette a prua su un mucchio di funi e cominciò a fissare intensamente
il mare. La sera si faceva
sempre più piena di stelle. All'alba Madigan, che non aveva sentito
Woodruff scendere
sottocoperta, salì sul ponte a cercarlo. Lo trovò seduto nella stessa
posizione in cui l'aveva lasciato la sera prima. Il
padrone dichiarò che aveva dormito qualche ora all'aperto, coprendosi
con una vela, ma era falso.
Non si era mai mosso da dove stava, e aveva contemplato il mare per
tutta la notte. Quando Madigan gli
domandò se avrebbe gradito una tazza di caffé, Woodruff gli fece un
ampio gesto con il braccio e disse semplicemente:
"E' colore del vino" "Che cosa?" chiese Madigan meravigliato "Il mare
pescoso" rispose Woodruff. Poi
tirò fuori l'Odissea dalla tasca e si mise a leggere, continuando a
fare ogni tanto dei gesti con la mano e
pronunziando frasi che a Madigan suonavano alquanto singolari. "Dalle
dita di rosa, figlia della luce"
oppure "e lei di nuovo si immerse nel mare ricco di onde, come una
folaga..." Erano da poco passate le quattro del
pomeriggio allorché il capitano venne ad informare i passeggeri che
Itaca era in vista. Ma Woodruff se n'era già accorto e stava dicendo a
Madigan, indicandogli la costa che si
avanzava a prora: "è aspra, non adatta ai cavalli..." Al tramonto la
piccola nave attraccava nel porticciolo dell'isola. L'umore di Woodruff
era, se possibile, ancora più lieto di come era stato durante tutta la
giornata. Adesso sembrava che non avesse più fretta. Accettò che
Madigan contrattasse una sistemazione abbastanza comoda nella casa di
un pescatore ricco, poi passeggiò
tranquillamente per le vie del minuscolo borgo, scambiando sorrisi e
cenni del capo con tutti quelli che incontrava.
La sera cenò abbondantemente e fu simpatico con Madigan, concedendogli
una confidenza a cui non si abbandonava
facilmente. Woodruff raccontò delle sue avventure nell'esercito, delle
donne che aveva
conosciuto, e Madigan, seppure con discrezione, fece capire al padrone
di esserne al corrente, visto che in
Scozia la sua fama era già considerevole. Woodruff continuava a ridere
e a raccontare, sempre più
allegro. Ma quando l'ignaro cameriere, credendo di fare cosa gradita al
padrone, estrasse dalla valigia
di cuoio una bottiglia di Porto e un bicchiere di cristallo rosso, quel
famoso bicchiere, Woodruff impallidì.
La conversazione cadde bruscamente e Madigan ebbe l'impressione che il
padrone fosse sul punto di piombare nuovamente
in uno di quegli attacchi di malinconia che tanto spesso lo avevano
colto negli ultimi tempi.
Ma fu solo un attimo. Woodruff si riprese rapidamente e, indicando il
bicchiere, pronunziò questa frase:
"coppa di vino, da bere quando il cuore mi inviti". Poi disse che era
stanco e preferiva andare a dormire.
Il giorno seguente avrebbero cominciato ad esplorare l'isola. Così
avvenne, infatti, Woodruff e Madigan trascorsero l'intera giornata
camminando per sentieri scoscesi e cespugli di timo. Aiutandosi con la
sua mappa, Woodruff riuscì finalmente
a raggiungere un luogo che aveva individuato come l'antico Antro delle
Ninfe. Qui volle sostare a lungo, seduto
su un masso, mentre Madigan si faceva vento col cappello di paglia e
beveva limonata dalla borraccia.
Woodruff lesse e rilesse il passo dell'Odissea in cui era descritta la
grotta, declamò al cameriere
la storia di come Atena fosse apparsa ad Ulisse simile a un giovane
pastore, narrò dei lebeti e dei tripodi
preziosi. Poi fu la volta delle rovine della reggia di Ulisse - o
almeno, di quelle che Woodruff aveva individuato come
tali servendosi sempre della famosa mappa. Probabilmente erano solo i
resti di antichi muri a secco, o
di uno stallo per animali. Battendo palmo a palmo il terreno del
recinto Woodruff dichiarò di aver trovato
persino il vecchio ceppo di olivo su cui Ulisse e Penelope avevano
fabbricato il loro intrasportabile letto. Madigan
vedeva il suo padrone in piedi su quel ceppo mentre, con un sorriso
malizioso, gridava: "Oh donna, davvero è doloroso quello che dici. Chi
ha spostato altrove il mio letto?" Woodruff era felice. Era bastato
venire a leggere in situ, nel medesimo ambiente presupposto dalla sua
Odissea, e il famoso bicchiere aveva smesso di piazzarglisi in mezzo
alla
mente. Adesso egli sentiva tutta la forza del libro, non più fragile,
permeabile ad ogni interferenza esterna, ma capace di imporsi lui sulle
cose e di modificarne il significato. Il presente era diventato una
semplice incrostazione di cui il libro, con il suo potere risolutivo,
non faceva fatica a liberare l'essenza della realtà. Woodruff era
sempre più sicuro del fatto suo. Dove tutti i pescatori di Itaca
vedevano solo una spiaggia lui aveva individuato con certezza il porto
di Forchis, il luogo in cui era
sbarcato Telemaco. Mentre una vecchia colonna di pietra, residuo forse
di qualche rozza cappella bizantina, era stata
identificata come il pilastro a cui Eumeo e Filezio avevano appeso il
traditore Melanzio. Poi toccò
alle rovine di un ovile sperduto fra i monti, in un luogo che i pastori
frequentavano malvolentieri perché dicevano che era abitato dalle
donnole e dagli spiriti delle Nereides. Ma Woodruff aveva individuato
lassù i resti della capanna del fedele Eumeo. Al termine di ogni
escursione Woodruff, sedendosi nell'erba o
appollaiandosi su uno scoglio battuto dal maestrale, con i capelli nel
vento, leggeva la sua Odissea. Nessuna
interferenza veniva più a turbare dall'esterno la dolce e lineare
coerenza delle lettere dell'alfabeto, e
anzi erano loro, le lettere, che lasciavano le pagine per posarsi sulle
rovine e sui paesaggi: come uno sciame diapi laboriose, avrebbe detto
Omero, che
fuggite nel bosco rapidamente coprono le fronde di una quercia col
brulichio delle loro ali e costruiscono
un nuovo alveare. Woodruff decise di rimanere per sempre a Itaca.
Madigan, dopo aver tentato inutilmente di dissuaderlo dal suo proposito
e di convincerlo a ritornare in patria, si separò
piangendo dal suo padrone e dopo un anno esatto dal loro arrivo riprese
tristemente il mare verso il Pireo e
verso la lontana Scozia. Woodruff continuò a cercare luoghi per leggere
l'Odissea e a trovarne ovunque, in piedi,
seduto, sdraiato fra le greggi del Ciclope, contemplando le vacche del
Sole che scampanavano allegre lungo
una valletta in faccia al mare. Trascorse anche indimenticabili
giornate con Calipso, nella grotta di
un pastore, finché Hermes non venne a spiegargli che avrebbe fatto bene
a smettere e ad andarsene da
lì al più presto. La gente del luogo si era abituata alla sua presenza,
benché a volte guardasse con
curiosità, e persino con ironia, quell'uomo con la lunga giacca che
leggeva in continuazione il suo libro recitando strane
formule. E quando Woodruff morì l'intero borgo si raccolse attorno alla
sua salma.
Molte donne, con indosso lo scialle del lutto, si colpirono il petto e
versarono
lacrime di pianto. Molti uomini restarono immobili, con gli occhi
asciutti, mentre il canto della prefica
guidava il coro delle piangenti. Erano passati trentadue anni da quel
giorno del 1776 in cui Woodruff, con un gesto del braccio, aveva
indicato a Madigan la costa di Itaca che si affacciava a prora: "è
aspra,
non adatta ai cavalli..." Fu chiamato il Pope dell'isola, che in un
greco certo molto diverso da quello che Wodruff
era abituato a leggere nella sua Odissea, pronunziò l'orazione funebre
per lo scomparso. Il passo
più saliente del suo discorso, forse, fu questo: "Addio Woodruff.
Nessun uomo, a Itaca, riuscirà
più a camminare per i sentieri dell'isola, né a contemplare il
porticciolo che tu chiamavi Forchis, senza che il tuo
libro gli si piazzi in mezzo alla mente".
L'uomo nella pioggia porta
una mantella di tela cerata e un
cappello
floscio.
Sembra il capitano di una nave che sta affrontando la bufera. Io ho
indosso solo la camicia e per la
pioggia
i capelli mi si appiccicano sulla fronte. Stiamo facendo insieme un
tratto di strada, lungo University
Street,
lui non ha bisogno di ombrello, io sì, ma non ho certo il coraggio di
dirgli che preferirei cercare
un
cornicione e aspettare. Ho l'impressione che a lui tutta quella pioggia
piaccia e gli metta addosso un'allegria
quasi
infantile. I coni luminosi dei lampioni sono pieni di fili d'argento.
"Ci sarà pur stato un passaggio,
una
frattura" dice l'uomo nella pioggia mentre continuiamo a camminare
"Almeno nei sogni questo momento corrisponde
per
me all'immagine di un bambino che corre incontro a suo fratello grande.
Nella mano destra
tiene
il sussidiario, nella sinistra il libro di lettura: «Che cosa ci si
deve fare» chiede il bambino
«con
i libri?» E' il primo giorno di scuola della quinta elementare". L'uomo
nella pioggia dice che suo fratello non risponde, e
il
sogno si interrompe. "Fino a quel momento leggere era stato come
camminare o come andare in
bicicletta.
Una volta imparato lo si fa, non ci si domanda perché bisogna farlo o a
che scopo. A
scuola
la maestra mi chiedeva di leggere solo per vedere se ero in grado di
farlo, non c'era altro da sapere. Al
massimo
capitava di imparare a memoria qualche filastrocca. Ma quando
arrivarono i due grossi libri della
quinta
elementare - il libro di lettura pieno di poesie e di prose con le
note, il sussidiario diviso in storia,
geografia,
matematica - si vide chiaramente che le cose erano cambiate. Adesso
bisognava leggere per uno scopo, per fare
qualcosa
con quelle pagine. Che cosa?" L'uomo nella pioggia dice che, nei sogni,
suo fratello grande
non
risponde, ma nella realtà rispose. Ci sono due modi diversi per
studiare i libri, gli spiegò, il primo
consiste
nell'imparare a memoria quello che c'è scritto per poterlo ripetere
pari pari, il secondo nel capirlo e nel
saperlo
ridire con parole tue: devi scegliere tu. L'uomo nella pioggia dice che
da allora la situazione per lui non
è
cambiata. "Che cosa ci si deve fare con i libri?" ancora si chiede.
Come quel bambino del sogno.
Non conosco quell'uomo ma University
Street è lunga diverse
miglia,
anche di notte si finisce sempre per incontrare qualcuno. Quando
abbiamo cominciato a camminare insieme la
pioggia
scrosciava già, e neppure adesso il ritmo accenna a cambiare. Potrebbe
durare per sempre. "E lei
cosa
ci fa, con i libri?" mi chiede bruscamente. Non rispondo. Dovrebbe
sapere che la mia funzione, in
questo
dialogo, è solo quella di ascoltare e di tacere. Ho già le mie
preoccupazioni, con tutte
quelle
pozzanghere da evitare. Oltretutto lui a ogni semaforo rosso si fa
quasi un dovere di attraversare anche se
passa
una macchina, provocando frenate improvvise e schizzi d'acqua e fango.
Per fortuna gli autisti si
limitano
a dare un colpo di clackson o a lanciare qualche imprecazione che la
pioggia rende sorda. "A lungo avevo letto per piacere" continua l'uomo
nella pioggia "Tom
Saywer,
Il Corsaro Nero, Capitani Coraggiosi. Soprattutto mi piacevano le
avventure di mare, con i colpi
di
colubrina e le navi cariche di pirati. Leggevo per il gusto fisico di
fare colazione e leggere, bere latte e
leggere,
dare il primo morso a un biscotto e attaccare il primo rigo del
capitolo. Ricordo benissimo tutti quei
libri,
i nomi dei personaggi, le notti di luna sull'isola, gli assedi dal mare
col lampo delle bombarde sulle mura. A
quel
tempo credevo che leggere i libri rientrasse fra le funzioni
fisiologiche, o meglio fosse un'aggiunta
necessaria,
una seconda voce che si accompagnava al resto della vita quotidiana.
Non mi sono mai chiesto
che
cosa ci si dovesse fare con Capitani Coraggiosi, lo leggevo e basta.
Quando al campo accendevano il
fuoco
e cucinavano la carne sulla brace, era come se mangiassi anch'io. Vede"
continua l'uomo nella
pioggia
"quella per me era come l'età dell'oro. Quando c'era cibo per tutti
senza che si dovessero coltivare
i
campi, c'erano vino e latte perché zampillavano spontaneamente dalla
terra. Gli uomini allora non si
domandavano
che cosa ci dovessero fare con il mondo che avevano intorno, non
pensavano né di
trasformarlo
né di sfruttarlo. Ci vivevano e basta. Così era nella mia età
dell'innocenza, quando leggevo i
libri
solo per leggerli, perché c'erano, a portata di mano, e davano piacere.
Poi l'età dell'oro si interruppe
bruscamente.
Forse fu proprio quella la frattura, come nel sogno: il primo giorno
della quinta elementare, quando
qualcuno
improvvisamente mi chiese conto di quello che leggevo. E con enorme
sconcerto mi accorsi che con i
libri
ci si doveva fare qualche cosa. Ma cosa?" Beato lui che ha un
impermeabile e un cappello da marinaio.
Anche se
fosse
al timone, in una notte di tempesta in mezzo all'Atlantico, riuscirebbe
a restare asciutto. Io
invece
sono bagnato come se fossi caduto in mare con tutti i vestiti.
University è una strada talmente
lunga
che sembra non avere mai fine. "Ho letto libri noiosissimi solo perché
li sentivo nominare a scuola o li
trovavo
nella biblioteca di casa. Se tutti dicevano che bisognava leggerli, e
se quei libri esistevano, come potevo non
leggerli
io? Le Tragedie di Vittorio Alfieri, gli Inni sacri del Manzoni, le
Confessioni di un italiano. Ogni tanto
avevo
la tentazione di smettere ma poi, quando meno me l'aspettavo, mi
imbattevo in un verso o in una frase che
mi
pareva di colpo bellissima. Allora la sottolineavo e cercavo di
impararla a memoria. Forse era per
questo
che si leggevano i libri? Perché contengono delle frasi memorabili? Ma
anche con quelle
frasi
non sapevo che farci. Mi domandavo se bastava saperle per poterle
ridire a qualcuno e far vedere agli
altri
che avevo letto, o se non dovessi piuttosto trasformare quelle frasi in
qualche altra cosa dentro di me.
Ma
non avevo idea di come avrei potuto fare. Era sempre lo stesso dilemma
in cui mio fratello mi aveva
lasciato,
la ragione per cui, nel sogno, non mi risponde. Conosco tante persone
che hanno continuato semplicemente a
ripetere
i libri che leggono, a chiedersi l'un l'altro «hai letto l'ultimo
romanzo di...»
oppure
a citare una frase di un libro famoso per vedere se l'altro la
riconosce. Ma non può essere che i libri esistano
solo
per essere ripetuti o citati. Sarebbe come dire che vengono scritti
solo perché qualcuno possa coniugare un
verbo
e dire «ho letto». In ogni caso oggi sono certo che, in questo modo, i
libri non servono.
Ho
letto tutti i drammi storici di Shakespeare, ma non mi ricordo più
nulla e non saprei citare
più
nulla. La lunghezza degli atti era interminabile, le scene si
succedevano talmente fitte che a un certo
punto
perdevo addirittura l'orientamento. Dove eravamo? Ma io andavo avanti
con avidità, con un piacere
quantitativo
e un po' nauseante (oggi ho letto cento pagine, domani proverò se
arrivo a centocinquanta) e
quando
chiudevo il libro godevo nel vedere il segnalibro che marcava un terzo,
poi metà, e finalmente un
fascio
di pagine talmente grosso da far pensare che ormai ero alla fine.
Ancora poco e avrei potuto dire di aver letto
tutti
i drammi storici di Shakespeare.
Ho ancora quei volumetti in fila su
uno scaffale, in camera da letto,
ma
oggi posso dire di ricordarmi solo il nome Bolingbroke, che mi faceva
pensare a una palla, e una donna detta
Doll
Tearsheet. Nient'altro. La prego" dice l'uomo nella pioggia "non
giudichi troppo male la mia
frenesia
e la mia superficialità di allora. La verità è che mi trovavo di fronte
al muro della vita e
disperatamente
cercavo una breccia per entrarci. Ero convinto che i libri fossero
quella breccia". Figurarsi se io potrei
giudicarlo
male perché leggeva i libri troppo in fretta. A me basterebbe solo che
smettesse di piovere. L'uomo si ferma bruscamente. "Sa che a un certo
punto mi sono persino
provato
a polemizzare con gli autori? A scuola avevo studiato un po' di
filosofia e leggendo L'elogia
della
follia, a diciassette anni, me la prendevo a margine persino con
Erasmo. «In questo modo»
scrivevo
«tu trasformi gli uomini in cani da corsa...» Lo so che è un nota
cretina, ma lo facevo per
disperazione.
I libri mi facevano arrabbiare, non sapendo che cosa farci li criticavo
- forse era per quello che si
leggeva,
per ostilità, per inimicizia, per affermazione di sé? Molti del resto
continuano a farlo tutta la
vita,
e in questa lettura arrogante, più simile a una lotta che a una
decifrazione, pensano di aver trovato la ragione
dell'esistenza
dei libri. Ma io mi sentivo solo uno sciocco. Smisi di polemizzare.
Purtroppo, però, non
riuscivo
più a leggere senza questa". L'uomo nella pioggia tira fuori una matita
da sotto la mantella e me la mette
sotto
il naso. "Persino i libri belli, quelli che mi davano piacere, ormai li
leggevo
sottolineando,
non facevo più distinzione fra Il gattopardo e i romanzi di Gabriele
D'Annunzio. Continuavo a
cercare
delle frasi da citare, che mi facessero fare buona figura quando le
avessi ripetute, oppure delle
frasi
sciocche da segnare con tanti punti interrogativi. A forza di
sottolineare mi abituai a fare confronti e mi
perdevo
dietro a mille analogie. Questo lo dice meglio Thomas Mann, questo sta
già in Proust anche se ad
altro
proposito, qui Tasso in realtà traduce Ovidio. Mi inebriavo di quei
paralleli ma intanto guardavo con invidia
i
miei compagni che studiavano il manuale di anatomia o il trattato di
scienza delle costruzioni. Loro
sapevano
che cosa dovevano farci, con i loro libri, li avrebbero usati per
curare la gente e per fare la case.
Ma
io? Avevo perfezionato la mia capacità circolare di andare da un libro
all'altro, di
confrontare
e criticare, ma era come un gioco di biliardo, con la pallina che batte
quattro sponde e anche di più, se il
giocatore
è bravo a dare il giro.
Usavo i libri per passare continuamente ad
altri libri. Ma non uscivo comunque da
lì".
L'uomo nella pioggia riprende a camminare. E' grande e grosso, nella
sua
mantella di tela cerata, eppure il suo passo ha ancora qualcosa di
infantile, come se da un momento
all'altro
potesse mettersi a correre a scomparire dietro un muretto. University è
una strada molto
lunga
ma so che fra non molto, anche se la pioggia non accenna a diminuire,
arriveremo alla spianata. "Facevo
lunghe
passeggiate, come questa, e parlavo con i miei amici. Ore e ore di
conversazioni defatiganti,
deludenti,
perché loro non leggevano libri o se ne leggevano non ne parlavano, e
non si domandavano perché li
leggevano.
Tornavo a casa esausto e mi rimettevo a leggere. Avevo l'impressione
che la breccia non si aprisse,
anzi,
il muro era sempre più spesso. Avevo creduto che i libri mi avrebbero
aiutato e invece era il
contrario.
Tornavo a casa ed ero solo perché pensavo che i miei amici erano
diversi dai libri che leggevo, e anche
le
ragazze che conoscevo erano diverse da quelle che imparavo dai libri -
le belle Micol, le dolci Sally che
suonavano
il pianoforte, le Marie brune e pensierose che vivevano in case piene
di fiori. Man mano che mi
entravano
dentro, i libri che leggevo mi facevano sempre più simile a loro stessi
e, invece di aiutarmi a
entrare
nella vita, me ne allontanavano. I libri suggeriscono l'esistenza di
tante belle persone che però,
disgraziatamente,
non esistono, e in questo modo spingono circolarmente verso loro
stessi. Si cercano sempre nuovi libri
perché
non si possono frequentare persone simili a quelle che si leggono.
Forse c'è un disegno in
tutto
questo. I libri suggeriscono l'impossibile per poter continuare ad
esistere senza essere disturbati. Come tutte le
caste,
anche quella dei libri tende a mantenersi in vita con tutti i mezzi,
anche i più astuti". Passa un cane, si volta verso di noi,
improvvisamente ha gli occhi
rossi.
L'uomo nella pioggia accenna un movimento brusco, come se volesse
correre dalla sua parte, e il cane
attraversa
la strada con uno scarto. Poi scompare fra le auto di un parcheggio.
"Cominciai a scrivere di
libri"
continua lui "le mie rozze note a margine diventarono saggi e
recensioni. Forse era per questo che i
libri
esistevano, pensavo, per poterne scrivere. Io scrivevo di libri e altri
leggevano quello che scrivevo,
per
potere a loro volta scrivere di me e dei libri di cui scrivevo io. In
un certo senso, gli altri scrivevano per
rispondermi,
come se ci scambiassimo delle lettere sui libri. Credo che sia questa
l'origine di ciò che
chiamano
critica letteraria, il bisogno di fare comunque qualcosa con tutti i
libri che ci sono in giro. Mi accorgevo
che
adesso stavo prendendo l'altra delle due vie che mio fratello mi aveva
indicato da bambino, provavo a ridire
con
parole mie quello che leggevo. Proprio come prima cercavo di imparare a
memoria delle belle frasi da
citare,
per far vedere che avevo letto. Ma crede che così io fossi finalmente
felice?"
Mi stringo
nelle
spalle. Come potrei saperlo? "I libri della mia biblioteca erano
diventati
oggetti da squadernare e scarabocchiare,
li
trattavo con la sicurezza un po' sprezzante con cui un falegname prende
i pezzi di legno di cui ha
bisogno
per costruire le sue scaffalature. Li riempivo di fogli incollati e il
loro volume aumentava smisuratamente.
Accanto
ai libri che usavo, con le copertine gualcite e sformate, cominciai ad
allineare i miei, quelli
che
scrivevo su di loro. Il bisogno di scrivere di libri cominciò ad
attanagliarmi, il tempo non
bastava
mai. Per scrivere di libri bisognava leggerne in continuazione, alla
fermata dell'autobus, nella coda del
supermercato,
in treno. Leggevo per avidità e per possesso, per trasformare quello
che leggevo in una cosa mia. Leggevo
il
giornale abbandonato da qualcuno sulla poltrona a sdraio, nella
certezza che se non lo avessi fatto
subito
quell'occasione non si sarebbe ripresentata mai più. Leggevo in stato
di continua emergenza,
come
si leggono delle istruzioni in codice, alla fine delle quali sta
scritto «adesso inghiotti il
foglio».
A volte" l'uomo nella pioggia abbassa la voce "ho persino rubato per
questo. Quando vedevo un libro che poteva essermi
utile
lo nascondevo sotto la giacca e lo portavo via, per impedire ad altri
di leggerlo e di farne lo stesso
uso
che volevo farne io. Non immagina fino a che punto si può scendere, con
i libri..." Finalmente siamo arrivati alla spianata, la fine di
University
Street.
Un tempo qui c'era la banchina del porto, ma da molti anni questo
tratto di baia è stato interrato.
Davanti
a noi non si vede acqua ma solo una grande distesa di camion e di gru.
La baia è lontana, segnalata appena
dai
rintocchi della campana che nella nebbia guida i battelli verso
l'attracco. Ci fermiamo sotto un lampione.
"Faccio
il conto dei miei anni" continua l'uomo nella pioggia "e
penso a quanti libri potrò ancora
leggere.
Un numero finito. Da ragazzo credevo che i libri fossero infiniti ma
non è vero. O perlomeno, sono
infiniti
i libri che esistono, ma non quelli che si possono leggere. Con che
criterio dovrei scegliere i libri che mi
restano
ancora da leggere? E soprattutto, vale la pena di continuare a farlo?"
Non capisco perché l'uomo
nella
pioggia lo chieda a me. Francamente mi interessa molto di più essere
arrivato alla spianata "Anche
Vittorio
Alfieri se lo era domandato. La sua risposta era che, continuando a
leggere, avrebbe avuto la soddisfazione
di
morire meno asino di come era venuto al mondo. E' una frase molto
spiritosa, non trova? Invece
Seneca,
alla fine della vita, diceva alla Natura: ti restituisco sapendo quello
che mi hai dato quando non sapevo
nulla.
Un modo di mettere le cose molto più dignitoso di quanto non facesse
Alfieri. Belle frasi.
Non
per nulla stanno nei libri. Ma non dicono molto di più se non che
bisogna continuare a leggere libri
perché
vale la pena leggerli". Ho capito che ormai stiamo per salutarci. La
spianata è piena
di
lampioni, per via del parcheggio dei camion. "Ormai ho rinunziato a
capire. Probabilmente i libri sono come Dio, la
loro
esistenza segue dei piani troppo al di sopra della mia mente perché io
possa sperare di
comprenderli.
Forse dovevo leggere dei libri solo perché una goccia di quel loro
succo infinito (infinito come Dio, che è
tutto
in tutto) rifluisse anche dentro le mie vene, e di qui dentro ad altre
vene, in un movimento senza fine. Il
perché
non lo so.
I libri sono come Dio, ci devono essere e basta. Però"
continua l'uomo nella pioggia "io
non
riesco a dimenticare la mia età dell'innocenza, prima che ci fosse
quella frattura del sogno. Quando
leggevo
Capitani coraggiosi e Il Corsaro Nero, quando non avrei mai pensato
che, con i libri..." Sulla spianata c'è un vecchio locale, si chiama
"The Schooner".
Sta
lì dai tempi in cui di fronte alla sua porta c'era la banchina e le
navi a vapore attraccavano per scaricare grano
ed
emigranti. Pur essendo così tardi "The Schooner" è ancora illuminato e
dentro si vedono uomini che
bevono
e fumano. Se si voltano le spalle alla spianata per guardare fisso
verso la porta di legno e la lanterna
di
ottone, simile a quelle delle navi, pare ancora di stare sulla
banchina, con l'acqua della baia che lambisce le
pietre,
e non ai bordi di un parcheggio. L'uomo nella pioggia si toglie il
cappello di tela cerata e mi porge la
mano.
Adesso che lo vedo col capo scoperto, sotto la luce dei lampioni, mi
accorgo che è
bellissimo.
Ha il viso perfetto di un adolescente, gli occhi azzurri, i capelli
biondi e lunghi fino sul collo. Sono talmente
colpito
dalla sua bellezza che quasi non riesco a trovare la mano che mi porge.
"Buona notte" mi dice con un
sorriso.
"Buona notte" gli rispondo con la lentezza stupita di un sogno
"capitano Hornblower".
Alma e Aadan abitano
insieme da circa dieci anni. Alma è
molto
anziana, ma sta bene, e se non fosse che vede così poco potrebbe essere
contenta della sua vecchiaia.
Aadan
è più giovane, anche se non molto, e viene dalla Somalia. Passa le sue
giornate in casa ed esce solo la
mattina
per fare la spesa. Una volta la settimana, se non piove, Alma e Aadan
vanno fuori insieme per guardare
le
vetrine. Aadan le descrive ad Alma, che peraltro sostiene di vederle, e
spesso sembra veramente che
le
veda. A volte ad Aadan mancano le parole e Alma gliele suggerisce, pur
senza distinguere bene gli
oggetti
di cui parlano. "Grande vestito blu" "E' un cappotto" la corregge Alma.
Alla fine della loro breve
passeggiata
le due donne entrano regolarmente nel negozio di fiori dove però non
comprano mai niente. Alma ama
le
piante, e Aadan, al suo paese, faceva la contadina. Il profumo del
negozio piace a tutte e due. Alma non legge più da tanto tempo, perché
non vede. Aadan
è
analfabeta.
"Come fai a ricordarti così bene i numeri di telefono?" si
lamenta Alma " se solo avessi un po' della tua
memoria!"
Aadan ricorda perfettamente il telefono dell'idraulico, quello del
laboratorio di
riparazioni
tv e persino i prefissi delle città. Però Alma non è mai riuscita a
convincerla del fatto che
esistono
i numeri civici delle vie, Aadan preferisce dire "strada verduraio" o
"palazzo automobili". Se non conosce
già
il posto dove deve andare fa lunghi giri concentrici, chiedendo
informazioni ai passanti, e alla fine trova
immancabilmente
il portone o il negozio che cercava. Per lo stesso motivo riesce a
cucinare dei dolci
complicatissimi
senza dimenticare né un ingrediente né una dose. A volte Alma le dà dei
suggerimenti del
tutto
inutili "Bastano solo trecento grammi di zucchero se metti mezzo chilo
di farina". Aadan non sa leggere la bilancia e fa
tutto
a occhio. In compenso Alma ha due libri di cucina pieni di vecchie
ricette, scritte da lei o dalle
sue
amiche, che ormai non servono a nessuno. Alma non ha più occhi per
leggere, Aadan non ha mai imparato.
Per
una la lettura è un ricordo, per l'altra un sospetto, e per entrambe i
libri e i giornali sono muti. Gran parte del
tempo
lo passano a parlare e, molto spesso, a raccontare. "Parlami del tuo
paese" le chiede immancabilmente Alma. Aadan sorride,
poi
allarga le braccia "Ancora?" "Non mi racconti mai niente. Le avete le
galline?" Alma pensa che la
Somalia
sia simile all'Astigiano di quando lei era bambina, e forse non ha
tutti i torti. Crede che ci
siano
i contadini che tornano a casa la sera, sul carro, e le ragazze che
guardano da dietro la porta di casa "Noi
abbiamo
tenda, non porta" dice Aadan "molto caldo in Somalia". E' vero però che
Aadan non racconta
volentieri
della Somalia, probabilmente ha visto scene troppo brutte. L'unica cosa
di cui parla è suo
figlio,
perché ha studiato ed è tornato in patria per fare l'avvocato "Lui
tanti libri in casa, come te" "Potessi leggerli"
esclama
Alma "ce ne sono ancora tanti che non ho letto!" Per Alma i libri sono
solo quelli vecchi che ha nella
sua
libreria: di nuovi non ne ha più visti da almeno dieci anni e piano
piano si è dimenticata del fatto che
continuano
a uscirne. Probabilmente non le interesserebbero nemmeno più,
l'incapacità di leggere
rafforza
la sua convinzione che la vita, e dunque anche i libri, siano solo
quelli di una volta. Dei suoi vecchi libri
crede
di riconoscere alcune copertine - Orgoglio e Pregiudizio, La saga dei
Forsythe, Le memorie di un uomo
inutile
- e qualche volta le mostra ad Aadan. "Questo è molto bello" le dice
seriamente, indicandole un
libro
che lei pensa sia La saga dei Forsythe. Nessuno sa che cosa pensi
davvero Aadan dei libri. Li
spolvera
spesso, ma non è mai accaduto che ne togliesse uno dallo scaffale. Il
figlio di Aadan parla francese, ha fatto l'Università a
Nanterre.
Quando si arriva a questo punto la parola passa immancabilmente ad
Alma, che comincia a raccontare. "Anche mio
nonno
parlava benissimo francese. A quei tempi, in Piemonte, tutte le persone
colte sapevano
parlare
francese. La mia famiglia abitava nella Villa dei Lamarmora perché mio
nonno era
intendente
dei beni del Marchese" "Intendente?" "Vuol dire uno che si occupa di
amministrare la ricchezza di un altro,
le
terre, i conti in banca, le azioni. Chiedi a tuo figlio, l'avocat,
vedrai che te lo spiega. Il marchese
invece
è un nobile, una persona importante" Aadan si appassiona sempre molto
ai racconti di Alma, soprattutto
quando
ci sono di mezzo dei nobili. In un certo senso è vero che la Somalia
rassomiglia all'Astigiano di
tanti
anni fa. "Il Marchese Lamarmora, il vecchio, era un eroe, è quello che
ha fondato il corpo dei
bersaglieri.
Sono i soldati che corrono sempre, con la tromba, e hanno le piume sul
cappello". Aadan conosce bene i
bersaglieri,
li ha visti alla televisione. E anche al suo paese ciascun nobile ha i
propri soldati. "A quei tempi
non
si scherzava" continua Alma "sulle colline c'erano i briganti e quando
mio nonno portava i soldi in
città,
con la diligenza, c'era sempre la possibilità di incontrarli" Aadan non
sa che cosa sia di preciso
una
diligenza ma questo ha poca importanza "E poi sulla diligenza viaggiava
spesso anche la Marchesina Lamarmora,
che
andava a scuola a Torino con le mie zie, al Collegio dell'Adoration "
"Non bersaglieri?"
"Macché
bersaglieri, a quei tempi non avevano paura di niente. Mio nonno
metteva un cuscino sotto i piedi delle
ragazze,
perché non si sciupassero le scarpe. Ma quel cuscino era pieno di
monete d'oro. Una volta i briganti
fermarono
davvero la diligenza e rubarono il portafoglio a mio nonno, però non
pensarono di
togliere
il cuscino da sotto i piedi dalle ragazze" Aadan sorride. Avevano molto
rispetto per le donne, quei briganti
"Molti
briganti in Somalia, anche vicino a mio villaggio. Noi paura per le
ragazze" "E non ci sono i soldati, la
polizia?"
Aadan allarga le braccia. "Racconta di zio Paolo". Aadan conosce quasi
tutte le storie della
famiglia
di Alma, ma le piace sentirle ripetere.
Non avendo mai letto una sola
riga in vita sua, Aadan
concepisce
il racconto, di chiunque e di qualunque cosa, come l'unica possibile
alternativa alla noia e al
silenzio.
Dal racconto si aspetta tutto e non si aspetta nulla. Sa bene che certe
volte dai racconti potrà
ricevere
molto divertimento, e persino degli insegnamenti, mentre altre volte
essi risulteranno del tutto
indistinguibili
dalla chiacchera più banale. Ma in ogni caso non importa, è così che si
fa e si è
sempre
fatto. Per cui è giusto che ora Alma le racconti di zio Paolo. "Oh lui.
Da giovane voleva fare il capitano di mare, sulle navi
che
andavano in America, mio nonno però non aveva voluto che lasciasse il
paese. Zio Paolo voleva
vedere
il mondo e correre delle avventure, come quelle che leggeva nei libri.
Ma mio nonno non ne voleva sapere.
«Guarda
il mar ma statti alla riva» gli ripeteva. Capisci che cosa vuol dire
questo proverbio? Che le cose
belle
ma pericolose, come il mare, è meglio guardarle di lontano. Quando io
l'ho conosciuto zio Paolo era
già
vecchio e abitava in una piccola casa" Alma avrebbe voluto dire una
dépendance "in fondo al
giardino
della Villa. Cavava i denti ai contadini. Facevano degli urli, quei
poveretti! Mio nonno lo aveva messo là
perché
non voleva sentire quegli urli". Aadan è terrorizzata dai dentisti e si
mette una mano sulla
bocca.
Anche al villaggio veniva qualche volta un dentista e lei, quando
passava davanti a quella casa, voltava gli occhi
dall'altra
parte. "Prima però zio Paolo aveva fatto la bella vita, a Torino. A mio
nonno
diceva che studiava per prendere la laurea in medicina, invece
affittava persino una carrozza, con i soldi
che
gli mandavano le sorelle, e se ne andava su e giù con le ballerine.
Quando poi aveva finito i
soldi
vendeva il cappotto" "Grande vestito blu" pensa probabilmente Aadan "e
passava le notti in un caffé. Dopo
un
po' le zie mandavano altri soldi e lui ricominciava da capo a
divertirsi con le ballerine e a girare in
carrozza.
Quando mio nonno se ne accorse lo costrinse a tornare immediatamente a
casa e gli fece prendere la laurea
per
corrispondenza. Cioè per lettera". Questa cosa che le lettere possano
servire
persino a prendere
la
laurea è sempre sembrata molto misteriosa ad Aadan. Che cosa ci deve
essere scritto, in una lettera,
perché
possa servire a prendere una laurea come quella di suo figlio? "Così
zio Paolo aveva passato
tutta
la sua vita alla Villa, in quella piccola casa in fondo al giardino.
Stava sempre in camera sua a leggere, gli
piacevano
soprattutto i libri di viaggi e i romanzi di avventure. Una volta al
mese si vestiva elegante e usciva,
portando
con sé una borsa di cuoio rosso. Stava via da casa un paio di giorni,
nessuno era mai riuscito a
sapere
dove andava. Chi diceva che aveva un'amica a Torino, altri che era per
una visita medica, altri
sussurravano
persino che avesse una famiglia di nascosto da tutti. Quando tornava,
sempre con la sua borsa
di
cuoio rosso, si infilava in casa senza dire una parola e si metteva di
nuovo a leggere" "Sempre libri?"
chiede
Aadan sospettosa "Sempre libri". Zio Paolo leggeva libri di viaggi, e
quando i contadini avevano bisogno
di
lui bussavano alla porta della piccola casa. Entravano, urlavano, poi
uscendo si inchinavano e zio
Paolo
portava in casa un pollo oppure delle bottiglie di vino. "Negli ultimi
tempi però erano
diventati
poveri e a Villa Lamarmora li tenevano quasi per carità.
Le mie zie
lavoravano in casa, facevano le bambole
per
un commerciante di Asti, e quando si trovavano in difficoltà più gravi
vendevano qualche
mobile.
Se non li avessero venduti tutti adesso ne avrei chissà quanti" Alma
non ha mai digerito questa faccenda dei
mobili,
anche se da allora devono essere passati almeno ottant'anni "mi è
rimasto solo il cassettone
dell'ingresso.
Quello è un bel mobile davvero, ti ricordi che quando è venuto il
falegname lo voleva comprare per cinque
milioni?"
Cinque milioni. Una somma incredibile. "Anche libri venduti?" chiede
Aadan. Alma lì per
lì
non risponde "Chissà. Di sicuro però alla morte di zio Paolo successe
una cosa molto strana". Aadan si aspettava
qualcosa
di strano da uno che leggeva tutti quei libri. "Dopo il funerale le
sorelle entrarono nella piccola casa in fondo al
giardino
per mettere un po' d'ordine. Pensavano che c'era il laboratorio da
dentista da smontare, le pinze, i
trapani,
le bottiglie di etere, poi i vestiti di zio Paolo che si potevano dare
alle suore perché li
distribuissero
ai poveri. Ma quando entrarono nella stanza da letto videro che era
completamente piena di libri. Ce n'erano
dappertutto,
sui comodini, sui davanzali delle finestre, sul divano, ma la maggior
parte erano
ammucchiati
per terra. Le sorelle dovettero farsi aiutare da due contadini per
metterli nei sacchi e portarli in
giardino,
da sole non ce l'avrebbero mai fatta".
Aadan sta sempre aspettando
quello che successe, la cosa
strana.
"Insomma, quando una di loro ebbe sgombrato l'armadio dai libri che
Paolo aveva ammucchiato anche
lì,
vide che sul fondo era appoggiata la famosa borsa di cuoio rosso. Le
sorelle restarono in dubbio se dovevano
aprirla
oppure no. In fondo lui la usava solo per quelle sue gite segrete,
forse non avrebbe avuto piacere
che
loro guardassero cosa ci nascondeva. Ma alla fine decisero di aprirla.
Nessuno avrebbe mai
potuto
immaginare quello che videro. Dentro la borsa c'era una sciabola,
un'uniforme blu e un berretto da
ufficiale.
Sulla fascia interna del berretto, che era ancora nuovo, c'era scritto:
«Capitano Paolo
Amerio».
Una volta al mese, zio Paolo andava chissà dove per vestirsi da
capitano di marina, come aveva
sempre
desiderato di fare. Strano che nessuno lo avesse mai incontrato vestito
in quel modo. Forse si rinchiudeva in una
stanza
d'albergo o forse, per sentirsi un marinaio, gli era già sufficiente
tenere i vestiti chiusi
nella
borsa. Proprio come diceva mio nonno, guarda il mar ma statti alla
riva" Alma ride. Da bambina, quando le zie le raccontavano questa
storia, lei
si
immaginava zio Paolo mentre, con l'elsa della sciabola stretta sotto il
braccio, guardava il mare dalla
riva
dei libri.
C'è molto vento. Ho
appoggiato la carta su una tavoletta,
seduto
sui gradini, ma non so per quanto tempo riuscirò a scrivere. Veloci
come insetti passano fili d'erba,
frammenti
di corteccia, grumi di terra. Si arrestano per un attimo sulla
superficie bianca del foglio poi, con la
stessa
velocità, riprendono il volo e scompaiono. Ho scritto poche righe, solo
la data e l'inizio di una
descrizione:
"Salomies, il giorno IV di Ecatombeone C'è molto vento. Ma il sole è
forte come al solito, e
nei
turbini che portano terra e odore di menta arriva anche il canto di una
cicala. Sono le quattro del pomeriggio, e penso
che
tu..." Non ho altro mezzo per comunicare se non scriverti. Qui a
Salomies,
dove
mi trovo ormai da più di tre mesi, non esiste telefono, posso solo
scriverti una lettera. Che però
non
potrò spedirti perchè non c'è neppure la posta. Al massimo la mia
lettera resisterà qualche minuto sulla
tavoletta,
qua fuori, poi prenderà il volo assieme ai fili d'erba e scomparirà
chissà dove.
Così
tu non potrai mai sapere che esisto ancora. Ma io saprò che esisti tu.
Almeno nella mia lettera esisterai e
domani,
quando vedrò il sole nella stessa posizione, e altri fili d'erba
correranno col vento, tu tornerai qui ad
esistere.
Del resto che tu ci sia davvero o no, dall'altra parte di questa
lettera, non me ne importa niente. Mi
accorgo
che la consolazione che mi dai, esistendo dentro le mie lettere,
appartiene solo a me. Le mie sono
diventate
lettere di puro egoismo. Il pronome che ti rappresenta è più che
sufficiente.
Scrivendo
"tu" posso scrivere anche "io", e così esistiamo già tutti e due, dove
mi pare e quando mi pare, col solo vincolo
di
una trama (fatta di lettere mie) che dà senso alle cose che ti
racconto. La lettera, mi ha detto Ermogene, è come la metà di un
dialogo.
Si sbaglia. O perlomeno questo non vale per la mie lettere a te, che
sono un dialogo tutto intero. Forse la lettera
forma
la metà di un dialogo quando dall'altra parte c'è una persona diretta,
che attende di
ricevere
delle notizie e vuole rispondere. Ma tu non sei una persona diretta, e
non potrai mai rispondermi. Ermogene ha la barba
a
punta, quando mi ha sorpreso a scrivere, seduto sui gradini del Tempio,
ha subito voluto dimostrarmi
che
conosceva l'arte della definizione. "Cos'è una lettera?" ha esclamato
"nient'altro che la
metà
di un dialogo". Ma Ermogene è un retore schematico, e dell'argomento
"lettere" deve essersi occupato solo
frettolosamente.
Se si fosse impegnato di più, avrebbe scoperto anche quanta simulazione
contengono. In
realtà
ho sempre avuto difficoltà a scrivere lettere vere a delle persone
autentiche.
Non mi piace ingannare la
gente.
Come tutti, in questi casi ho sempre preferito telefonare. "Salomies,
il giorno V di Ecatombeone Ho fatto dei lavori, sai? ho tolto
i rovi,
sgombrando
l'ingresso,
e insieme a Lica abbiamo persino tirato su due tamburi di colonna. Il
Tempio è piccolo, forse è per
questo
che nessuno l'aveva mai utilizzato per abitarci. Vedrai quando farà
freddo! mi dice Ermogene, e può darsi
che
abbia ragione. Ma per ora sto molto bene, non ho mai vissuto in una
casa così bianca. Gli uccelli si sono
abituati
alla mia presenza, e ogni mattina una ghiandaia mi sveglia per
chiedermi le briciole di pane. Temo di averla
viziata..."
Preferisco telefonare perché il telefono non richiede
simulazione,
specie se si conosce già chi sta dall'altra parte del filo. Ma anche se
non lo si conosce, pochi toni di voce, lo
stesso
modo di dire "pronto" o "this is Charlie Ross", sono sufficienti a dare
un volto all'interlocutore. Dopo
di
che a ogni domanda segue una risposta, il sì e il no nascono immediati.
Quanto si può
simulare
dentro un microfono che dà la tua voce in presa diretta ? Ben poco. Il
telefono non ti permette di tornare
indietro
su un discorso sbagliato, per annullarlo e farne un altro più adatto
alla situazione. Il
telefono
non si cancella, per questo è refrattario alla simulazione. Al massimo
si può evitare la conversazione
raccomandando
a qualcuno "per favore, digli che non ci sono!" Ma poi l'altro
richiamerà, oppure richiameremo
noi,
snervati, incapaci di rimandare ancora. E la simulazione, anche quella
poca che consiste nel negare se stessi,
sarà
per forza finita. In una lettera invece il tempo e i mezzi per simulare
sono infiniti, ogni discorso può
essere
cancellato e riscritto quante volte si vuole. Ecco perché le lettere si
prestano così bene ad essere
scritte
a qualcuno che non c'è. Basta inventare o riscrivere non solo le cose
che si dicono ma anche la persona a cui ci
si
rivolge. In questo modo le lettere danno anche una grande consolazione.
Invece il telefono, in casi del
genere,
non serve proprio a nulla. Non si può telefonare a qualcuno che non
c'è. Il telefono da
solo
non fa mai compagnia, e non è capace di riempire alcun vuoto.
Telefonare a qualcuno che non c'è
significa
solo ascoltare un segnale che si perde chissà dove, assieme alla
speranza. "Salomies, il giorno VI di Ecatombeone Da un momento
all'altro mi aspetto la visita del capitano
bizantino.
Il
forte è a cinque miglia da qui, costruito su un picco che guarda la
baia. Ieri tre soldati, armati di lance, si
sono
fermati a lungo sulla collina di fronte. Avevano l'aspetto di Bulgari,
ed erano quasi degli straccioni. Forse
Lica,
il pastore di cui ti ho parlato, li ha avvertiti della mia presenza
(gli avevo raccomandato di non farlo).
Oppure
passavano di qui per caso e hanno capito che nel Tempio ci abita
qualcuno. Prima o poi il capitano
verrà,
vorrà conoscermi. Forse crede che io sia un mendicante, o un eremita!
Verrà, se non altro per
spiegarmi
come ci si deve comportare nel caso che sbarchino i pirati. O magari
per sincerarsi che io non sia uno
di
loro, pronto a far segnali di notte, a tradire: come sono pronti a
tradire i suoi soldati, com'è pronto
a
tradire Lica, con i suoi occhi bruni e molli come fichi secchi. Hai
paura per me? Qua si muore così
facilmente..."
Per fortuna non mi leggerai. Altrimenti dovrei stare attento a
quello
che scrivo, dovrei tacere tante cose e cercare solo di farti ridere.
Come facevo prima, quando ti spedivo
realmente
le mie lettere. Scrivere lettere vere, a persone vive, è molto
difficile. Solo un retore
(sarà
stato Ermogene ad avvertire il capitano della mia presenza?) può
credere che queste "metà di dialogo" siano
come
una registrazione telefonica in cui le battute della conversazione sono
state trascritte su fogli separati. In
realtà
le lettere vere sono persino più immaginarie di quelle fantastiche, e
la mente deve sforzarsi molto di
più.
Ricordo quando ci scambiavamo realmente delle lettere. Te ne ho scritte
centinaia
nella mia vita. Ti ho scritto dal treno, dalla nave, da casa, ti ho
scritto da remoti
alberghi
di vacanze e dal bar sotto le tue finestre. Il mio destinatario, tu,
eri vero, eppure io dovevo immaginarti ogni
volta.
Eri il termine dei miei pensieri, io prendevo quello che vedevo, o
quello che sentivo, e per te lo mettevo
in
forma di parole: "Qui dove siedo l'aria è molto chiara, e di fronte a
me il mare corre in una
prospettiva
che sembra infinita..." Figurarsi se non è immaginaria una persona che
fa da termine a pensieri sull'aria
e
sul mare! Ma questo non è ancora nulla. Perché mentre scrivevo mi
capitava a volte di vederti, o di
pensarti,
mentre a casa tua avresti letto quello che scrivevo. E allora sì che
ero costretto ad immaginarti,
ancor
più di quando eri solo un sentimento, un fantasma lucente che faceva da
termine ai miei pensieri. Immaginavo
come
avresti potuto essere al momento in cui la mia lettera ti fosse
arrivata, perchè certo la
tua
persona sarebbe stata molto diversa dall'ultima volta in cui ci eravamo
parlati: o dall'ultima volta in cui
ci
eravamo scritti. Il tempo è una sostanza terribile, che a tutto si
mescola e tutto cambia. Per questo bisogna
consumare
gran parte della propria mente, e della propria vita, per pararne i
danni in anticipo.
Pensare al tempo
porta
via un sacco di tempo. Da quando non ti spedisco più le mie lettere è
tutto
molto
più facile. Non devo immaginare niente che ti riguardi mentre ti
scrivo, niente che si allontani dal modo in cui il
mio
capriccio, il mio egoismo, ti ha fissato una volta per sempre. E anche
riguardo a me, non solo riguardo a te,
sono
molto più tranquillo. Perché allora, quando ti scrivevo davvero, dovevo
continuamente immaginare anche me.
Me
stesso come tu mi volevi, o come mi piaceva che tu mi volessi. Oppure
immaginare me stesso come
sarei
stato quando la mia lettera fosse giunta a destinazione - una persona
per forza differente rispetto
a
quella che in quel momento ti stava scrivendo. Nella lettera cercavo il
più possibile di farmi
rassomigliare
all'"io" che sarei stato il giorno in cui "tu" mi avresti letto. Solo
che non riuscivo mai a prevedere
esattamente
come sarei stato in quel momento. Nel frattempo sarei persino potuto
morire, ma tu avresti continuato a
leggermi
come se fossi stato vivo. Ripensandoci oggi, mi sembra di aver passato
giorni e giorni a
stiracchiare
me stesso, quando ti scrivevo davvero, raddoppiandomi nella forma di un
fantasma supposto e
inesistente.
"Salomies, il giorno VII di Ecatombeone Penso che il capitano
stia per arrivare. Mi sembra
persino di
sentire
il passo del suo cavallo. Temo che i suoi soldati siano già stati
avvertiti: meirákia!
avrà
ordinato il capitano senza scendere di sella, solo un colpo di lancia,
senza rumore, ma prima guardatevi bene in giro..." Se solo dovessi
pensare che "tu", in qualche modo, potresti
leggere
questa
lettera e rispondermi! che tra una settimana, o tra un mese, Lica
potrebbe arrivare trafelato, portandomi
una
busta con su scritto "urgente" "per favore" "fate presto..."
Dovrei
sforzarmi di immaginare. Ah già,
esclamerei,
deve essere la risposta a quella lettera in cui scrivevo che il
capitano stava per arrivare, per questo
ci
sono delle frasi così angosciate! Avrei di fronte agli occhi il tuo
viso spaventato - e subito dopo dovrei
anche
cercare di immaginare te come sei invece "adesso", cioè nel momento in
cui ricevo la tua lettera.
Una
persona ancora differente da quella che, nella lettera, mi scongiurava
di stare attento e di scappare. Una
persona
che nel frattempo è diventata più tranquilla, che magari si è
addirittura messa (come si dice) il
cuore
in pace. Comincerei inevitabilmente a pensare che fra te e i caratteri
della tua lettera c'è un vuoto
senza
fine. E allora potrei anche impazzire, non ci sarebbe più certezza di
nulla. Neppure di me che certo,
quando
mi scrivevi, tu immaginavi in una condizione (riverso sui gradini del
Tempio, nascosto fra i rovi, in un
burrone...)
differente da quella in cui potrei trovarmi al momento in cui ti
leggessi. Perché nel
frattempo
potrebbe benissimo essere accaduto che il capitano bizantino non fosse
venuto affatto, oppure che fosse venuto
e
si fosse dimostrato amichevole e simpatico. In quel caso io potrei
persino trovarmi a leggere la tua
lettera
di terrore proprio mentre sto giocando a scacchi con il capitano, sui
gradini del Tempio. Dio mio, ma
quanti
condizionali e quanti congiuntivi sono necessari per descrivere che
cosa capita con le
lettere
vere! "Salomies, il giorno VIII di Ecatombeone che ne diresti se ti
descrivessi finalmente la mia amica
ghiandaia?
Ha
un color verde scuro, e tutte le mattine si affaccia fra i tamburi
delle colonne frullando le ali per
svegliarmi.
Oggi però non si è fatta vedere. Ermogene, che si picca di disquisire
su tutto, anche sugli argomenti
più
futili, dice che gli uccelli sentono il pericolo molto prima degli
uomini, e che quando scompaiono
bruscamente...."
Il vento cresce, e il foglio su cui stavo scrivendo è volato
fra
i sassi, verso il mare. Come tutti gli altri. Si perde un'altra lettera
indirizzata a te, che non ci sei. Proprio come
non
c'è il pastore Lica, non c'è Ermogene, il retore con la barba a punta,
e non c'è neppure il capitano
bizantino
che sta per spuntare da dietro la curva. Da quando ho smesso di
spedirti le lettere che scrivo tutta la mia
esistenza
combacia molto meglio di prima. Vivo in un mondo completamente
fantastico eppure la mia immaginazione
si
riposa tanto di più. Ma gli uccelli si sono zittiti completamente, e
nel sole ho visto un lampo di
metallo.
"Meirákia!"
"Quando la tromba annunziò
la visita del generale Baistrocchi
Peppino
aveva appena buttato gli spaghetti. Cioè li aveva buttati il suo
attendente" "Intendente?"
interrompe
Aadan "No, ho detto attendente" la corregge Alma "l'intendente era mio
nonno, quello che curava i beni dei
Lamarmora.
L'attendente invece sarebbe un soldato che fa i servizi a un ufficiale.
Rifà il letto, cucina,
stira..."
Anche Aadan sta stirando, in salotto con Alma, e le sembra strano che
un soldato possa fare gli stessi lavori
che
fa lei. Al suo paese i soldati uccidono la gente con le bombe e il
fucile, non stirano i vestiti. La televisione è rimasta spenta. Fanno
vedere solo morti
ammazzati,
si lamenta Alma, e un sacco di maleducati che gridano! Così Aadan sta
stirando e Alma siede
composta
sul divano, con la piccola persona un po' sprofondata nel cuscino.
Accanto allo schienale c'è un
porta
giornali con dentro un rotocalco, il reportage delle nozze fra Prince
Charles e Lady Diana. E' stata
l'ultima
cosa che Alma, se pure aiutandosi con la lente, è riuscita a leggere, e
da allora quel rotocalco
è
rimasto lì, unico, senza essere sostituito da nessun altro. Ormai Aadan
si è abituata a spolverarlo con la
stessa
diligenza priva di curiosità con cui tratta la zuppiera bianca di
Bassano e la statuetta del violinista. Alma sta
raccontando,
come spesso accade quando Aadan stira e lei si annoia. Dai suoi
racconti la vecchia somala
impara
un'Italia che non esiste più da almeno cinquant'anni, e forse non è
neppure mai esistita. Se
Alma
avesse ancora gli occhi buoni probabilmente leggerebbe ad Aadan, che
stira, quello che sta scritto
sui
settimanali, storie di politici e di attori. Un'Italia ugualmente falsa
e irreale, ma perlomano identica a
quella
di cui leggono e parlano anche tutte le altre persone. Ma Alma non ci
vede abbastanza per leggere, e
Aadan
è analfabeta. Per cui, soprattutto quando Aadan stira, l'Italia torna
ad essere quella di zio
Paolo,
dell'intendente dei Lamarmora e del generale Baistrocchi. "Figurati
Peppino quando sente dire che
è
arrivato il generale! Tremava dalla rabbia. Per lui gli spaghetti erano
sacri, e quel Baistrocchi veniva a
fare
l'ispezione proprio pochi minuti prima che l'attendente glieli scolasse
nel piatto. Peppino uscì
dalla
tenda e disse all'attendente che sarebbe tornato prima possibile".
Peppino era un vecchio militare che aveva cominciato la carriera come
ufficiale
di complemento nella grande guerra. Dopo di che non era più riuscito a
lasciare
l'esercito.
Diceva che quando era tornato a casa si era accorto di non saper fare
altro se non il militare, per cui era
subito
tornato sotto le armi e ci era rimasto per sempre. Aveva combattuto
come ardito in tante piccole
guerre
dimenticate, poi aveva comandato una compagnia in Etiopia e infine era
stato fatto prigioniero
a
El Alamein.
Gli inglesi lo misero in un campo di prigionia, in India,
dove rimase a lungo. Ma delle sue
guerre
Peppino parlava poco, e sì che ne aveva viste tante. Raccontava solo
del generale Baistrocchi, di Torino
e
delle molte fidanzate che aveva avuto nella sua vita. O forse è Alma
che ha dimenticato tutto il
resto,
e adesso racconta solo di questo. "Il generale entrò nell'accampamento
tutto vestito di nero e con
il
fez sulla testa. Era un gran fascista. Peppino gli andò incontro, si
mise sull'attenti e gli disse
«Comandi
signor generale!» Ma era sempre arrabbiato per via degli spaghetti. Il
generale voleva vedere i soldati
che
saltavano nel cerchio di fuoco". Al paese di Aadan nessun soldato ha
mai saltato nel cerchio di fuoco. Lei
li
ha visti fare i caroselli con le jeep, nel villaggio, e trascinare via
la gente. Per questo ha lasciato casa
sua
e non vuole raccontare mai nulla di lei. "A quell'epoca era venuto di
moda che i militari dovessero fare
quell'esercizio
per dimostrare il loro coraggio. Anche i soldati di Peppino saltavano,
e a volte doveva
saltare
persino Peppino. Nella compagnia c'era solo uno che aveva paura, e
nessuno era mai riuscito a farlo
saltare
in quel maledetto cerchio di fuoco. In genere, quando venivano le
ispezioni, il sergente lo faceva
nascondere
in un magazzino, ma quella volta Baistrocchi era arrivato
all'improvviso. Portarono subito il cerchio,
che
tenevano sempre pronto perché così voleva il generale, gli dettero
fuoco, e Peppino fece schierare la
compagnia.
Poi cominciarono a saltare. Peppino però pensava sempre agli spaghetti,
che ormai ... " "E
quello
che non salta?" interrompe Adan "Era schierato anche lui. Quando fu il
suo turno prese la rincorsa,
arrivò
fino davanti al cerchio di fuoco poi si fermò di botto e tornò
indietro. Il generale era
già
furibondo. Ordinò che il soldato saltasse di nuovo ma lui, che aveva
paura, quando fu arrivato davanti al cerchio di fuoco si
fermò
nuovamente e tornò indietro. Baistrocchi andò da Peppino e gli disse
«Capitano, lei
è
un incapace!» Peppino stava sull'attenti e pensava ai suoi spaghetti,
che a quel punto erano già diventati colla.
Immobile,
sempre sull'attenti, gli rispose «Signor generale, questo lo dica a sua
sorella!» Baistrocchi lo mise agli
arresti,
Peppino tornò nella tenda e disse all'attendente di buttare di nuovo
gli spaghetti". Da quando Alma ha raccontato ad Aadan questa storia, e
lo ha fatto
più
di una volta, in casa gli spaghetti sono migliorati. Adesso Aadan si
affretta molto di più a
scolarli
e a condirli, e anzi, soffre quando pensa agli spaghetti di Peppino che
passavano di cottura mentre i soldati
saltavano
nel cerchio di fuoco. "Fatto Peppino?" chiede ansiosa ogni volta che
mette in tavola la zuppiera per
loro
due. "No, sono perfetti" le risponde regolarmente Alma "al dente". Adan
sorride.
A volte dai
racconti
si imparano molte più cose che dai libri. Adan continua a stirare, Alma
si alza e prende un
cioccolatino.
"Peppino
non moglie?" chiede Aadan insistendo col ferro su un colletto
particolarmente grinzoso "No, anche
quando
era a casa stirava e cucinava sempre l'attendente. Peppino non si è mai
sposato. Però
ha
avuto tante fidanzate. Tutte cose serie, più di una volta era stato sul
punto di sposarsi e spesso aveva anche comprato
l'anello
per il fidanzamento ufficiale. Poi all'ultimo momento ci ripensava e
regalava l'anello a sua sorella.
La
sorella aveva un sacco di anelli, quelli di tutti i fidanzamenti che il
fratello aveva mandato a monte.
Neppure
lei si è mai sposata". Donne lontane. Anche se Alma tutt'ora va due
volte l'anno a trovare la
sorella
di Peppino e quando torna a casa ha sempre qualche storia da
raccontare. Giovani donne con la
collana
lunga e i vestiti tagliati dritti, simili ad Alma com'è nelle
fotografie che a volte fa a vedere ad
Aadan
dicendole "guarda bene, che qui ci devo essere anch'io!" E le mostra
dei gruppi di giovani signore
eleganti,
sorridenti, degli ufficiali col berretto duro e la mantella azzurra.
Aadan, di fronte a ogni fotografia, dice
regolarmente
che c'è anche Alma e che l'ha riconosciuta "Quante fidanzate Peppino?"
"E chi lo sa. Cinque,
dieci,
nessuno può dirlo. Però quella più ricca si chiamava Lucrezia. Era la
figlia di un allevatore pugliese e Peppino non l'aveva mai
vista.
Aveva combinato tutto la famiglia, al paese. Un giorno Peppino si era
visto arrivare una lettera da casa. Non
ne
riceveva mai". Aadan si preoccupa sempre quando sente parlare di
lettere. L'unica volta che suo
figlio,
l'avocat, invece di telefonare le aveva spedito una lettera, era stata
una vera tragedia.
"Perché
lettera a Peppino?" "Suo padre gli scriveva che lo aveva fidanzato con
una ragazza molto ricca e, secondo lui,
molto
bella. La famiglia di lei voleva conoscerlo al più presto, insomma,
doveva scendere in Puglia per
il
fidanzamento. Nella busta c'era anche una fotografia della fidanzata,
una ragazza con i capelli biondi e
molto
lunghi. Peppino infilò la lettera nella cornice dello specchio e disse
all'attendente di preparare i bagagli
per
il treno. Dopo un giorno e una notte arrivarono alla stazione di
Foggia. Era il mese di Luglio e fuori dalla
stazione,
ad aspettarli, c'era una bellissima macchina scoperta. Il padre di
Lucrezia era seduto davanti,
accanto
all'autista. Peppino dette la mano al suocero, l'attendente si sedette
sullo strapuntino e partirono
per
la campagna". Fa caldo d'estate in Puglia, e Peppino aveva il colletto
duro. Ma non
se
lo poteva slacciare di certo. L'ufficiale è sempre un signore, come si
usava dire a quei
tempi!
"Quando arrivarono alla fattoria era mezzogiorno e Lucrezia li
aspettava per il pranzo. Peppino disse
all'attendente
di portar su la valigia e si cambiò. Poi scese nella sala. Lucrezia
aveva effettivamente i
capelli
biondi e lunghi, che le scendevano quasi fino alla vita. Dalla
fotografia però Peppino l'aveva immaginata
più
alta. Pranzarono, Peppino raccontò di Torino, della vita militare,
delle feste che dava il colonnello
comandante.
Il suocero si sentiva molto soddisfatto, era ricco ma non era nobile, e
avere per genero un
ufficiale..."
"Lamarmora nobile" la interrompe Aadan. Le piacciono i nobili "I
Lamarmora erano marchesi,
una
gran nobiltà! Invece i suoceri di Peppino avevano fatto i soldi con la
campagna" "Come tuo nonno" "Ma no,
che
sono tutti morti poveri, te l'ho detto. Le mie zie facevano addirittura
le bambole per vivere. I suoceri
di Peppino invece avevano tanta terra, tante greggi di pecore, si
poteva girare per ore con la macchina
ed
era tutta roba loro. Alla sera ci fu la festa di fidanzamento, Peppino
aveva portato un bellissimo anello.
Lucrezia
indossava un vestito bianco e la collana di perle, Peppino invece aveva
messo la divisa nera, da
sera,
ed aveva le scarpe di vernice. Già lui era terribile con gli
attendenti! Se solo c'era una macchiolina sulle
scarpe
gliele faceva pulire da capo.
Alla festa saranno state duecento
persone, forse di più, erano venuti
da
tutta la regione. Ci fu la cena, poi il ballo, Peppino era un gran
ballerino e Lucrezia aveva dei capelli bellissimi.
C'era
solo una cosa che non andava bene" "Cosa non andava bene?" "Lucrezia
non dava di niente". Aadan non capisce "Così almeno diceva Peppino.
Lucrezia aveva
dei
bellissimi capelli, lunghi fino alla vita, però non dava di niente, era
una donna insignificante. Non
sapeva
parlare, non sapeva scherzare" "Sapeva leggere?" "Certo che sapeva
leggere, era istruita, aveva studiato a
Bari
in collegio. Però era una ragazza noiosa, l'unica cosa che aveva erano
i soldi e dei capelli bellissimi.
Peppino
ballava, tenendo la persona ben dritta come gli avevano insegnato ai
balli dell'esercito, e intanto
ammirava
tutto quello sfarzo e quelle luci. Ma ogni volta che diceva qualche
cosa a Lucrezia lei gli rispondeva con
delle
frasi sciocche, e gli sorrideva in un modo che non dava di niente. A un
certo punto il suocero
interruppe
l'orchestra e fece portare un piccolo tavolo al centro della sala.
Peppino ci mise sopra la scatola
con
l'anello e Lucrezia, a sua volta, posò sul tavolo un bellissimo
orologio d'oro. Era il dono di nozze che
avevano
preparato i genitori di Lucrezia. Il giorno dopo Peppino partì, perché
doveva tornare al
reggimento.
Il matrimonio era già fissato per il mese successivo". Peppino tornò a
Torino e andò subito dalla sua amica.
Questo
è un lato della vita di Peppino che Alma tende sempre a sfumare, per
buona creanza. Peppino stesso faceva solo delle
allusioni
alle sue amiche del passato, specie quando era presente la sorella.
Quella a cui lui regalava gli
anelli
dei fidanzamente andati a monte. Dunque Peppino aveva un'amica che
abitava in via Lagrange. "Era un po'
birbone,
Peppino, per questo non si sposava mai. All'amica non aveva raccontato
nulla di Lucrezia, della
Puglia,
del suocero. Stava seduto di fronte allo specchio e fumava una
sigaretta. Poi chiese un foglio e una
penna
e si mise a scrivere una lettera" "A Lucrezia?" "No a suo padre, in
Puglia. Gli diceva che aveva
sbagliato
ad obbedirgli, che aveva cambiato idea e che comunque il matrimonio non
era fatto per lui.
L'amica
lo guardava senza capire" "Sapeva leggere?" "Sì, certo che sapeva
leggere, ma non si
leggono
le lettere degli altri. Peppino mise la lettera in una busta, scrisse
l'indirizzo e salutò bruscamente
l'amica.
Disse che sarebbe tornato più tardi". C'è una buca delle lettere in via
Lagrange, quasi all'incrocio
con
corso Vittorio - cioè, c'era ai tempi di Alma, di Peppino e delle sue
fidanzate. Peppino si fermò di fronte
alla
buca e per qualche minuto si mise a considerare quello che stava
facendo. Pensò alla cerimonia del
matrimonio,
alla macchina scoperta, alle pecore del suocero. Pensò alla lettera del
padre, che era
arrivata
fino dalla Puglia e che era rimasta infilata nella cornice dello
specchio. Decise che aveva avuto troppa fretta e si
rimise
in tasca la sua busta. Non poteva spedirla. Poi alzò gli occhi verso la
finestra dell'amica
e
vide che lei lo guardava attraverso le tendine. Allora tirò fuori la
lettera e la impostò. L'ufficiale
è
sempre un signore, e Lucrezia non dava di niente.
Un giorno che viaggiavo
sulla Bart, la metropolitana di San
Francisco,
c'era il diavolo seduto di fronte a me. Ma io non lo sapevo. Il diavolo
si era vestito da yuppy e teneva in
grembo
un tabulato di bilancio. Nel frattempo io avevo aperto il giornale.
Dopo un po' mi accorsi che lui, seduto dall'altra parte del foglio,
sbirciava
i titoli dello sport. Provai bruscamente a voltare pagina, sperando che
il diavolo si accorgesse del
mio
fastidio, ma lui si mise a sbirciare anche il supplemento di economia
e, subito dopo, la cronaca
locale.
Sembrava che tutto lo interessasse. Allora abbassai il giornale,
seccato. Il diavolo fece
finta
di niente e cominciò a guardare fuori dal finestrino. In quel punto la
Bart corre all'aperto, anzi, ben in
alto
sulla massicciata, e dal vetro si può vedere persino la baia. Perché
questo signore non guarda il
panorama?
mi domandavo. Non avrei certo immaginato che si trattasse del diavolo.
La gente che sbircia i
giornali
altrui mi ha sempre dato fastidio, li considero dei maleducati. Quando
si legge un libro, o un giornale,
è
come se si fosse impegnati in una conversazione silenziosa, per cui chi
sbircia si intromette di fatto in
un'intimità
che non gli appartiene.
A quell'ora il treno è pieno di giovani coppie
che si tengono per
mano,
e a volte si baciano, sedute negli scompartimenti di fondo. Forse che a
qualcuno verrebbe in mente di
andare
ad ascoltare i loro discorsi? Guardi che sto con il mio boy friend,
direbbe la ragazza, ci lasci in
pace.
Io sono geloso della mia lettura, per me è come parlare con una persona
cara. All'altezza di Oakland il treno si infilò di nuovo sottoterra e
io
riaprii il giornale. Immediatamente il diavolo si mise a sbirciare la
pagina degli esteri. Mi alzai di scatto e cambiai
posto.
In questi casi non ho vergogna di reagire. Come tutti coloro che
passano molte ore viaggiando, non posso
permettermi
il lusso di concedere il mio tempo ai seccatori che incontro. Leggere
in treno è un gran
conforto,
ma diventa un supplizio se si viene avviluppati in una conversazione
sul calcio o sulle malefatte dei
figli.
Prima di sedermi da qualche parte osservo dunque con cura le facce
delle persone che ci sono e prendo
subito
la mia decisione. Questi faranno di certo amicizia e si metteranno a
chiacchierare, dico passando di
fronte
al primo scompartimento; quest'altro ha il walkman e la testa rasata, è
probabile che
prima
o poi sfonderà le sue orecchie ma di sicuro sfonderà subito le mie;
questa signora invece è di sicuro
curiosa
ed estroversa (si vede da come mi guarda mentre passo). Confesso però
che il diavolo mi aveva tratto in
inganno,
aveva un'aria così professionale e discreta. Avrei giurato che, appena
il treno si fosse messo in moto,
avrebbe
cominciato a leggere i suoi tabulati segnandoli con una penna biro. C'è
anche un'altra ragione per cui evito gli scompartimenti in
cui
ci sono delle persone che fanno conversazione. Se ci si ostina a
leggere mentre gli altri vorrebbero
parlare
si crea imbarazzo e sembra di voler essere superbi. Dopo un po' i
compagni di viaggio finiscono per
domandarsi:
cosa ci sarà scritto mai in quel libro perché lui preferisca leggere
piuttosto che
partecipare
ai nostri discorsi? La situazione è molto simile a quella che si crea
quando, nel bel mezzo di una conversazione,
qualcuno
viene chiamato al telefonino e si mette a parlare allegramente con uno
sconosciuto che sta
chissà
dove. Gli altri restano disorientati, cominciano a bisbigliare e spesso
finiscono solo per fare congetture,
più
o meno velate, su chi possa essere stato a chiamare. Lo stesso accade
anche quando si legge in treno. Dopo
un
po' di tempo si cominciano a sentire degli apprezzamenti sulla
copertina del libro o sul nome
dell'autore.
Cercano di attirarti nella trappola. Naturalmente anche l'atto di
sbirciare i fogli del giornale può
manifestare
l'intenzione di attaccare discorso. Così accadde quella volta, sulla
Bart che mi portava a Daly
City.
Dopo pochi secondi, infatti, il diavolo si alzò e venne
nuovamente
a sedersi di fronte a me. Il treno stava passando sotto la baia,
all'altezza di Bay Bridge, e il rumore era
molto
più forte di prima. Il diavolo si era tolto i vestiti da yuppy e adesso
appariva proprio come lo si descrive di
solito:
aveva la coda, le corna e le zampe di capra. Confesso però che rimasi
colpito soprattutto dal suo
sguardo
che, contrariamente a quello che mi aspettavo, era poco intelligente.
"Sono il diavolo" mi disse" "Lo vedo.
Vuoi
il giornale?" "No" rispose "non saprei che farmene. Io non so leggere".
Ma guarda un po', non avrei mai
sospettato
che il diavolo fosse analfabeta. "E allora perché sbirciavi i titoli di
nascosto?" gli chiesi. Il
diavolo
fece un gesto con la mano, quasi di rassegnazione. "Io sono il diavolo"
ripeté "Ho capito, lo vedo"
dissi
"ma questo non ti giustifica dall'essere analfabeta" E per di più
curioso, avrei voluto aggiungere. Ma
ebbi
paura di offenderlo. "Il fatto è che i primi tempi non c'era bisogno di
saper leggere..." bofonchiò. Era
evidente
che nonostante i miei modi alquanto bruschi, e il mio ostentato
desiderio di leggere il giornale, lui aveva
deciso
di attaccar discorso. Fra tutti i seccatori che avessi mai incontrato
sui treni, il diavolo era
certamente
uno dei peggiori. "Dio creò il mondo con la parola, non con la
scrittura"
continuò
con una certa irritazione "questo sembra che oggi non se lo ricordi più
nessuno. La parola era tutto.
Gli
angeli
non leggevano libri ma facevano delle lunghe discussioni, fra loro o
con il Padre, e per imparare la teologia
bastava
semplicemente stare a sentire. E io imparavo facilmente. Anche quando
mi cacciarono dal cielo
continuavo
ad essere informato su qualsiasi cosa. Ho delle orecchie grandissime"
lo guardai, era vero "mi basta
puntarle
in una direzione qualunque per ascoltare tutte le conversazioni che si
svolgono in quel momento. E' il
vento
che me le porta. In una sola notte sono capace di ascoltare milioni di
discorsi, da Nord, da Sud, da
qualsiasi
parte dell'universo. Ho sempre saputo tutto semplicemente perché
ascolto tutto. Quando
Caino
decise di ammazzare il fratello io lo sapevo, l'avevo capito da
un'allusione fatta vicino all'altare dei
sacrifici.
E anche la volta in cui Noé decise di costruire l'arca ne ero
perfettamente informato. Arrivai anzi in tempo
per
suggerirgli di aggiungere i topi e le zanzare alla lista degli animali
da salvare, altrimenti se ne sarebbe
dimenticato"
"Complimenti!" lo interruppi. Il diavolo fece finta di non sentire
"Furono i miei anni più
felici.
Ascoltavo, riferivo, ovviamente travisando tutto, mettevo zizzania, ero
capace di suscitare odi o passioni
infuocate.
Lo sai come mi chiamavano? «Trico»..." "«Trico»? non l'ho mai sentito"
"E'
una
parola latina" continuò il diavolo con un certo sussiego "io sono is
qui nectit tricas, colui che intreccia i garbugli e mette i
laccioli"
"Questo lo so" lo interruppi di nuovo "e mi risulta che anche nelle
questioni di sesso ti piace fare
pasticci".
Per quanto possa sembrare strano lui arrossì. "Cosa vuoi
insinuare?"
disse. Avevo letto che certe volte il diavolo assume le fattezze di una
donna, bionda o bruna che sia ma
sempre
bellissima, e poi se ne va in giro a sedurre i maschi. In questo modo
fa scorta di sperma, che conserva
nei
suoi visceri freddi. La volta dopo prende invece corpo di maschio e
riversa il seme che ha accumulato
dentro
il grembo delle donne che seduce, fecondandole. Spesso il diavolo
assume persino le fattezze
rassicuranti
del marito, o del fidanzato, per ingannare meglio le sue vittime, così
che quelle povere
donne
pensano di aver concepito un erede del tutto legittimo. In questo modo
il diavolo riesce a ingarbugliare
persino
le parentele e le famiglie, disseminando figli naturali all'insaputa di
tutti. E' veramente un bel
Tricone,
il diavolo. "Mi riferivo alla faccenda dei cosiddetti figli del
diavolo, che in realtà poi non
sono
neppure figli tuoi..." "Queste sono cose che non ti riguardano" mi
interruppe bruscamente. Oltre che analfabeta,
il
diavolo era anche pudico.
Il treno si era fermato alla stazione di
Powell Street. In un attimo lo scompartimento si riempì di ragazzi con
in testa
il
berretto di una squadra di Baseball. L'allenatore, nonostante la
confusione che facevano, aprì "Usa
Today"
e cominciò a leggere. Il diavolo si mise immediatamente a sbirciare i
titoli. "Finisci il racconto" gli
dissi
"tanto non sai leggere". Lui fece un gesto di stizza e continuò in
questo modo "Poi furono inventati
i
caratteri dell'alfabeto. Sul momento non ci feci caso, mi pareva una di
quelle tante cose nuove, come il fuoco, la
ruota,
l'arco con le frecce, che a me non interessavano affatto. E anche
quando la scrittura si diffuse
continuai
a non badarci perché in ogni caso loro leggevano tutti ad alta voce"
"Ad alta voce?" "Certo. Una volta
nessuno
leggeva con le labbra chiuse, come fate voi. Che si trattasse
dell'inventario dei buoi reali o del
Poema
della creazione, per leggere bisognava per forza declamare. Facevano
così anche i contabili"
"Per
questo prima tenevi in braccio un tabulato di bilancio?" Il diavolo
cercò meccanicamente il suo
pacco
di fogli, ma evidentemente era rimasto sull'altro sedile insieme ai
vestiti da yuppy. "Audit" disse con aria
solenne
«Audit»? ma che diavolo...?" Lui si adombrò "Scusa. Avevi detto
«audit»" "E' questa la
formula
che si usa ancora in inglese per indicare la revisione dei conti.
Perché anche in quella circostanza c'era
uno
che leggeva le cifre ad alta voce e un altro che lo stava a sentire, in
latino audire" "Come sei pedante!" "Va bene"
riconobbe
il diavolo. Poi continuò: "Benché gli uomini scrivessero sempre di più,
io
continuavo
ugualmente ad essere informato su tutto perché ogni cosa che veniva
letta era anche recitata. Conoscevo il contenuto
delle
lettere d'amore che Fedra scriveva a Ippolito, e persino tutti i
dettagli delle fatiche di
Ercole.
A proposito, chi credi che sia stato a farlo avvelenare?"
"Disgraziato". I ragazzi scesero tutti alla fermata di
City
Center, eravamo di nuovo soli. "Poi un giorno sentii dire che a
Milano..." "In Italia?" "Se mi
interrompi
sempre perdo il filo" "Hai ragione" "a Milano c'era un vescovo che si
metteva di fronte ai libri sacri e
restava
muto per ore. Si chiamava Ambrogio.
Credevo che fosse semplicemente un
mistico contemplativo
invece
quell'uomo leggeva: ma senza pronunziare una sola parola ad alta voce.
Teneva le labbra chiuse e
leggeva
con la voce della mente. Sed cum legebat oculi ducebantur per paginas
et cor intellectum
rimabatur....."Ti
piace proprio il latino!" "Sono il diavolo" "Capisco". "Quell'abitudine
si diffuse rapidamente, ma non bisogna credere che si
sia
trattato di un grande progresso. Perlomeno non dal punto di vista
morale. Prima gli uomini erano
più
onesti..." "Ora ti sta a cuore anche l'onestà?" "Stavo parlando di
loro, non di me. Quando leggevano
ancora
ad alta voce si preoccupavano che l'autore fosse in qualche modo
presente, gli lasciavano almeno la
possibilità
di disporre di una voce. La lettura era ancora una forma di dialogo, un
racconto che l'autore
faceva
al lettore servendosi della voce di lui. Una cosa molto graziosa"
"Specie per un curioso" "Sono stato io
stesso
a dirti che mi piace sapere tutto. Un tempo i lettori erano meno
arroganti di come sono adesso,
ammettevano
di essere solo degli interpreti, o meglio degli attori che recitavano
delle frasi scritte da un altro.
Oggi
invece i lettori vogliono essere tutti degli autori, non degli
interpreti. Leggono ma non parlano, non fanno
trasparire
nulla. Trattano le cose scritte da altri come se fossero roba loro. Chi
può sapere cosa ne fanno,
dentro
la loro mente, di quello che leggono?" "E tu, che cosa ne facevi di
quello che origliavi?" "Uff". "Man mano che la gente imparava a leggere
in quel modo muto le
pubbliche
declamazioni scomparivano, e persino i poeti scrivevano zitti zitti,
senza lasciar trapelare neppure
una
rima. Le ragazze continuavano a leggere le loro lettere d'amore in
camera, la sera, ma si chiudevano
dentro
la cortina del letto e sorridevano, piangevano, languivano senza
emettere neppure una sillaba! Io andavo
persino
ad appostarmi dietro le inferriate però non riuscivo ugualmente a
captare una sola
parola.
Erano diventate tutte agitatissime e mute. E' stato allora che ho preso
l'abitudine di sbirciare" "A che scopo, se
non
sapevi leggere?" "Infatti non capivo niente..." "Ma non potevi andare a
scuola per farti
insegnare?"
"Ci
sono andato" borbottò il diavolo "ma non c'è niente di peggio di quando
le cose si studiano male la prima
volta.
Io avevo imparato l'alfabeto ebraico, e persino il demotico, ma lo
usavo soltanto alla rovescia per fare gli
incantesimi.
I maghi che frequentavo mi avevano giurato che così rivoltata la
scrittura era molto
più
potente. Solo che poi, quando andavo a sfogliare un codice e tentavo di
leggere quello che c'era scritto, non riuscivo
assolutamente
a raccapezzarmi" "Ma insomma vuoi spiegarmi perché, se non sai leggere,
ti ostinavi a
sbirciare
i titoli del mio giornale?" "Soffro tanto". Il diavolo era davvero
umiliato. Continuava a lisciarsi la sua zampa di
capra
e io, francamente, avrei tanto desiderato rimettermi a leggere il
giornale. Ma sapevo che lui avrebbe
fatto
di tutto per impedirmelo, e poi dovevamo essere quasi arrivati a Daly
City. "Secondo me" dissi "gli
uomini
hanno cominciato a leggere muti proprio per evitare che tu stessi
sempre ad origliare quello che
dicevano.
Credi che non se ne fossero accorti? Se tu fossi stato un po' meno
maleducato avrebbero continuato
a
leggere ad alta voce, e forse non avrebbero neppure avuto bisogno di
inventare i caratteri
dell'alfabeto..."
Dovevo aver colpito nel segno, perché a questo punto lui abbassò
addirittura la testa.
"Escluso"
sospirò "mi hanno escluso. Sono secoli che le idee più importanti mi
sfuggono, che faccio delle gaffes, che
trovo
sempre qualcuno che scoppia a ridere quando tricas meas nectere
conor..." "Mi vuoi spiegare finalmente
perché
sei rimasto così affezionato al latino?" "E' stata l'ultima lingua in
cui ho sentito leggere ad alta
voce
delle cose sensate". "In effetti" continuai "devi essere ben ignorante,
scusa se te lo dico.
Sicuramente
non conoscerai, che so, la Gerusalemme liberata..." "Ne ho sentito
recitare dei brani ad alta
voce"
"la Critica della ragion pura..." "Questa in effetti non l'ho mai
sentita " "E neppure i Promessi
sposi..."
"Ah no, conosco bene l'inizio: «Quel ramo del lago di Como...»" "Basta
per favore, non lo sopporto"
"Un
tempo i ragazzi lo imparavano a memoria per ripeterlo in classe..."
"Devi avere un'idea ben strana
della
nostra cultura" "Adesso non esageriamo" "Ma se non hai mai letto
nulla!" "Frequento assiduamente
tutti
i teatri, i cinema, e seguo persino la Lectura Dantis in Orsammichele.
La Divina commedia la so a memoria.
E
poi conosco un sacco di frammenti e di citazioni, io sto sempre con le
orecchie tese e ogni
tanto
capita che qualcuno dica delle frasi come «Mi illumino di immenso».
Deve essere il verso di un
poeta
famoso..." "Sono solo pezzetti, bocconcini, spizzicati di qua e di là
come se fossero gli stuzzichini
dell'aperitivo!"
"Guardo molto la televisione". Daly City. Il treno si fermò bruscamente
e io scesi quasi senza
salutarlo.
Sul marciapiede volli tirar fuori il giornale per leggerlo lungo la
scala mobile ma mi accorsi che lo avevo
dimenticato.
Troppo tardi, le porte scorrevoli si stavano già chiudendo e il treno,
lentamente,
prese
velocità. Dal finestrino il diavolo mi fece un cenno, non so se di
imbarazzo o di ironia, poi prese il giornale che
avevo
lasciato sul sedile e lo aprì. Penso che lo facesse per darsi un
contegno.
Zio Paolo che cava i denti
nella dépendance di Villa
Lamarmora,
o Peppino che affronta Baistrocchi mentre i suoi spaghetti passano di
cottura, fanno parte di storie che i
familiari
di Alma hanno sentito raccontare decine di volte, in conversazioni che
li attraggono poco ma che, dopo
pranzo,
si debbono fare per convenienza e per affetto. I familiari di Alma non
solo non hanno
interesse
per queste storie, e le ascoltano solo per amore di lei, ma soprattutto
non si sognerebbero mai di
narrarle
a loro volta. Fra i nipoti e le nipoti di Alma, per esempio, non ce n'è
uno a cui verrebbe in mente che la
storia
di Peppino e di Baistrocchi è qualcosa che si può raccontare anche ai
propri compagni di
scuola.
Le storie di Alma entrano, forse, attraverso qualche orecchia, ma di
sicuro non escono e non usciranno
più
da nessuna bocca. Quelle di Alma sono storie vecchie, come si dice, ma
non lo sono
soltanto
perché narrano fatti che appartengono al passato. L'atto stesso di
raccontarle è vecchio,
perché
si è già compiuto decine di volte. Ma soprattutto appartiene al passato
quell'insieme di sensazioni, di
immagini,
di comportamenti dati per scontati che costituiscono la sostanza dei
racconti di Alma così come
quella
di qualsiasi altro racconto. Per esempio, la storia di Peppino col
colletto duro nonostante il caldo del luglio
pugliese
è una storia vecchia almeno tre volte: perché Peppino appartiene
all'Italia del 1930,
perché
il racconto che lo riguarda è già stato fatto da Alma in molte
occasioni e perché la giustificazione di questo
colletto
duro nonostante il caldo - l'ufficiale è sempre un signore - appartiene
a un mondo che non esiste più.
Nessuno
oggi troverebbe qualcosa di interessante nel fatto che l'ufficiale
debba, anzi dovesse, essere
sempre
un signore. Tutti i racconti di Alma hanno la caratteristica di essere
un trionfo, anzi un'enciclopedia del
passato.
Per questo motivo i suoi familiari si annoiano quando lei racconta, e
non penserebbero mai di
narrare
ad altri le sue storie.
Probabilmente non le considerano neppure
storie. In condizioni normali i racconti di Alma sarebbero già morti da
un
pezzo, e la loro sopravvivenza si deve solo a una combinazione di
circostanze. Alma non può più
leggere
perché non ci vede, e quindi non rinnova la sua riserva di storie
attingendone di più attuali ai settimanali e
ai
rotocalchi. Se solo potesse seguire le avventure di attori, principesse
e politici che compaiono ovunque sulla stampa,
non
avrebbe bisogno di ricorrere a zio Paolo per fare due chiacchiere con
Aadan, e quelle vecchie storie le
tornerebbero
alla mente con molta minore insistenza. D'altra parte Aadan è straniera
e analfabeta,
dunque
neppure lei può leggere i giornali per guadagnarsi la propria razione
quotidiana di storie. E poi viene da un
paese
così remoto e lontano da trovare le vecchie storie di Alma non noiose
ma, paradossalmente,
appassionanti,
perché hanno per lei qualcosa di arcano. Dicono che la concomitanza
fortuita di certi fattori naturali a volte
finisce
per preservare i tratti arcaici di un ambiente, e persino per
svilupparli. Nello stesso modo, al primo piano
di
una casa alquanto buia del centro storico una serie di coincidenze ha
fatto sì che alcuni vecchi
racconti
non solo sopravvivano ma addirittura tornino a prosperare. E
soprattutto che torni a prosperare l'antica
pratica
del racconto. Non parlo del racconto orale professionale, quello che
ancora si pratica alla
televisione
da parte di comici, "protagonisti" e gente invitata a parlare nei
talk-show. Mi riferisco al racconto
occasionale,
fatto da una persona qualunque che parla non di eventi speciali ma di
fatti, appunto, qualunque: e che
potrebbero
appartenere alla memoria di chiunque altro. Questo tipo di racconto di
fatti qualunque, specie da
parte
di donne anziane ad altre donne anziane, lo si è fatto per millenni
(aniles fabellae, le
chiamavano
già i Romani, "racconti di vecchie"), e di sicuro ha molto contribuito
allo sviluppo della nostra tradizione
narrativa.
Solo che oggi non lo si pratica più, e ormai occorrono delle condizioni
eccezionali, come quelle in cui vivono
Alma
e Adan, perché questo genere di storie torni inaspettatamente a vivere.
Perché la scrittura è come un grosso animale, che a causa
della
propria forza e della propria mole uccide anche quando non avrebbe
intenzione di farlo. Nessun editore ha mai
deciso
di stampare il proprio rotocalco con lo scopo precipuo di distruggere i
racconti della gente qualunque
per
sostituirli con quelli di politici e top model. Ma nei fatti è questo
che accade. Sia pure in buona fede,
le
aniles fabellae sono state soppiantate dai servizi che compaiono sui
settimanali. A differenza dei familiari, Aadan è un'ottima ascoltatrice
delle
storie che Alma racconta. Però anche lei non riferirebbe mai a nessun
altro le storie che sente.
Non potrebbe farlo
neppure
se volesse, visto che tutto il proprio tempo lo passa in casa con Alma.
Ad Aadan manca un
interlocutore,
elemento fondamentale per far sì che qualunque racconto possa essere
narrato. Anche nel caso
di
Aadan insomma le storie di Alma entrano dalle orecchie ma non escono e
non usciranno mai da nessuna
bocca.
Le storie di Alma, che una sola persona desidera ascoltare, e nessuna
vorrà o potrà
raccontare
di nuovo, sono veramente arrivate alla fine del loro cammino. Come un
torrente che si insabbia perché
dalla
riva del mare lo separa l'immensa barriera del deserto. "Per arrivare
da Torino a Piazza Armerina" racconta Alma "in Sicilia,
ci
vollero quasi due giorni di treno. Papà aveva avuto il posto al Liceo
di laggiù ed eravamo
dovuti
partire in quattro e quattr'otto. L'ultimo tratto del viaggio però si
doveva fare con la diligenza perché
il
treno si arrestava molto prima della città. Salimmo e insieme con noi,
sui sedili, avevano ammonticchiato le valige e i bauli
con
i vestiti. Una gran confusione, dopo tutte quelle ore di treno! A
quell'epoca mammà portava dei bei
cappelli,
grandi, con le piume di struzzo, secondo la moda di allora. Anche sulla
diligenza per Piazza Armerina,
nonostante
il viaggio, ne aveva uno sulla testa. Un tempo le signore erano così,
sempre eleganti. Ma
quando
i ragazzini la videro, seduta là in alto con il suo cappello e le piume
di struzzo che svolazzavano al
finestrino,
cominciarono a inseguire la diligenza gridando «arrivano i
saltimbanchi, arrivano i
saltimbanchi!»
Figurati mammà, che veniva da Torino e credeva di essere elegante"
Aadan sembra attratta più dai cappelli che
dai
saltimbanchi "Tu porti cappelli" la interrompe. Alma in effetti ha
diversi cappellini nell'armadio, pur se
non
hanno le piume di struzzo e non sono grandi come quelli di mammà. "I
cappelli piacciono tanto anche a
me,
ma ora li metto di rado, solo quando fa freddo. Sai che da giovane
volevo fare la modista?" "Modista?" "E' quella che fa i cappelli, un
bellissimo mestiere. L'ho
desiderato
tanto di fare i cappelli. A Piazza Armerina invece la marchesa
Trigona..." "Nobile?" Ad Aadan i
nobili
continuano a interessare "sì, come i Lamarmora. La marchesa Trigona,
che era una gran signora della
città,
non aveva la modista per i cappelli, ma aveva il modisto" "Un
uomo?" "Un uomo, che
appunto
chiamavano
«il modisto» e che lavorava nel palazzo della marchesa. Faceva i
cappelli solo per lei. Quando
mammà
fu arrivata laggiù da qualche giorno, e ci fummo sistemati come si
poteva, la marchesa Trigona le
mandò
un biglietto in cui le chiedeva se poteva mandare il modisto a copiare
i suoi cappelli. Da tanto che erano
belli.
Si vede che la marchesa aveva visto passare mammà per strada ed era
rimasta colpita dalla sua
eleganza.
Mammà disse subito di sì, figurarsi, e questo modisto venne. Era un
ometto magrolino, molto
ossequioso,
che arrivò portando una cartella di cartone come quella dei pittori.
Mammà gli
aprì
l'armadio dei cappelli e lui li copiò tutti sopra dei grandi fogli di
carta" "Te piaceva cappelli" "Io ero piccola ma lo
guardavo
con grande ammirazione mentre disegnava le piume. Mi sembrava
impossibile che lui fosse capace di
fare
tutti i cappelli che voleva. Una sera la marchesa Trigona dette una
grande festa e invitò
anche
mammà e papà, probabilmente per ringaziare dei cappelli che il modisto
aveva copiato. Mammà
avrebbe
voluto andare, a lei piaceva ballare, però rispose alla marchesa che
non poteva perché non
sapeva
con chi lasciarmi. Io avevo solo sette anni. La marchesa mandò un altro
biglietto in cui diceva che ci sarebbe
stata
una stanza anche per i bambini, con le bambinaie, e che portassero
anche me" "Mettevi cappello?" "Sì,
avevo
anch'io un cappellino con i nastri.
A quell'epoca il cappello si
portava sempre. Il palazzo Trigona era
bellissimo,
io mi ricordo bene i lampadari che erano tutti di cristallo. Quando
arrivammo l'orchestra suonava
già,
però i bambini non potevano andare nel salone con i grandi. Invece a me
sarebbe tanto piaciuto vedere
com'erano
vestite le signore! Mi portarono subito nella stanza delle bambinaie,
dove c'erano alcuni bambini
più
piccoli di me. Io mi misi a sedere su un divano e mammà mi promise che
ogni tanto sarebbe venuta a
trovarmi.
Però non avevo paura. Tant'è vero che quando mammà venne a vedere come
stavo non mi trovò
più.
Come si spaventò, poveretta! Dice che rovistarono in tutte le stanze, e
che la marchesa in persona gridava
alle
domestiche «guardate nel ripostiglio delle coperte!» «provate nelle
cantine!» A nessuno
venne
in mente di guardare nella stanza del modisto. Io invece ero
lì, quell'ometto ossequioso mi stava
insegnando
come si disegna la tesa di un cappello e come si girano i feltri nella
forma. Lui aveva tante cose in quel
laboratorio,
avresti dovuto vedere. Persino un mazzo di piume di struzzo e rocchetti
di nastri di tutte le altezze e
di
tutti i colori. Sopra uno scaffale ci teneva gli album dei cappelli,
che gli arrivavano fino da Parigi.
«Questo
è leggero» diceva «per la mattina. Per le serate eleganti a Parigi si
porta quest'altro, con un
galà
di strass, ma qui a Piazza la marchesa non lo metterebbe mai. Qualche
volta ne porta in valigia uno simile quando va
a
Palermo, dai cugini. Bello poi è questo, tutto in velluto, per le
signore sportive che escono a
cavallo».
C'erano cappelli per tutti i momenti della giornata e per tutte le
stagioni.
Quelli estivi, di paglia e fiori di seta, sembravano davvero dei
bouquet. «La paglia si lavora
peggio»
mi spiegava il modisto «io ho poca simpatia per la paglia. Il feltro dà
tutta un'altra
soddisfazione...»
Quando mi trovarono mammà era sconvolta e il povero modisto non sapeva
proprio come scusarsi. Io non volevo
più
uscire dalla sua stanza. Da quella volta cominciai a dire che da grande
avrei fatto la modista, e quando lo
dicevo
tutti ridevano. Ma io parlavo sul serio" "Tu hai fatto cappelli?"
"Magari! Una volta ci ho provato
davvero
a dire a papà che volevo lasciare la scuola per fare la modista. Mi
sembra sempre di sentire gli urli che
fece.
Bisognava studiare, altro che fare i cappelli" "Studiare con libri" "Eh
sì, con i libri".
La mia scuola era in Via
del Platano, ma questo non mi
giustifica
dall'aver
conservato una foglia di tiglio dentro il libro di geometria. Ho sempre
evitato di mettere foglie o
fiori
fra le pagine dei libri, "gialli boccioli appassiti / fra pagina e
pagina", come dice Robert Browning in una
poesia
che non ho mai letto. Però, il fatto che la mia scuola fosse in via del
Platano, e che quella foglia fosse
di
tiglio, deve essermi sembrato una ragione sufficiente per farlo. Fu un
errore. In ogni caso, questa
analogia
mi ha sempre impedito di buttare via la foglia. Ormai credo non che ci
riuscirò più. Quella
foglia
sta lì da oltre trent'anni, e io non apro mai il mio libro di
geometria: però so che quella foglia c'è, che
è
di tiglio, e dunque che la mia scuola era in Via del Platano. Pur non
avendola mai letta, so che la poesia di Browning si chiama
Pippa
Passes. Un titolo strano. Presumo che Pippa sia il nome di una ragazza,
ma non so altro. La vedo
passeggiare
in un giardino, di fronte alla casa dei suoi genitori, con indosso un
vestito molto voluminoso e in testa
un
cappello legato da un nastro. So bene che a questo punto dovrei andare
a prendere le opere di Browning e
controllare
come stanno realmente le cose, solo che non sono materialmente in grado
di farlo. Ma anche se
potessi
alzarmi e andare in biblioteca credo che non lo farei ugualmente.
Dentro quel libro avrei paura di
trovarci
dei fiori secchi, "gialli boccioli appassiti / fra pagina e pagina",
come dice l'unico verso di quella
poesia
che conosco. Saranno stati di rosa, questi boccioli? Certamente. Pippa
li coglie nel giardino dei suoi
genitori.
E' anche probabile che fosse proprio lei a metterli dentro i libri, e
che qualcuno (Pippa stessa, il
poeta)
provasse poi una certa commozione nel ritrovarceli dentro appassiti.
Per questo non ho nessuna intenzione
di
andare a leggere quella poesia, così come mi guardo bene dall'aprire il
mio libro di geometria con
dentro
la foglia di tiglio. Negli ultimi tempi mi sono fatto delle idee molto
precise sulla poesia
Pippa
Passes, anche se non la conosco. Perché "passa", Pippa? E' strano
infatti che di lei si dica
proprio
questo, che "passa", e addirittura nel titolo. Secondo me Pippa passa
proprio perché aveva l'abitudine di
mettere
dei boccioli nei libri. Se non lo avesse fatto non passerebbe affatto.
Bisogna evitare di mettere nei libri
fiori
o foglie perché, appassendo, fiori e foglie trasmettono il tempo ai
libri: che da questo contagio sono di
per
sé immuni. Pippa si è comportata come una ragazza imprudente, che nel
roseto ha piantato una rosa con i
pidocchi,
o dentro la voliera (ci sarà pur stata una voliera, nel giardino di
Pippa) ha messo un canarino
malato.
Così tutte le rose sono seccate e i canarini sono morti. Pippa non
avrebbe dovuto mettere gialli boccioli
ad
appassire fra pagina e pagina, ecco che ora i suoi libri sono stati
contagiati dal tempo e lei, poverina,
"passa".
Già mentre ne stiamo parlando Pippa ha abbandonato la casa dei suoi
genitori e adesso è una
signora
sposata, alquanto malinconica, che vive con il marito in un
appartamento di Londra. Non ha quasi
più
il tempo di leggere, ci sono i ragazzi che vanno a scuola e una grande
casa a cui badare. Pippa passa. E non
è
ancora finita. Nessuno direbbe mai che Lucia Mondella "passa". Lucia
sta lì, e
dall'inizio
alla fine - dall'inizio alla fine del libro, dall'inizio alla fine del
tempo - continua a fare le stesse
cose:
tiene gli occhi bassi, è insidiata da Don Rodrigo, si nasconde nel
convento della Monaca di Monza. Per sincerarmi
di
quello che dico basta che io prenda i Promessi sposi e cominci a
leggerli. Lucia è sempre
lì.
Ma anche se questo non sta accadendo, se io non sto affatto leggendo i
Promessi Sposi e anzi tengo il libro
accuratamente
chiuso nello scaffale, non c'è dubbio che Lucia continui imperterrita a
comportarsi nello stesso modo.
Ci
mancherebbe altro che Lucia - non vista, non letta - si fosse messa a
fare delle cose diverse! Per
esempio,
avesse deciso di strapparsi dalla testa tutti quegli spilloni, che la
mamma le ficca fra i capelli la
sera
prima delle nozze, e fosse scappata in America per cercare Manon
Lescaut. Qualsiasi cosa accada Lucia non
passa,
è sempre lei. Invece Pippa, nel frattempo, è stata abbandonata dal
marito ed è
tornata
a vivere nella vecchia casa dei suoi genitori, dove ha ripreso a
sfogliare i suoi libri pieni di fiori appassiti.
In paese,
comunque,
si dice che abbia per amante lo stalliere dei vicini. Nella sua vita
non c'è veramente nulla di
definitivo.
Il bello dei libri invece è che, li si legga o meno, non mutano.
Si
può lasciare Robinson Crusoe sulla sua isola, a metà del volume, e
ritrovarlo trent'anni dopo sotto il
medesimo
albero. Anche il teorema di Pitagora - in un triangolo rettangolo la
somma dei quadrati costruiti sui cateti... -
non
passa. Non ha un'età, non ha un tempo, è sempre lui, come Lucia
Mondella e Robinson Crusoe. A meno che
uno
non abbia commesso l'errore di mettere una foglia di tiglio dentro il
libro di geometria, come avevo
fatto
io quando andavo a scuola. Ecco perché non penso mai di aprire quel
libro. Già
così,
solo tenendolo chiuso nello scaffale, è capace di ricordarmi che la mia
scuola era in Via del Platano, figuriamoci cosa
accadrebbe
se lo aprissi. Sarei costretto ad accorgermi che il teorema di Pitagora
è passato,
che
ha un tempo e si è appassito come quella foglia che ci avevo
imprudentemente infilato. E quella Pippa, che
metteva
continuamente boccioli di rosa fra le pagine! Più ci penso e più mi
convinco del fatto che
Pippa
è come Pandora, tutte le disgrazie dei libri vengono da lei, e forse
anche quelle dei lettori. Ecco perché al
suo
funerale non c'era quasi nessuno, solo la figlia della vecchia balia e
due cugine di Birminghan. Pippa passes.
Questo
succede, avrebbe dovuto dire il pastore nel suo sermone funebre, quando
si ha l'abitudine di mettere
gialli
boccioli ad appassire fra pagina e pagina. Se non avesse commesso
questa sciocchezza Pippa sarebbe per
sempre
rimasta la graziosa ragazza che passeggia nel giardino dei suoi
genitori. Ferma ed immobile come
Lucia
Mondella, come Robinson appoggiato al suo albero.
L'unica cosa che i
libri sopportano fra le loro pagine è il
segnalibro,
che non è contagioso e non ha nulla a che fare col tempo. A meno che
non si abbia l'abitudine di usare a
questo
scopo delle cartoline e di lasciarle poi fra le pagine a libro finito.
Dicono che il segnalibro ideale una
striscia
di cartoncino brillante, solido, con sopra l'immagine di un gatto o di
un castello. Però va bene
anche
un biglietto usato dell'autobus, o una striscia di carta strappata
dalla pagina di un quotidiano. Finito che
sia
il libro, il segnalibro viene infilato senza rammarico nel successivo e
così via, di libro in libro, oppure
viene
gettato nel cestino. L'importante comunque è non dimenticarlo dentro il
libro dopo averlo finito
perché,
se questo avviene, si fa violenza alla natura stessa del segnalibro.
Che in questo è veramente il
contrario
delle foglie o dei boccioli appassiti. Una volta racchiuso fra le
pagine, il fiore non si può più
spostare,
è irreparabilmente destinato a invecchiare nella medesima nicchia di
carta in cui Pippa lo ha racchiuso. La natura del
segnalibro,
invece, è del tutto opposta, nel suo codice genetico sta scritto che
esso deve andarsene. Con i
libri
ha un rapporto temporaneo, occasionale, mentre il fiore e la foglia
sono "per sempre" - proprio
come
gli amori di Pippa, che chiusa nella sua stanza sognava di dare il suo
cuore a uno, e uno soltanto. E invece
fu
abbandonata dal marito. Il fatto è che il segnalibro misura lo spazio,
non il tempo.
Appartiene
alla geografia, non alla storia. Man mano che avanza fra le pagine il
segnalibro funziona come una
bandierina
piantata nella mappa del libro: "fin qui", segnala, alla maniera del
comandante fortunato che dopo ogni
battaglia
marca su una cartina i progressi delle sue truppe. Il segnalibro è
bello perché con lui si
vince
sempre. Se il libro ci piace si arriva velocemente in fondo,
sbaragliando il nemico. Se invece non ci piace al massimo si
interrompono
le operazioni e si ottiene subito una tregua. Però, di sicuro, col
segnalibro non si
arretra
mai, coi libri non si perde, mal che vada si fa pari. Io sono arrivato
fin qui, dico, e il territorio che ho occupato
me
lo tengo: tu autore tieniti pure il resto, che tanto a me non
interessa. Come si sarà già immaginato, quel verso di Browning
l'ho
trovato citato in un altro libro. Me lo ero segnato - non si sa mai,
come si dice in questi casi. Sono fortunosamente
riuscito
a riprendere in mano quel libro e, in effetti, dopo pochi secondi ho
subito ritrovato il passo che volevo.
C'era
una freccia puntata a margine, non bella, anzi storta, e due o tre
righe sottolineate: "In Pippa Passes,
Robert
Browning richiama l'attenzione sull'usanza, ancora largamente diffusa,
di comprimere fiori freschi fra
le
pagine dei libri, «gialli boccioli appassiti / fra pagina e pagina». Il
fiore secco, che un tempo
era
vivo, è l'equivalente psichico del testo verbale". Non sono d'accordo
con questa interpretazione della poesia di
Browning,
anche se colui che la dà, diversamente da me, quella poesia l'aveva
letta. L'autore del saggio
vuol
sostenere che i libri, e la scrittura in generale, irrigidiscono nella
morte le parole che una volta erano solo
parlate:
e che l'uso di infilare fiori fra le pagine vorrebbe alludere al
carattere appassito che contraddistingue
ogni
testo scritto rispetto al suo equivalente parlato. Sarà. Ma quando mai
il teorema di Pitagora
era
stato una parola parlata? Eppure io a scuola, in Via del Platano, avevo
avuto la dabbenaggine di infilare una
foglia
di tiglio proprio nel libro di geometria. Francamente non sono neppure
convinto del fatto che qualcuno
possa
immaginare i Promessi Sposi nella forma di semplici parole parlate, con
Alessandro Manzoni
che
li racconta ai suoi amici seduti attorno al caminetto. Eppure, se si
cercasse bene nelle case,
chissà
quanti fiori secchi si troverebbero anche dentro i Promessi Sposi.
Come
si fa a pensare alla storia di Renzo e
Lucia
- con tutti quei "La c'è, la c'è la provvidenza" e relative cronache in
italiano secentesco - mentre viene
narrata
a viva voce da qualcuno che ha per di più un accento lombardo? Il fiore
secco non è l'equivalente psichico di un discorso
orale,
è semplicemente l'equivalente vegetale del tempo del lettore. Quel
fiore sono "io". Sta qui il mitico errore di
Pippa,
fanciulla mai abbastanza deprecata, e anche il mio. Una volta infilata
la foglia di tiglio nel libro di
geometria,
trascinato dalla colpa di Pippa, ho messo me stesso fra quelle pagine,
il mio tempo e quello del teorema di
Pitagora
si sono messi a oscillare sulla stessa lunghezza. Adesso noi passiamo
insieme. Il fiore nel
libro,
o la foglia, sono come il tizzone di Meleagro, in cui era stata
magicamente racchiusa la sua vita. La madre
dell'eroe,
Altea, custodiva gelosamente quel tizzone, ma una volta si arrabbiò col
figlio
che
aveva ucciso i fratelli di lei, e lo gettò nel fuoco a bruciare. Così
Meleagro morì, senza neanche
sapere
che la sua vita e quella di un tizzone avevano sempre oscillato sulla
stessa lunghezza. Tutto sommato, però, ho fatto bene a segnare con la
matita
quelle
righe su Browning. La mia sottolineatura, e soprattutto la freccia,
anche se sono piuttosto brutte mi hanno
aiutato
a ritrovare qualcosa che altrimenti avrei di sicuro dimenticato.
Evidentemente quella volta, man mano che
procedevo
nella mia avanzata lungo le pagine, mi ero anche preoccupato della
preda - cosa che non sempre
val
la pena di fare, con i libri che si leggono. Perché il segnalibro è un
confine rapido ma
teorico:
mentre le frecce, le barre, le sottolineature sono dei marchi molto più
concreti, valgono come tante trincee
espugnate
dal fante che avanza, tante bandierine issate non sulla mappa, al
comando, ma sul campo. Uno
sottolinea
e dichiara "questo adesso appartiene a me, caro autore", è roba mia.
Per questo non ha
molta
importanza la qualità del segno che si fa. Certo, se uno è bravo come
Petrarca può disegnare a
margine
delle belle manine, delle dita lunghe e affusolate che indicano con
eleganza i passi conquistati. Ma non
è
necessario. L'importante è segnare. Da alcuni anni a questa parte molta
gente ha preso persino l'abitudine non
di
sottolineare ma di evidenziare, cospargendo la pagina di righe
colorate, gialle, blu, rosse, che
trasformano
il testo in una tavolozza da pittore. Così anche i cattivi disegnatori
hanno l'illusione di essere
bravi.
Sono certo che mi ricorderò di tutti i passi che ho segnato
nei
libri che ho letto? Magari. Mentre scorrevo le pagine di quel libro,
alla ricerca della citazione di Browning, ho
visto
decine di frasi sottolineate, interessanti, di cui ovviamente non mi
ricordavo affatto. Eppure ero stato io a
segnare
quelle pagine.
La sottolineatura è un'esortazione, una speranza, ma non
ha nulla di sicuro. Al contrario
è
un segno di ansia, se ho bisogno di sottolineare significa che non sono
affatto certo che mi
rammenterò
di quella frase. Altrimenti basterebbe soltanto che la leggessi, senza
contaminare con le mie inquietudini
anche
le pagine del libro. Sottolineando o evidenziando cerco in tutti i modi
di accrescere il peso dello scritto,
e
quasi lo raddoppio. Adesso c'è un segno, la parola, più un altro segno,
il mio. Dopo che l'ho
marcata,
esaltando graficamente la mia conquista, è come se quella frase fosse
stata scritta due volte. Platone, che a suo
dire
disprezzava la scrittura, sosteneva che le cose veramente "importanti"
non si scrivono, si dicono soltanto:
o
se si scrivono, vuol dire che non sono importanti. Noi invece scriviamo
le cose importanti addirittura
due
volte, aggiungendo la nostra sottolineatura ai caratteri usati
dall'autore. Forse però aveva
ragione
Platone. Se dimentichiamo così in fretta tutto quello che abbiamo
sottolineato, vuol dire che quelle frasi tanto
importanti
non erano. Il fatto è che, come accade con i territori conquistati, per
mantenerne davvero il
possesso
bisognerebbe lasciare le truppe a presidiarli. Altrimenti gli sconfitti
dopo un po' si ribellano e si
sottraggono
al dominio degli occupanti. Solo che, per far questo con tutti i libri
che sottolineiamo, di quanti mai
soldati
dovremmo disporre? La sottolineatura è un presidio fittizio, una
bandiera issata su un
forte
difeso solo da manichini di stoffa. "In Pippa Passes, Robert Browning
richiama l'attenzione sull'usanza,
ancora
largamente diffusa..." Osservando meglio la mia freccia di allora, sul
margine di questa
frase,
riconosco sì che è storta ma per un motivo diverso dalla mia normale
inettitudine. Mentre tracciavo la riga
la
matita deve essersi spezzata, si vedono ancora le minuscole macchie che
la polvere di grafite ha
lasciato
sul bordo della pagina. Rivedendo quelle macchie posso anzi dire di
ricordare vagamente il momento in cui
questo
è accaduto, e quasi risento il rumore secco della mina che si rompe.
Nella sua dispersione quel
pulviscolo
nero ha disegnato come l'abbozzo di una figura, sembra quasi la corona
di un boccio. Ancora la
maledizione
di Pippa. Inevitabilmente quella frase sottolineata adesso ha un tempo
per me, e io so che ce
l'ha.
Come la foglia di tiglio mi rammenta Via del Platano, e dà un tempo al
teorema di Pitagora,
così
quella corona di grafite mi richiama inevitabilmente "me" nel preciso
momento in cui scopro l'esistenza di
Pippa,
e il significato del suo gesto solo in apparenza così gentile e
innocuo.
Ho sottolineato una frase a
proposito
dell'abitudine di mettere i fiori nei libri e, in un certo senso, è
come se anch'io ne avessi messo
uno
dentro il libro che stavo leggendo. Se volessimo tenere i libri al
riparo dal tempo, ed evitar loro ogni
possibile
contagio, non bisognerebbe neppure sottolinearli. Forse non
bisognerebbe neppure sfogliarli, per
evitare
di gualcirli, meglio ancora sarebbe non leggerli per niente e lasciarli
nello scaffale così
come
sono.
"Perché Dio, il mio Dio, è
un combattente gagliardo,
che
lotta di là dal velo". Così disse il profeta con aria di sfida, e sul
momento mi mancò il modo di rispondergli. Non
potevo
certo dirgli che il mio dio, messo a combattere anche lui dietro a quel
velo, perderebbe sicuramente.
Perché
il mio dio non è un combattente, anzi, è piuttosto fragile, e non so
neppure che mestiere faccia.
Mentre
l'altro, il Gagliardo, so bene che cosa fa e come passa il suo tempo.
Scrive libri. A scrivere cominciò quasi per caso. Dicono che prima
avesse
fatto
vari mestieri, il conciapelli, il falegname, forse addirittura il
soldato, poi aveva scoperto che scrivere gli
piaceva
e in pochi giorni aveva già steso un volume in cui descriveva le
avventure di un mitico popolo di nani: i
Resolonghi,
che abitavano sulle montagne del Falgàr. Quei nani trasportavano le
zanne dell'elefante
Bulgur
dalle miniere del Caldo al Lago dell'Avvoltoio, e durante il loro
viaggio incontravano ogni sorta di
animali
fantastici e di erbe miracolose. Fu un successo straordinario, il Libro
dei Resolonghi raggiunse
rapidamente
il milione di copie e le ristampe non si contavano più. Alle avventure
dei Resolonghi seguirono allora
quelle
dei Sumbula, un popolo di giganti che abitava ancora più a oriente, e
di cui il Gagliardo descriveva i
costumi
mostruosi e le arcane crudeltà. "Adjakar, la città reale dei Sumbula,
fu un giorno destata da un
turbine
di candide tortore..." Candide come le donne delle pianure, che i
Sumbula violentavano per motivi mistici. Fu
un
successo ancora più grande del precedente, il secondo libro del
Gagliardo fu rapidamente tradotto in
cinquantadue
lingue e la Storia dei Sumbula diventò anche un film di successo. I
ragazzi, sulla
spiaggia,
indossavano magliette con su scritto "Alozal Strambi!", la frase
pronunziata dal sire dei Sumbula in
risposta
ai motteggi del cammello turchino. Mentre le storie dei Resolonghi
venivano drammatizzate nei boschi da
adolescenti
armati di computer e di elmi di cartone.
Visto che la gente leggeva i
suoi libri con un interesse così
grande,
il Gagliardo si decise a scrivere un volume interamente autobiografico.
Vi si narrava di lui che appariva al
re
dei Resolonghi, un nano sapiente di nome Atabil, e grado dopo grado lo
iniziava alla rivelazione del
Baldrùs.
Il Gagliardo trascinava Atabil lungo i cammini della Pietraia, un luogo
dove ovviamente lo sguardo era
abbacinato,
dove le rocce erano regolarmente di cobalto e le aquile avevano almeno
due teste.
Lassù,
fra quelle pietre aspre e immacolate, il nano Atabil ricevette ogni
tipo di insegnamento - da come si dovevano
tenere
le gambe sotto il tavolino al numero esatto delle parti in cui l'anima
si suddivide - mentre il
Gagliardo,
sempre più certo della sua superiorità, trattava il re in modo
sprezzante. Lo chiamava
omuncolo,
nano, persino deficente, derideva la sua cecità di fronte al fulgore
del Baldrùs. Atabil era
sempre
più schiacciato dalla grandezza del Gagliardo, del Baldrùs non capiva
quasi niente ma aveva vergogna a dirlo
perché
sarebbe stato deriso ancora di più. Intanto i servi del Gagliardo,
montanari dalle chiome bionde e dallo
sguardo
di fuoco, accompagnavano la rivelazione con il fragore dei loro
tromboni. Atabil sentiva che la
vita
gli sfuggiva, mentre il Gagliardo era sempre più ebbro della sua
rivelazione: "al cinquecentesimo
gradino
del Baldrùs sta la pietra chamata Saà, che ama la quiete della
Sorrestra e protegge i cigni dalla nuvola di
fuoco.
Se vuoi cercare Trebanti Alfredo nell'elenco telefonico di Milano
guarda sotto Rossi Trebanti
Maddalena..."
Alla fine Atabil morì, schiacciato dal rombo dei tromboni, e il
Gagliardo lo spinse con il piede
giù
dalle rupi. Che gli importava ormai di lui? Il libro, il suo Libro, era
scritto. Le opere del Gagliardo furono presto raccolte in un solo
volume. Ma il
lavoro
era stato svolto in fretta, e benché il Gagliardo avesse talento per la
scrittura ci si
accorse
che fra le varie parti dell'opera c'erano squilibri e contraddizioni.
Il Gagliardo non si perse d'animo. Per
prima
cosa stese di fronte a sé un grande velo, poi arruolò un certo numero
di scribi e di commentatori.
Le
istruzioni le impartiva direttamente da dietro il velo, e ben presto la
sua opera riprese nuovo vigore. Le lacune
furono
colmate, le contraddizioni vennero spiegate, le parti più povere di
dettagli furono arricchite con
varianti
che si dicevano tratte dagli appunti manoscritti dell'autore. Nacque
una vera e propria filologia a servizio
del
Gagliardo, e coloro che la professavano erano capaci di intervenire sul
testo ovunque e con
precisione
chirurgica. Atabil, a un certo punto, si faceva una sauna sulla
montagna? Dato che i nani Resolonghi,
come
tutti sanno, non conoscevano la sauna, che è in uso esclusivamente fra
i popoli del
settentrione,
è ovvio che questo episodio doveva essere inteso come una pura
allegoria ahurvedica ((CONTROLLARE LA GRAFIA!)): a
significare
l'ardore che purifica dall'umore della passioni corporee. La stessa
figura di
Atabil,
talora un po' troppo quotidiana, meschina, certo inadeguata a recepire
tutta l'immensità del
Baldrùs,
fu rapidamente trasformata in una metafora dell'umanità oppressa dalla
miseria e dall'ignoranza.
Ormai
il Gagliardo si era stabilmente conquistato il suo posto dall'altra
parte del velo, e combatteva con i
suoi
nemici solo da là dietro. Nessuno è più riuscito a sconfiggerlo. Alcuni
dicono che il Gagliardo sia un mostro, altri che è un
folle.
Io so che non si tratta né dell'una né dell'altra cosa. Il Gagliardo è
semplicemente un grafomane. Per
lui
è come una febbre, ha bisogno di occuparsi di tutto, e ne gode.
Vuol
dire la sua sul modo in cui si
costruiscono
le barche, sulle genealogie degli eroi, sulle posizioni dell'amore e
sui nomi dei concessionari Ford.
Dato
che nel Baldrùs non era riuscito a dire tutto quello che voleva (eppure
la sua scienza torrenziale aveva
persino
causato la morte di Atabil), muovendosi abilmente da dietro il velo
egli fa in modo che i suoi
esegeti
arricchiscano di ogni tipo di significato anche le minime avventure dei
Sumbula o le più
insignificanti
azioni dei Resolonghi. In questo modo I tre libri del Gagliardo sono
già diventati una specie di
enciclopedia
universale. Una volta, per esempio, nacque una questione abbastanza
importante: gli scappamenti
devono
essere rivolti verso l'alto, come li hanno i bus di città, o è meglio
che siano
orizzontali?
Nel Baldrùs non c'è traccia di scappamenti, né il Gagliardo si era
preoccupato di impartire istruzioni specifiche al
povero
Atabil anche a questo riguardo. Allora si è pensato di fare così.
Interrogato da dietro
il
velo, il Gagliardo ha puntato il dito su un passo della storia dei
Sumbula, in cui si parla di un carro a quattro stanghe "che
sulle
tracce del pitone Za solleva polvere urlante sino alle stelle". Se il
carro alza polvere fino alle stelle,
hanno
commentato di qua dal velo, e questa polvere è definita "urlante", vuol
dire che gli scappamenti
devono
essere rivolti verso l'alto. Adesso si sta già provvedendo a una
generale modifica in questo senso di tutte le
autovetture
in circolazione. I Libri del Gagliardo sono scritti immancabilmente
all'imperativo,
anche
quando sembra che egli si serva dell'indicativo o del congiuntivo. Per
lui l'imperativo è una
specie
di arci-modo della sintassi, che contiene tutti gli altri e in tutti si
manifesta. Mentre racconta, il Gagliardo
prescrive:
e quando esplicitamente prescrive, come accade nel Baldrùs, in realtà
ordina. I libri del
Gagliardo
danno del "tu" a tutti, non conoscono altre forme o altri pronomi se
non questo per rivolgersi al lettore. Non fa
differenza
se si tratta di un bambino o di un vecchio, di un dotto o di un
ignorante. Lo sterminato pubblico del
Gagliardo
legge esclusivamente per ammirare, per stupirsi, per punirsi, per fare
fagotto e incamminarsi.
Non
legge mai per leggere. E come se non bastasse il Gagliardo continua a
scrivere, muovendosi dietro al
velo
su una sedia a rotelle. Cigni, marinai, bicchieri, pietre filosofali,
romanzi gialli e saggi matematici sulla
teoria
dei frattali...Si sussurra che ormai i suoi libri li detti direttamente
ai propri esegeti, i quali si
preoccupano
di arricchirli con note istantanee. Veloce come il vento, con la spada
fiammeggiante fra le mani, il Gagliardo
gesticola,
allude, significa senza dire, e la sua parola si fa istantaneamente
Libro. A me il Gagliardo è antipatico. Se Dio deve essere un
grafomane
preferisco farne a meno. Ovviamente riconosco che la vita eterna
sarebbe in sé una bella cosa, e
anzi,
come molti altri della mia generazione, per un certo periodo sono stato
anche educato a crederci. Forse la fortuna
del
Gagliardo deriva proprio da questo, che i suoi libri sono capitati fra
le mani di gente che ha
ancora
una grande nostalgia della vita eterna. Non che lui la prometta, il
Gagliardo è furbissimo e non si
metterebbe
mai nella condizione di poter essere smentito. Però tutte quelle
iniziazioni sciamaniche, quelle
pelli
d'orso che si animano e partoriscono zaffiri aromatici, rassomigliano
molto alla vita eterna. I libri del Gagliardo
sono
tutti ambientati "da un'altra parte", in luoghi simili al Tibet o alla
Siberia, e comunque sempre diversi dal
mondo
di qua. Come appunto dovrebbe accadere con la vita eterna che, se c'è,
sta per forza in un
luogo
diverso da quello in cui si vive di solito. Il Gagliardo è abilissimo
nel gioco dell'ambiguità. La
Pietraia,
le rocce di cobalto, la città dei Sumbula sono semplicemente dei luoghi
primitivi ed esotici, come il Serengeti o il
Mato
Grosso, oppure laggiù, per qualche motivo, il divino si è manifestato
davvero? La rivelazione del
Baldrùs
è una interminabile sequenza di metafore, da affidare all'antropologo o
allo psicanalista, oppure i
cammini
che essa indica portano realmente dall'altra parte dell'universo? Il
Gagliardo utilizza un'altra, sottilissima tecnica per suscitare
attraverso
i suoi libri l'impressione dell'eterno.
Spesso si allude da solo e,
scrivendo, significa abilmente la sua
stessa
scrittura. Dietro le descrizioni del sacro fiume Zaber o della Pietraia
abbacinata lascia intravedere
sé
stesso mentre, scrivendo, imprigiona in una pagina le mutevoli forme
del mondo. I Libri del Gagliardo sono
nello
stesso tempo scrittura e allegoria della scrittura. Perché fa questo?
Perché ha capito che,
fra
tutte le arti escogitate dall'uomo nel corso dei millenni, la pratica
dell'alfabeto è quella che più
rassomiglia
alla conquista della vita eterna. La scrittura realizza il bisogno di
proteggere, l'impulso a durare, l'ansia di
redimere
e di salvare. E questa stessa cosa il Gagliardo continuamente
suggerisce, lasciando vedere la sua persona
scribens
nella filigrana delle montagne calcinate dal sole. Il Gagliardo sa che
i caratteri dell'alfabeto sono
gli
ultimi barlumi di quella eternità che, a un certo punto, ci è stata
sottratta. Per questo, fra tutti i
mestieri
che poteva scegliere per diventare Dio, il Gagliardo ha pensato bene di
fare lo scrittore. "Il mio dio" risposi finalmente al profeta "è un
mingherlino,
ha
gli occhiali grandi e i capelli grigi. Sembra un bibliotecario, o
meglio ancora un vecchio zio, di quelli che vivono in
una
casa piena di libri e ogni volta finisce che ne prestano qualcuno. Il
mio dio non ha veli dietro cui nascondersi
e
gli piace anzi farsi vedere da tutti. Non combatte, non rivela, non
ordina, e soprattutto non scrive. Il mio
è
un dio che legge..." "Un dio che legge? Ma che dici?" Specialmente a
casa, la sera. Legge romanzi, poesie, libri di musica e
persino
trattati di medicina. Il mio dio è talmente schivo che sostiene persino
di non essere l'unico. Al
contrario,
dice, noi dèi siamo tanti, addirittura in numero infinito. "Ogni libro"
ama ripetere "ogni autore è una
provincia,
e ogni provincia è sotto la giurisdizione di un dio. Il politeismo non
è morto, anzi,
è
più vivo di prima. Solo che adesso si è spostato nelle biblioteche".
Una volta gli ho chiesto che cosa intendeva per
politeismo,
e lui mi detto quello che mi aspettavo. "Gli antichi pensavano che
quando qualcuno si innamora entra
nella
giurisdizione di Eros, quando si mette a commerciare occupa la
provincia di Hermes, e quando fa la
guerra
calpesta quella di Ares. Ecco perché bisogna raccomandarsi di volta in
volta a ciascuna
divinità
e implorarla di concederci il suo favore. Allo stesso modo, quando alla
sera si apre un volume delle poesie di
Rilke
si entra nella provincia di un dio pallido, fragile ma potente, che
alcuni chiamano il dio Amaro. Questo
dio
ha un aspetto un po' alabastrino, inclina alla malinconia ben disegnata
ed è cugino della Musica.
Se
invece si aprono i racconti di Diderot, o quelli di Voltaire, allora si
entra nella provincia del dio Irriverito:
che
è un dio bizzarro, simpatico, ragionatore, talmente amante del
paradosso che spesso chiede al lettore di fargli,
logicamente,
uno sberleffo. E così via. Proust conduce nella provincia del dio
Lungo, detto anche Andante
Sfumato,
mentre i trattati di medicina stanno nella provincia del dio
Preoccupato (preoccupato che la scienza
di
cui è signore muti senza che lui ne sia stato informato) e i saggi di
matematica nella provincia del dio
Riservato.
Il politeismo dei libri" dice il mio dio "è talmente vasto che non ne
possediamo neppure la
più
sommaria delle mappe. Basta pensare all'imprevedibile esistenza del dio
Tattico, che pure signoreggia nelle
Biblioteche
delle Accademie Militari, a quella della dea Tenerona, che presiede
alla lettura dei romanzi rosa,
o
al dio Cipollaccio, che si occupa dei trattati sui tulipani in vaso.
Gli dèi dei libri sono migliaia,
forse
milioni, e appartengono alle categorie e ai livelli più disparati.
Possono corrispondere a generi letterari, ad
autori,
ad argomenti, a singoli periodi storici, a momenti della
critica...Omnia plena deorum, tutto è pieno di
dèi
"dice il mio dio con un grande sorriso "ed è bello che sia così. Perché
in questo modo ciascuno
è
libero di sperdersi e di scoprire, ogni sera, in quale remota provincia
della divinità il suo capriccio lo abbia
sospinto".
Il profeta era inorridito. Non si aspettava, evidentemente, che al
mondo
esistessero ancora i pagani e gli idolatri. Si stringeva sul petto il
secondo libro del Gagliardo (che
è
il suo preferito) e mi guardava con occhi di fiamma. Ma io non mi sono
spaventato. Gli ho detto apertamente che, a
mio
parere, il Gagliardo non era affatto l'unico dio dei libri ma, al
massimo, il titolare di una fra le
infinite
province librarie, quella dei Libri sarcofago, non che il signore della
Scrittura presuntuosa. Poi gli ho
anche
spiegato che, secondo il mio dio, la vita eterna non ha niente a che
fare con la scrittura, e neppure con la
lettura.
Sulla lettura circolano infatti molte idee grandiose e superficiali, di
cui i ciarlatani si
approfittano
per vendere a questo e a quello libri che si pretendono miracolosi.
Questa gente va raccontando in giro che la
sostanza
dei libri sarebbe granitica, misteriosa, perenne, sovrannaturale. Non è
vero. I libri nascono
e
muoiono, proprio come gli uomini, e anche i milioni di dèi che li
rappresentano
sono mortali. I libri e i
loro
dèi possono avere una vita più lunga della nostra, come quella delle
querce e delle sorgenti, ma la loro sostanza
è
mortale. Anzi, è persino dubbio che i libri posseggano una loro
sostanza autonoma e particolare. Il mio dio
sostiene
infatti che i libri da soli non esistono neppure..." Come puoi provare
tutto ciò?" mi ha
assalito
il profeta brandendo il libro del Gagliardo. Ma io sapevo come
ribattere. "Voglio farti una domanda" gli ho detto. "Che cosa si legge,
quando si
legge?"
Lì per lì il profeta non sapeva come rispondere. Probabilmente gli
pareva una questione troppo facile e
troppo
difficile nello stesso tempo. Prima ha provato a dirmi "le lettere" poi
"le parole", ma io continuavo
a
scuotere la testa. Allora, credendo forse che volessi spingermi nella
provincia della semiotica e della
linguistica,
ha cercato di essere più preciso: "la frase, no, il significato..." Il
mio dio è molto paziente,
gli
ho detto, non è un energumeno come il Gagliardo. Se fosse qui di fronte
a te si limiterebbe ad alzare le spalle. Ma la
volta
in cui aveva rivolto a me questa stessa domanda, fece molto di più.
Prese infatti la pagina di un
libro
e la scosse, facendo cadere a terra tutte le lettere. "Lo vedi?" mi
disse "i caratteri dell'alfabeto sono
impalpabili
e fatti di puro colore. In sé non hanno né sostanza né corpo. Per
questo il loro oggetto
materiale
è fatto solo da colui che li legge". La lettura è una lente puntata in
primo luogo sul lettore, questo dice il mio dio. I
libri
parlano sistematicamente di noi, e ogni lettura altro non è che la
decifrazione di una parte diversa di
noi
stessi. Ecco perché per scrivere è sufficiente un solo dio, come il
Gagliardo, ma per leggere ne occorrono
tanti.
Omnia plena deorum, tutto è pieno di dèi ma noi,
purtroppo,
non siamo educati a rendercene conto. Solo raramente capiamo che cosa
significa avere il privilegio di uscire
rapidamente
dalla provincia del dio Russo, che è quello dei romanzi di Tolstoj (un
dio dall'intelligenza
grassa
ma profonda, come quella di Kutuzov), per entrare in un batter d'occhio
nella provincia della dea Ingarbugliata:
quella
che presiede alle ricerche di metrica classica. Al dio Amaro, al dio
Irriverito, ad Andante Sfumato
dovremmo
raccomandarci ogni sera - specie quando usciamo dalla loro provincia
per entrare in un'altra - e
soprattutto
ringraziarli per essere così numerosi. Ai lettori politeisti non
toccherà mai il privilegio
di
godere della vita eterna, questo è vero, ma grazie agli dèi dei libri
essi avranno comunque la
possibilità
di vivere non una sola vita ma tante tutte insieme.
A queste parole il profeta si voltò di scatto e corse via,
verso
il velo del Gagliardo. C'era una certa agitazione, là dietro.
Antonio Rendine dedicava
un'attenzione scrupolosa alla stesura
del
proprio
diario. Aveva cominciato all'età di diciotto anni e da allora non aveva
più smesso. Ma nonostante
la
diligenza con cui lo curava, e la grande quantità di tempo che vi aveva
dedicato, questo diario non
ammontava
a molte migliaia di pagine, come ci si potrebbe aspettare, bensì a
qualche decina di fogli protocollo.
Rendine
evitava accuratamente di annotare fatti di cronaca, mutamenti politici,
malattie o eventi significativi
della
famiglia. Non scriveva neppure riflessioni ingarbugliate sulla vita, né
confessioni dei propri
timori
e delle proprie speranze. Si limitava a registrare sensazioni banali,
riflessioni piatte e luoghi comuni. Il
diario
Rendine costituirebbe un documento del tutto inutile per qualsiasi
storico, anche il più
sofisticato,
a motivo della sua completa estraneità ai tempi nei quali è stato
scritto. Così come risulterebbe
mortalmente
noioso per qualsiasi lettore. Rendine aveva composto un diario
assolutamente cretino.
Le note di Rendine sono infatti di questo tipo:
"disgusto per il pesce
cappone"
"il freddo mi fa male", "chi la fa l'aspetti", e via di questo passo.
Come si vede si tratta di frasi
brevi
e talora sentenziose, ma nelle quali l'attenzione alla propria
interiorità è molto bassa e la
cui
utilità non supera lo zero. Talora l'autore si concede pensieri
leggermente più lunghi, ma tali da non andare mai oltre
le
due righe e sempre di contenuto scontato: "Mi fa male la pancia perché
ho mangiato castagnaccio. Il 27
gennaio
1972". Rendine era attentissimo alle date. Ciascun pensiero o ciascuna
sensazione portava infatti, in calce,
la
registrazione di giorno, mese e anno della medesima. Talvolta Rendine
annotava persino l'ora. Per esempio,
siamo
informati del fatto che il disgusto per il pesce cappone era stato
identificato alle 15 e 35 del
12
Gennaio 1981, mentre "chi la fa l'aspetti" risaliva alle 7 e 30 del 4
Agosto 1965. Come si vede già da questi pochi esempi, la disparità
delle
date, dalla metà degli anni sessanta, ai settanta, ai primi anni
ottanta, non comporta nessuna diversificazione nel tipo di
annotazioni
che Rendine registrava, né dal punto di vista dei contenuti né dal
punto di vista dello
stile.
Rendine ha continuato a scrivere le stesse insulsaggini, e nello stesso
modo, per oltre trent'anni. Capita anzi
che
la medesima annotazione ricorra, a distanza di tempo, praticamente
immutata. Il disgusto per il pesce
cappone,
per esempio, ricompare in forma appena variata ("che schifo il pesce
cappone" "pesce cappone, puuh!")
in
altre due occasioni oltre a quella già indicata. Queste annotazioni
ripetute, abbastanza frequenti
nel
diario, appaiono inoltre contrassegnate a margine da uno o più "bene!"
Segno che Rendine si rileggeva
spesso
e, lungi dall'esserne contrariato, accoglieva con favore questi ritorni
di sensazioni o sentimenti banali
anche
a distanza di decenni. A chi erano destinate le note del diario
Rendine? A lui
medesimo,
è
ovvio, come mostra il fatto che passava il proprio tempo a rileggersi.
Rendine si riteneva un ottimo
interlocutore
di se stesso, tanto da comunicarsi appunti e osservazioni. Questa
interpretazione presenta però una
difficoltà.
Che bisogno aveva di informare se stesso circa il proprio disgusto per
il pesce cappone o la propria
convinzione
che il castagnaccio gli faceva venire il mal di pancia? Questo disgusto
e questo mal di pancia lo
provava
direttamente lui, non aveva certo bisogno di rendersene informato. Avrà
ben saputo che il pesce
cappone
gli faceva schifo. Invece non si stancava di ripeterlo.
Forse, si dirà,
Rendine parlava con se stesso solo in apparenza.
Si
potrebbe pensare che concepisse il proprio diario non come un vero e
proprio alter ego ma come un
interlocutore
esterno, ancorché fittizio. In questo caso, la sua tendenza a
registrare insistentemente le proprie
sensazioni
risulterebbe molto più comprensibile, perché si tratterebbe in realtà
di
informare
qualcun altro, e non lui medesimo, del fatto che il pesce cappone gli
faceva schifo. Ma chi potrebbe essere questo
misterioso
interlocutore? Non è necessario supporre che si tratti di una persona
reale. Molta gente infatti usa
tenere
diari rivolgendosi ad essi con la formula "Caro diario", come se ogni
volta cominciasse una lettera. In
casi
come questi il diario, trattato con il "tu" e apostrofato con l'epiteto
di "caro", assume palesemente la
funzione
di un amico, di un cugino, di un fidanzato, a cui comunicare sentimenti
e passioni personali dello
scrivente
che si ritengono in qualche modo sconosciute al destinatario. Ma niente
di simile poteva valere per Rendine, in quale era ben
consapevole
di rivolgersi solo e soltanto a se stesso, non a un interlocutore
esterno, sia pure fittizio. Tanto
è
vero che, il 14 gennaio 1983, egli annotava: "Caro Antonio, il pesce
cappone è veramente una schifezza". A
margine
stanno tre "bene!" Come si vede, in questa nota egli si rivolgeva
esplicitamente a se stesso chiamandosi
addirittura
con il proprio nome di battesimo preceduto dall'aggettivo "caro": come
nell'intestazione di
una
lettera che si fosse indirizzato da solo. Dunque non ci sono dubbi che
Rendine intendesse la scrittura del
proprio
diario come un protratto, e talora iterato, dialogo con se stesso. Ma
che motivo poteva avere
Rendine
per continuare a ripetersi che il pesce cappone gli faveva schifo? Gli
amici ritenevano che Rendine fosse semplicemente un pazzo. In
effetti,
la sua abitudine di passare gran parte del proprio tempo a distillare
stupidaggini sembrebbe confermare
questa
ipotesi. Tanto più che Rendine, quando non si occupava del proprio
diario, si appostava dietro
le
colonne dell'ingresso per impedire al postino di avvicinarsi alla sua
porta. Questo comportamento gli era
già
costato un paio di convocazioni in questura, dove il commissario aveva
dovuto ascoltare le sue smozzicate
giustificazioni
a base di "a me quello di libri non me ne deve consegnare!" e anche "se
il postino ci riprova
col
«Club dei Lettori» lo prendo a bastonate". Nonostante queste stranezze,
però, resto convinto
del
fatto che la meticolosità con cui Rendine redigeva il suo insulso
diario avesse delle motivazioni più
profonde
e più serie di una banale mania. Non sono mancati coloro che hanno
voluto dare interpretazioni
esoteriche
del diario Rendine. Soprattutto per quanto riguarda la faccenda del
pesce cappone, e del disgusto da esso
provocato
nel diarista, si è fatto presente che circa la metà delle note relative
a questo tema
sono
collocabili in periodi in cui il sole si trova per l'appunto nella
costellazione dei Pesci: mentre l'altra metà
ha
sì una collocazione astrologica fuori da questo segno, ma cade comunque
in periodi in cui case e ascendenti sono
in
qualche modo riconducibili a segni d'acqua.
Si potrebbe perciò supporre
che Rendine, in
quelle
notazioni, utilizzasse un codice segreto, noto solo ad una ristretta
cerchia di adepti, per significare una sua
visione
dell'universo profondamente segnata dalla scienza degli astri. Per la
verità, però,
gli
interpreti stessi ammettono di non saper definire nei dettagli in che
cosa precisamente sarebbe consistita questa visione
"acquatica"
del mondo che attribuiscono a Rendine, mentre nessuna testimonianza
appare in grado di suffragare
dall'esterno
la teoria astrale. Fortuna non maggiore ha avuto l'interpretazione
psicoanalitica del diario,
inteso
come il risultato di un antico complesso di castrazione con conseguente
disgusto per il proprio
"pesce"
capponato. Non sono mancate infine spiegazioni puramente biografiche
delle peculiarità del
diario.
La moglie di Rendine era infatti figlia di un pescivendolo, e certo è
difficile escludere che questo fatto
abbia
esercitato qualche influenza sul disgusto del marito per il pesce
cappone. Ma perché Rendine non si
decideva
a parlare di questo problema con la moglie, o con il suocero, invece di
scriverlo in continuazione sul
diario?
Ho una mia interpretazione del diario Rendine, e a questo
punto
ritengo
giusto sottoporla all'attenzione del lettore. Per arrivare alle mie
conclusioni sono partito da una secca
nota
dell'autore stesso, datata 5 Luglio 1959, dal seguente tenore: "i
libri". La nota viene ripetuta anni dopo,
il
24 Maggio 1968, nella forma "libri, uff", siglata a margine con due
"bene!" Queste note così
criptiche
trovano fortunatamente dei riscontri concreti nella biografia di
Rendine. Da un lato infatti esse richiamano
la
sua antipatia per il postino, con conseguenti appostamenti nell'atrio
di casa e misteriose allusioni alla
temuta
consegna di libri. Dall'altro, esse corrispondono a una idiosincrasia
del Rendine ben nota nella cerchia
dei
suoi conoscenti: cioè a dire la sua avversione per qualsiasi tipo di
lettura. Rendine infatti ammetteva
tranquillamente
di non aver mai letto un libro in vita sua, così come evitava con
estrema circospezione
persino
il giornale. Non si trattava di analfabetismo, naturalmente, visto che
Rendine era
in
grado di tenere un diario. Egli non rifiutava la lettura per
incapacità, ma per scelta. A mio
giudizio,
la motivazione di questo atteggiamento appare indicata in due ulteriori
note di diario, entrambe risalenti
all'Ottobre
1961: "libri ammazzano", e poi "libri succhiano". Frase che non ha il
significato dell'equivalente
idiomatico
inglese "books suck" - peraltro molto volgare - come
ritengono gli interpreti. Al contrario,
questa
espressione deve essere presa in senso molto letterale, e costituisce a
mio parere la chiave del mistero. Che cosa succhiavano i libri secondo
Rendine? Anche questa nota si
spiega
tenendo conto delle personali idee sui libri e sulla lettura che
Rendine aveva sviluppato nel tempo.
Sempre
stando alla testimonianza dei conoscenti, infatti, egli sosteneva che i
libri in sé non
avrebbero
alcun significato, ma lo ricevono unicamente dall'energia mentale che
il lettore impiega per interpretarli. Questo
vale
in primo luogo per lo sforzo che si fa quando a scuola ci insegnano a
leggere interpretando le lettere
dell'alfabeto:
un'operazione molto faticosa, in cui si è costretti ad attribuire un
valore e dei suoni
particolari
a delle stringhe di segni che di per sé sono sordi e muti. Ma
l'intrinseca insignificanza dei libri, e la totale
dipendenza
del loro significato dall'intervento del lettore, sarebbero soprattutto
dimostrate dal fatto che, a un livello
di
cultura superiore, quasi nessuno interpreta un libro nello stesso modo
in cui lo interpreta anche un
altro.
E anzi, molto spesso le interpretazioni di uno stesso libro
differiscono in maniera radicale a
seconda
di chi li legge. Dunque a parere di Rendine i libri sarebbero
sostanzialmente muti e privi di vita. Sono
gli
uomini, i lettori che, credendo in buona fede di attingere significati,
trame, idee dai libri, in
realtà
gliele attribuiscono, facendosi così "succhiare" vita e midollo dalle
lettere dell'alfabeto. Un'altra immagine frequentemente usata dal
Rendine per parlare della
lettura
era la seguente: "ventriloquismo". Chiunque leggesse un libro, secondo
lui, si
comportava
come un ventriloquo, il quale fa parlare un fantoccio privo di vita
impegnando fino allo spasimo i
muscoli
della sua pancia. Secondo Rendine, insomma, tutta la cultura
occidentale non sarebbe stata altro che una
colossale
opera dei pupi, in cui uomini simpatici e intelligenti, pieni di succhi
vitali e di risorse,
avrebbero
sperperato le loro energie per dare un po' di vita e di voce a un
esercito di larve senza viscere.
Nei suoi
momenti
di maggiore odio verso i libri, Rendine arrivava addirittura a
sostenere che i libri non erano solo fantocci
immoti
ma mostri maligni, crudeli, che godevano nel succhiare le midolla degli
uomini e oltrettutto li
umiliavano,
ostentando la propria superiorità nei loro confronti. Per questo aveva
giurato a se stesso che non avrebbe
mai
letto una sola riga. E per questo stesso motivo, penso, egli passava il
proprio tempo a
leggere
soltanto cose che si era scritto da solo. In questo modo Rendine si
sentiva certo che, almeno quelle frasi,
non
gli avrebbero succhiato sangue e midolla perché si componevano di
sostanze che comunque erano
già
sue. E anzi, per maggiore sicurezza si limitava a comunicarsi
sensazioni cretine, inutili, prive di qualsiasi
rilevanza.
Sapeva infatti che, per interpretare la frase "che schifo il pesce
cappone" o "chi la fa
l'aspetti"
gli sarebbe occorsa una quantità di energia così minima che, anche
qualora quelle frasi avessero
rivelato
qualche inclinazione al vampirismo interpretativo, la quantità di
sangue che gli avrebbero
succhiato
non sarebbe stata superiore a poche gocce. Per lo stesso motivo Rendine
si sentiva particolarmente felice tutte le
volte
in cui scopriva che il pesce cappone gli aveva già fatto schifo anche
vent'anni prima: e
costellava
con i suoi "bene!" ogni insulsaggine che ricorresse più di una volta
nel corso del diario. Quanto
più
egli leggeva cose sue non solo cretine ma anche arcinote, ripetute e
consuete, tanto più egli si sentiva
al
riparo dalla vampiristica minaccia della lettura. Antonio Rendine è
morto il 4 Ottobre 1992, come rivela una
nota
del suo diario ("ahi che male"). Negli ultimi tempi egli si era
dimostrato sempre più ossessionato dal terrore
per
la lettura, e dalla quotidiana, maniacale attenzione verso la banalità
delle frasi che registrava ("quando
piove
prendo l'ombrello" "due più due fa quattro"). Non c'è dubbio che a un
certo punto la sua mente
fosse
stata sfiorata dall'ala dell'idiozia, anzi, più che sfiorata ne era
stata percossa. Ma le circostanze della sua morte
hanno
comunque lasciato una profonda impressione di inquietudine in tutta la
sua famiglia e nella cerchia
dei
conoscenti. Perché certo non è consueto che un uomo sano e fisicamente
robusto, anche se turbato da
qualche
innocua mania, si spenga per un'improvvisa emorragia dopo che il
postino aveva consegnato alla
moglie
un pacco contenente un volume del «Club dei lettori». Il giorno dopo il
postino, con
molte
scuse, passò a riprendersi il volume, sostenendo di averlo consegnato
in casa Rendine per errore.
In piedi sull'erta del
fosso non so se devo lasciarmi
scivolare
giù
o invece non sarebbe meglio tornare indietro, perché la scesa è troppo
ripida. E' il cuore
dell'estate,
scivolare lungo un'erta erbosa pare la cosa più naturale del mondo.
Intorno è ancora tutto pieno di fiori. Ma
sarà
pericoloso? Il dubbio dura solo un attimo perché nel calcagno sento uno
schiocco forte, come di un grosso
elastico
che si rompe, poi un dolore acuto. E cado giù. Possibile che mi abbiano
tirato una sassata in un
calcagno?
Ma no, dietro di me non c'è nessuno e devo semplicemente essermi
slogato una caviglia. L'ultima immagine
che
mi rimane, da prima della caduta, è quella di un pescheto carico di
grossi frutti color di rosa.
Sarà
meglio risalire in macchina e cercare un pronto soccorso. Il pronto
soccorso lo trovo in una cittadina della pianura, un
bell'ospedale
piccolo e dall'aria pulita, dove un infermiere mi carica subito su una
sedia a rotelle e mi porta
all'accettazione.
Nome, età, indirizzo, la solita cerimonia, poi vengo accompagnato nella
sala delle radiografie. La
caviglia
si gonfia, e fa male. La radiologa è categorica, di rotto non c'è
nulla.
Comincio
già a rassegnarmi all'idea che, al massimo, mi toccherà passare qualche
giorno seduto col piede appoggiato su
una
sedia: "a guardare le olimpiadi" dice l'infermiere che mi spinge ("a
leggere un libro" correggo mentalmente).
Entriamo
dal medico di guardia. E' un grande uomo con la pipa, non si alza
neppure da dove è seduto
e
molto rassicurante mi dice "nulla di rotto, si tratta solo di una
distorsione". Dopo di che infila nuovamente le
radiografie
nella busta e comincia a riempire un foglio. Come già avevo fatto in
radiologia, indico
al
dottore il punto in cui la caviglia mi fa più male. Di fronte a questo
stesso gesto la radiologa aveva sì
commentato
"lì c'è il tendine", ma questa affermazione non aveva portato alcun
seguito concreto. La mia
insistenza
sul "punto del tendine" non smuove neppure il dottore con la pipa, che
resta seduto dov'è e
non
ritiene necessario venirmi a palpare. Una settimana di riposo, se fa
male posso mettere del ghiaccio.
L'infermiere
mi fa la più bella fasciatura elastica che abbia mai avuto in tutta la
mia vita. Certo che esistono
certi
materiali, al giorno d'oggi! L'infermiere stesso ne è molto orgoglioso.
I giorni passano, la caviglia continua a far male però si
sgonfia
leggermente. Impossibile reggersi sulla gamba o camminare, forse lo
deve fare. «L'u' dd'ha fa'», lo
deve
fare, mi dice scherzando un amico al telefono. E' la frase che il
meccanico del suo paese usava quando
qualcuno
gli portava una macchina che faceva uno strano rumore nel cruscotto o
prendeva gas un po' troppo
lentamente.
Sarà che lo deve fare, ma la caviglia non regge. Seduto in giardino,
mentre l'estate infuria
lontano
da me, leggo libri sulla cultura orale e anche un romanzo in tedesco.
Quale migliore occasione per leggere cose
che
altrimenti non leggerei? Max Frisch, Homo faber, un bel tedesco facile
che va bene anche per me. La
lettura
di Frisch mi assorbe molto. Quando l'aereo del protagonista compie il
suo atterraggio di fortuna e
i
personaggi passano alcuni giorni nel deserto messicano, sono
sinceramente proccupato per la loro sorte (dato
che
non riesco ad acchiappare un vocabolario, che sta al piano di sopra,
solo per intuizione arrivo a
capire
che laggiù il caldo è talmente infernale che le donne osano girare con
indosso il solo "reggiseno",
Büstenhalter).
I soccorsi arriveranno in tempo oppure no? Non riesco a staccarmi dal
libro, nonostante il
fastidio
della caviglia devo arrivare al momento in cui li tolgono di lì. Per
fortuna un elicottero
atterra
e sono salvi. Ma non sono salvo io. Dopo qualche giorno decido di farmi
vedere dal medico che qualche volta
mi
ha curato per il mal di schiena. Venga qui, dice, stia fermo in piedi,
adesso cammini. Mmh, distorsione,
provi
a non caricare sulla gamba sinistra e se mai a mettere dei grossi
zoccoli di tipo olandese. Gli
racconto
dello schiocco che ho sentito, sarà mica che mi sono rotto il tendine.
Il dottore sorride molto
canzonatorio
e mi dà una pacca sulla spalla. Se fosse il tendine, dice, sa che
dolore sentirebbe! Esco con le
stampelle.
Compráti gli zoccoli olandesi mi pare d'essere diventato un infermiere
anch'io, ma le cose non migliorano.
Passano
altri giorni, il romanzo di Max Frisch comincia mio malgrado a
languire. E se mi facessi fare un po' di
fisioterapia
da un medico sportivo? Con tutte le distorsioni che vedono in partita,
devono essere dei maghi
della
caviglia. Prendo l'appuntamento per il giorno dopo.
Una volta raggiunta
la sicurezza che i passeggeri
sono
stati tratti in salvo dal deserto messicano, e capito che il caso, o la
necessità, sta trascinando
il
protagonista di Homo faber a incontrare nuovamente il suo antico amore
in un paese dell'America Latina, mi
decido
ad abbandonare il romanzo di Frisch al suo destino. Il tedesco è troppo
impegnativo per una
persona
che porta grossi zoccoli da infermiere e ha una caviglia gonfia.
Casualmente il postino mi consegna un pacco,
contiene
l'edizione di alcuni Dialoghi di Seneca. Chissà che non servano a
consolarmi. Li leggo
diligentemente,
trovo delle belle frasi, ma almeno il De Providentia mi lascia
scettico. Vado dal medico sportivo. Il quale, visto semplicemente il
modo in cui cammino, esclama
"ma
lei
ha la rottura del tendine di Achille!" Mi spiega che si capisce già
solo da come il paziente mette il
piede.
Un rapido esame conferma la diagnosi in modo inequivoco. Altro che
fisioterapia, ci vuole un intervento e la
faccia
del medico sportivo fa presagire che non si tratta di una cosa banale.
Ma possibile che gli altri due
medici...
balbetto io. Lui si stringe nelle spalle. Afferra il piede e me lo
articola, il muscolo del polpaccio
resta
immobile. Il tendine rotto non comunica il movimento. Pare che anche
gli studenti di medicina
conoscano
questo sintomo e sappiano riconoscerlo. A patto, naturalmente, di
avvicinare almeno una mano al
piede
del malcapitato, cosa che nessuno aveva fatto finora. Ma poi chissà.
Seneca direbbe che i
voleri
della providentia sono, almeno per il momento, imperscrutabili.
Nonostante il periodo sfavorevole, Ferragosto, trovo
rapidamente
qualcuno
disposto a operarmi. Sono fortunato o almeno mi sembra. Però ho una
preocupazione. Cosa mi
porto
da leggere in ospedale? Penso che devo ancora finire i Dialoghi di
Seneca, e stavolta aggiungo anche
i
Contes di Diderot. Lettura abbastanza gaia, Le neveu de Rameau lo
conosco già. Mi piace la
storia
di questo briccone che viene invitato a pranzo, a turno, nelle case dei
conoscenti ma a patto che
non
dica una sola parola. E quando costui rompe la consegna, cercando di
partecipare alla conversazione, si alza
un
coro ironico e adirato, un solo grido "Oho, Rameau!" E il poveretto
annega il viso nel piatto e nella
sua
"fureur", mentre gli altri convitati scoppiano a ridere. Ma mi piace
molto anche il racconto Mystification,
che
ho tempo di leggere sul lettino dell'ospedale. Salgo sulla barella con
la testa piena di Diderot. Che buffo,
penso,
scendere
in una sala operatoria mescolando l'ansia per l'intervento e le
invenzioni che un impostore,
fingendosi
medico, ha inventato per farsi restituire da una donna un ritratto
compromettente. La parola che mi
torna
in mente più spesso è "mystifié". Ancora non so che si tratta in realtà
di un presagio, di un
maledetto
omen relativo a quello che sta per capitarmi. L'anestesista è gentile e
mi spiega che subirò
un'anestesia
di tipo "tronculare", limitata alla sola gamba. Mi prega anzi di non
spaventarmi se sentirò delle grosse
scosse
elettriche nel piede e nel polpaccio. Così accade in effetti, più che
spavento comunque si
prova
dolore. Nello stordimento generale sento che, mentre i chirurghi
tagliano, l'anestesista si chiede perché in
Italia
esistano vari posti che si chiamano «Zambra». Trova che il nome sia
strano, io invece trovo
bello
che un anestesista, in sala operatoria, abbia delle curiosità di questo
tipo. Con un filo di voce gli chiedo
"vuole
proprio sapere che cosa significa il nome «Zambra»?" Lui meravigliato
risponde che lo vuole sapere, e
io
gli dò la mia flebile etimologia. Flebile ma, crederei, esatta. Poi non
ricordo più niente. Mi sveglio con un gran dolore, e corrono ad
allentarmi il
gesso.
Capita
con quello post-operatorio, dicono, spesso è troppo stretto e l'arto
invece si gonfia più del
dovuto.
Adesso trasformiamo il gesso in una doccia e vedrà che passa tutto. Non
passa gran che, adesso le facciamo
un'iniezione,
dicono, stia tanquillo. Che roba è? chiedo. "Contramal".
Un nome molto
esplicito per un antidolorifico. Nello stordimento
dell'anestesia
e del "Contramal" mi viene in mente Lessing con la sua teoria dei
"redende Namen", ovvero "nomi
parlanti".
Nelle commedie di Plauto i personaggi portano spesso dei nomi che già
da soli sono in grado
di
significarne le caratteristiche: Pseudolo ovvero il "Mentitor di
inganni", Arpace ovvero "Colui che rapina",
Pasicompsa
ovvero la "Tutta bella". Anche il mio "Contramal" è un nome parlante
dello stesso tipo.
Parlante
e benefaciente. Il mio vicino di stanza è un uomo bruno e pelosissimo,
guarda la televisione dalla mattina alla sera
e
mi impedisce di leggere. Del resto non so neppure se ne avrei voglia.
Per tre giorni godo di
un'informazione
completa sul mercato del calcio con relative coppe estive, sul parto
dei leoni marini e sui "cliffs" delle
isole
Aaran. Inoltre ho imparato a memoria alcune decine di pubblicità
differenti. Ho letto con fatica
qualche
pagina del De Otio di Seneca, penso con l'argomento che anche
all'ospedale si è costretti a stare in
ozio.
Ma lette sul campo, le esortazioni di Seneca paiono non solo fiacche
ma, qualche volta, persino ipocrite. Quanto a
Diderot,
è rimasto a dormire nel cassetto del comodino. Mi rimandano a casa
quasi subito. Il gesso che ho non va bene e deve essere cambiato. A una
prima
visita
tutto risulta in ordine, il piede è gonfio e smagrito e fa anche male.
Ma dopo un intervento è ovvio
che
sia così (per forza, "l'u' dd'a fa"). Il guaio è che fa male sempre di
più. A casa riesco a
leggere
solo un po' di giornale, decido che Seneca riuscirà a consolare quelli
che stanno bene ma non certo i
malati
veri, Max Frisch vola chilometri sopra la mia testa, come i suoi
aeroplani che cascano nel deserto messicano, e
Diderot
è troppo difficile da seguire. Se si esclude però Ceci n'est pas un
conte, un raccontino a
dialogo
che mi piace per il tono insolitamente duro che l'interlocutore
fittizio di Diderot si permette di usare con
il
suo autore. Bisogna essere davvero un grande scrittore per accettare di
essere trattati così male da
uno
dei propri personaggi. Al mio nervosismo fa bene il tono perentorio di
quell'ignoto interlocutore. Non quanto bene
mi
fa il "Contramal", naturalmente, meraviglioso nome parlante che mi
aiuta a sopravvivere qualche notte.
Visto
che non posso leggere, perché il piede mi fa sempre più male, penso
improvvisamente che potrei
mettermi
a scrivere, magari senza farmi trattare male dai miei personaggi come
faceva Diderot. Del resto non
potrei
neppure permettermelo, so bene che per farsi maltrattare a quel modo
bisogna essere grandi. E poi non
ho
bisogno di essere ulteriormente maltrattato. Non potendo dormire, la
notte ho cominciato a guardare la
televisione.
Ho già acquisito una certa competenza sulla differenza fra le reti
virtuali e le reti reali
(Rai
due, dopo le tre del mattino) per merito di un professore dall'accento
piemontese che tiene lezioni di
elettronica
all'università notturna. Soprattutto ho rivisto molte puntate del
tenente Kozjack. Mi cambiano di nuovo gesso. Pare che il dolore, che
aumenta di
giorno
in giorno, sia causato dal fatto che ho un gesso troppo piccolo, adesso
mi rinchiudono la gamba con tutta la
coscia.
Nella sala gessi ho modo di apprezzare la straordinarie competenze
sportive di dottori e
infermieri,
che usano calcio o ciclismo come una sorta di codice esclusivo in cui
cifrare ogni tipo di allusione e di
battuta.
Nonostante i giorni trascorsi in camera col mio vicino bruno e peloso,
nonché le svariate notti
televisive,
io non capisco quasi nulla di quello che si dicono. Con nostalgia
ripenso al mio "Contramal", dal nome
così
esplicito e parlante. Un dottore in particolare mi colpisce. Ha un fare
gentilissimo, ma conosce persino i
nomi
delle componenti la squadra italiana di ciclismo femminile non che
quello dei vari individui
(età,
professione, etc.) con cui le più carine hanno affari di cuore. Con il
mio enorme salame di gesso vengo caricato
a
fatica in un'automobile e riportato a casa di peso. I dolori aumentano.
Adesso trascorro le mie giornate su
una
poltrona a rotelle, il dolore mi distoglie dalla lettura ma non dalla
scrittura, che per qualche ora
almeno
continua ad essere in grado di distrarmi. Scrivo su una mensolina
appoggiata sui braccioli della
poltrona.
Che cosa scrivo, poi, lo sa solo dio. Sto inventando strane storie in
cui compaiono il diavolo nella
metropolitana
di San Francisco, un divino grafomane che ho chiamato «il Gagliardo»,
uno scozzese
ossessionato
da un bicchiere e persino Aconzio e Cidippe (la cui vicenda non sono
riuscito a rileggere perché non
posso
procurarmi le Heroides di Ovidio). La notte mi inebrio di "Contramal",
con un misto di orrore e di lusinga ho
appreso
che si tratta di un oppiaceo.
L'ho scoperto quasi per caso, da una
frase incidentale delle istruzioni
per
l'uso: "Come tutti gli oppiacei, anche il Contramal...". Durante il
giorno nella mente mi riaffiorano
antiche
storie della mia famiglia, uno zio di mia madre che faceva il dentista
nell'astigiano, un ufficiale che
proprio
non si rassegnava all'idea di sposarsi, mia madre piccola a Piazza
Armerina con mio nonno professore
e
la mia nonna col cappello. La notte continuo a guardare la televisione,
dopo le due, su Rai Uno,
mandano
in onda i programmi di oltre trent'anni fa. Con stupore rivedo Lelio
Luttazzi, Johnny Dorelli, le
gemelle
Kessler, Giorgio Gaber che sembra un adolescente, la bellissima Mina.
Forse aiutato dal mio
oppiaceo,
la notte rivivo tutta la mia infanzia e a tratti, nel dolore, sono
incredibilmente felice. Essendo la situazione insostenibile, mi
ricoverano nuovamente
in
ospedale.
In realtà nessuno capisce che cosa abbia. Mi visitano e mi rivisitano,
faccio eco- di qualsiasi tipo
e
di ogni possibile terminazione morfologica (eco-doppler, eco-grafia
etc.), per fortuna mi hanno
tagliato
il gesso, riducendolo a una semplice doccia, e quando non mi vedono
posso togliere la gamba dall'astuccio e
massaggiare
dolcemente il tallone. Casualmente ho fatto una grande scoperta. Non so
se abbia a che fare
con
qualche principio della medicina cinese o con la più banale, e
occidentale, dinamica del dolore
umano,
ma quel massaggio tallonare, assieme al "Contramal", è l'unica cosa che
riesce a placare un po' il
mio
dolore. Vivo in una stanza tranquilla e in un reparto dove tutti sono
disponibili, se si esclude naturalmente la
capacità
di capire perché sto male. Nella mia solitaria posizione fetale, con il
tallone nella mano sinistra e un
piccolo
volume BUR nella destra, rileggo tutto Guerra e Pace. Avevo cominciato
con Agatha Christie, temendo la mia
abituale
incapacità di leggere col male al piede, ma la fortunata scoperta del
massaggio tallonare, una
delle
poche tappe benefiche del pensiero medico, almeno per quel che mi
riguarda fino a questo momento,
mi
spalanca inattesi orizzonti di lettura. Vado talmente in fretta che non
fanno in tempo a portarmi
tutti
i volumi che mi occorrono. In quattro giorni i medici non hanno ancora
capito nulla di quello che possa
riguardare
i miei dolori, ma in compenso io sono già valorosamente giunto
all'epilogo del romanzo. Che
Tolstoj,
secondo me, avrebbe potuto anche risparmiarsi perché è molto più brutto
di tutto
quello
che precede. E' come se Alessandro Dumas, non richiesto, avesse
direttamente aggiunto ai Tre moschettieri
un
riassunto
di Vent'anni dopo. Ma questi giorni passati a massaggiarmi il tallone
in compagnia di Napoleone, di Pierre,
di
Natascia, e del rude Bagrátion che cavalca incurante delle pallottole e
degli ordini ricevuti, resteranno
fra
i più belli e i più dolorosi della mia vita. Disgraziatamente, dopo
qualche giorno un medico mi piomba
nella
stanza
fuori orario, alle otto di sera, e si accorge della mia astuzia
tallonare. Continua a non capire
perché
ho male al piede ma in compenso mi rimprovera come uno scolaretto colto
in fallo e mi rinchiude
definitivamente
la gamba nella doccia di gesso, legandola con una fascia.
La lettura si
riduce, aumenta il "Contramal".
Dopo
due giorni mi fanno un nuovo gesso, il quarto, stavolta in vetro
resina, e mi rimandano a casa. E'
certo
che con questo nuovo apparecchio non avrò più dolore. La prima notte
già
impazzisco,
alla televisione rivedo per l'ennesima volta La dolce Vita (non ne ho
mai sopportato il finale, come in Guerra e Pace) e un film
dove
Amedeo Nazzari va a caccia di briganti post-unitari in Sicilia. Sono
ridotto talmente male che quando
"Rraffa-Rraffa",
il capo brigante, muore accoltellato dal suo rivale, mi metto a
piangere. E sì che
avrei
dovuto essere contento, era lui il cattivo. I giorni passano, siamo già
sopra quaranta, e si avvicina la
data
in cui avrò diritto a un gesso più piccolo con il quale potrò uscire e
poggiare finalmente il piede per terra.
Il
mondo mi è divenuto abbastanza indifferente, se si esclude la voglia di
scrivere (mi sto appassionando al tema dei
fiori
messi ad appassire nei libri) e di prendere "Contramal" all'inizio
della notte. All'ospedale, dove sono
tornato,
scongiuro un ortopedico di lasciarmi il gesso aperto, magari solo per
qualche giorno,
affinché
io - ecco, io possa far vedere il piede a qualcun altro, magari un
reumatologo, o un neurologo! Mi sono fatto
coraggio
e ho detto bruscamente quello che desideravo dire da tanti giorni (nel
tono penso di essermi ispirato
inconsciamente
all'interlocutore di Ceci n'est pas un conte, quello che trattava male
il suo autore). Per tutta
risposta
l'ortopedico mi solleva il piede, mentre sto seduto su un panchetto
della sala gessi, e me lo martella
qua
e là chiedendomi se sento delle scosse elettriche. Sì, forse qui,
aspetti, dico, forse anche
qui,
ma lui va talmente veloce col martelletto che non riesco a distinguere
fra dolore, formicolio, scosse elettriche e
nulla
cosmico, quello in cui navigo ormai da tanto tempo. Penso con amara
nostalgia a quando ero entrato nella sala
chirurgica
con la mente piena di Diderot. "Mystification". A quei tempi pensavo
che il mondo avesse un
ordine
e che ci si potesse permettere di entrare nella sala chirurgica con la
testa che uno preferiva. Mi
sbagliavo.
Non riesco quasi più nemmeno a scrivere. Un amico, a cui ho
fatto
leggere alcuni dei racconti composti durante la malattia, mi assicura
del fatto che quello scritto nel
momento
di maggior dolore è senz'altro il migliore. Come possono essere buoni
gli amici, o forse, come può
essere
bizzarra la vita. Dopo due notti di Gaber con faccia da bambino e di
reti virtuali, col solito professore
piemontese
inquadrato da camera fissa su sfondo di formule, non che alla fine
delle gocce di "Contramal", mi
decido
a farmi vedere da un altro ortopedico. Gli basta sentire la descrizione
dei sintomi, gli stessi
che
tante volte ho già tentato di spiegare sfruttando tutte le risorse
della mia eloquenza, e il nuovo ortopedico
mi
dice che evidentemente mi è stata lesa qualche terminazione nervosa
durante l'intervento e il dolore
deriva
da questo. Un esame meticoloso, condotto con una penna rovesciata dalla
parte del cappuccio e usata
come
se fosse un martelletto, conferma la diagnosi. L'ortopedico, un
professore tranquillo e dagli occhi molto
dolci,
gira finalmente la penna dalla parte con cui si scrive e segna il punto
in cui secondo lui la lesione
è
localizzata: con una bella croce blu. Debbo ricoverarmi per essere
operato nuovamente. Chiedo di
essere
ricoverato
in un'altro ospedale, sono fortunato, mi prendono.
Nella speranza di
poter almeno tornare al
massaggio
tallonare, se mi tolgono il gesso per accertamenti, decido di portare
con me Anna Karenina . E' sabato
pomeriggio,
l'ospedale rigurgita di parenti (quasi tutti venuti dal sud) e di casi
così gravi che
non
si potrebbe nemmeno immaginare. Mi accuccio nel letto che mi è stato
destinato mentre intorno
sento
parlare di anche rovesciate e rifatte, di femori spaccati, di necrosi
ossee che si spandono a macchia di leopardo
e
che i medici del luogo, con pazienza infinita, individuano e
sostituiscono con protesi costruite in
strane
leghe. Mi viene tolto il gesso e con un piacere indicibile posso
ricominciare a praticare il mio
massaggio
tallonare. Per la notte chiedo, e ottengo, un'iniezione di "Contramal",
Anna Karenina è
bellissimo.
In quel letto d'ospedale il mondo ha paradossalmente, e dolorosamente,
riacquistato una parte del suo
significato.
Non so se è solo un'impressione mia, che vengo da una lettura recente
di Guerra e pace,
ma
com'è bravo Tolstoj a darti l'impressione che il tempo è passato, che
la nobiltà
russa
non è più quella dei tempi di Kutuzov e dello Zar Alessandro! Gli
bastano pochi accorgimenti, come sostituire le parole
francesi
di Pierre e di Natascia con quelle inglesi di Dolly e di Kitty. Quando
leggevo queste cose da
ragazzo
non mi accorgevo di nulla, forse ero preso solo dall'adulterio di Anna
e dalla cinica passione di
Vronskij.
Invece quell'amore era soltanto una delle fibre che componevano
un'umanità molto più
complessa.
In quell'ondeggiare fioco di luci, malati e corridoi, mi viene in mente
un verso di Yeats: "giovani ci siamo amati
/
senza capirne niente".
Il giorno in cui
l'interprete scese dalla cattedra mi accorsi
che
teneva
un coltello nella tasca della giacca. Gi altri, troppo impegnati ad
applaudire, non notarono il pomello d'ottone
che
sporgeva fra i cappucci delle penne. Ma io sì, e mentre mi passava
accanto sfilai il coltello
con
delicatezza lasciandolo cadere nella mia cartella. Prima o poi sarebbe
venuto a riprenderselo, e allora avrebbe
dovuto
darmi delle spiegazioni. Si trattava di un oggetto solido, dalla lama
lunga e ricurva, come
quelli
che usano i cacciatori. Il manico era di corno e terminava con un
pomello di ottone lucente. Se l'interprete
fosse
stato meno vanitoso, e si fosse accontentato di un coltello ordinario,
io forse non lo avrei notato e
questa
storia non sarebbe mai cominciata. Invece, dopo qualche ora, il
campanello suonò e l'interprete,
visibilmente
imbarazzato, entrò nel salotto di casa mia. "Lei capisce..." disse per
prima cosa. Io non capivo, ma lo
pregai
ugualmente di sedersi. Era un grande interprete, molto rispettato, non
potevo lasciarlo in piedi. Il
coltello
stava sulla cassapanca sotto la finestra, in pieno sole. "Tanto vale
che lei mi spieghi subito a che cosa le serve" dissi "poi,
per
quel che mi riguarda, se lo può riprendere". L'interprete allungò una
mano verso la cassapanca,
ma
subito la ritrasse. "Ci sviscero" disse rapidamente. Come avevo fatto a
non pensarci? Quella parola mi
attraversò
la mente come un lampo e mi parve addirittura di vedere la scena.
L'interprete, con in mano il suo
lungo
coltello da cacciatore, stava seduto alla scrivania e sviscerava i
libri. "I testi" precisò
"non
si sviscerano libri, ma testi". "E non si insanguina?" chiesi con un
moto di disgusto "A volte sì. Ma
è
necessario". Ho un cane, e a queste parole dell'interprete lo vidi
alzarsi di scatto con la coda puntata a terra,
fremente,
come se aspettasse di lanciarsi da un momento all'altro in un
inseguimento. Così rimase, in
attesa,
per quasi tutto il tempo del nostro colloquio. "I testi sono come
animali selvatici" continuò
l'interprete
"io li bracco, li abbatto, e quando sono finalmente nelle mie mani li
metto nel carniere" "E dunque? " "Si
tratta
di selvaggina, prima di ogni altra cosa i testi devono essere
sottoposti a un trattamento speciale. I
cacciatori
hanno una parola apposta per indicarlo, si dice «starnare», e consiste
nell'aprire la pancia
dell'animale,
un fagiano, una lepre, o quel che sia, per strappare via le viscere con
un colpo netto.
Se questa operazione non
viene
compiuta subito si rischia che tutta la bestia prenda sentore di
selvatico e diventi immangiabile"
"Dunque
questo coltello le serve per starnare i testi?" "Per sviscerarli" disse
l'interprete con un sorriso
sottile
"i testi si sviscerano, non si starnano. Le piace la selvaggina?" "Sono
contrario alla caccia". Ci fu un momento di imbarazzo. "Fate tutti
così?" domandai
"Più
o meno. Solo che molti interpreti non sono capaci di sviscerare
veramente un testo. Lasciano dei residui, non
puliscono
bene, e dopo qualche tempo il testo comincia a puzzare. Ragion per cui
diventa immangiabile. Allora
devono
chiamare qualcuno di noi, interpreti più bravi, perché lo svisceriamo
da capo. In
questi
casi il coltello non basta" "Non basta?" "No, occorrono strumenti più
sofisticati, come si usa dire. Conosce
l'opera
Anatomia della critica? L'ha scritta Northrop Frye, un interprete molto
famoso. E' un trattato completo, per
qualsiasi
dubbio può dare un'occhiata lì. Comunque una cosa è certa, il cattivo
lavoro degli
interpreti
precedenti può avere effetti disastrosi. Se non si sviscera bene fin
dall'inizio, la selvaggina è compromessa e
il
testo risulta irrecuperabile. Resta quell'odorino, come dire..." "E se
uno mangia un testo che non è
stato
sviscerato a dovere?" "Niente di grave, però non lo assimila. Sarà
capitato qualche volta
anche
a lei di leggere senza assimilare. Quasi sicuramente si trattava di un
testo che precedentemente non era stato
sviscerato
come si deve. D'altra parte, se non si assimila, che cosa si legge a
fare? Lo dicevano anche
gli
antichi che la vera cultura è un fatto di digestione, non di accumulo.
E' perfettamente inutile tenersi
tutta
quella roba sullo stomaco, dicevano, se poi non entra in circolo a
formare nuova sostanza per l'organismo,
nuovo
sangue e nuove forze" "Io credevo che i libri andassero già bene come
sono" "I libri forse
sì,
i testi no di sicuro. I testi sono crudi, sporchi, quando si prendono
in mano la prima volta fanno quasi
impressione.
Gliel'ho detto, sono come selvaggina, per questo hanno bisogno di un
trattamento particolare". A
queste
parole il mio cane, sempre fremente e in posizione di attesa, si mise
ad abbaiare come se fosse
impazzito,
e mi ci volle un po' per calmarlo. "Solo delle belve" continuò
l'interprete "divorerebbero una
lepre
o un capriolo ancora palpitanti, con la testa e il pelo.
Ma si sa che
le belve non conoscono la cultura, non
distinguono
fra il cadavere e la carne da consumare come cibo. In sostanza non
sanno la differenza che c'è
fra
il crudo e il cotto. Le belve azzannano, si lordano la bocca di sangue,
gli uomini invece, fin dagli
albori
della civiltà, hanno scoperto l'arte di lavorare la carne e di
cucinarla. Alcune lingue usano persino due
parole
diverse per distinguere la carne viva e insanguinata da quella che si
può consumare. Per un
francese
la «char» è una sostanza ripugnante, un pasto da belve, mentre la
«viande» è un cibo
delizioso.
La stessa cosa accade con i testi che l'interprete, sviscerandoli,
rende commestibili e assimilabili. La funzione che noi
interpreti
svolgiamo è per l'appunto quella di far entrare i testi nella cultura.
Prima del nostro
intervento
sono solo dei brandelli di natura bruta, dopo" così dicendo
l'interprete ammiccò in direzione del
suo
coltello, che nel sole risplendeva di acciaio e di ottone "fanno parte
a tutti gli effetti della civiltà. Una volta
sviscerato
a dovere, il testo è completamente culturalizzato. Nel senso che non
crea più alcun problema,
né
di odore, né di sapore". Quell'uomo era disgustoso. "Ma io non credo
affatto che i libri..." "i testi" mi corresse lui "va
bene,
i testi si debbano mangiare. E per questo non penso neppure che lei sia
autorizzato a sviscerarli" "Si
sbaglia"
ribatté prontamente l'interprete "i testi si mangiano e come. Fino
dall'antichità i libri sono stati
considerati
un alimento da assimilare. Non ha mai sentito frasi del tipo «una
persona nutrita di buone
letture?»
E anzi noi interpreti moderni, che abbiamo sviluppato una capacità di
sviscerare che fu totalmente ignota
agli
antichi, svolgiamo un'opera di grande democrazia e civiltà. Il nostro
lavoro permette a tutti di
accostarsi
a un nutrimento che prima era concesso solo ai dotti e ai professori,
mentre per gli altri poteva risultare
addirittura
pericoloso" "In che senso?" "Diamine, nel senso che un tempo i dotti
svisceravano solo per loro e
al
popolo lasciavano testi contaminati. Di questo si poteva anche morire.
Conosce Artemidoro?" "Solo per
sentito
dire..." "E' stato un grande specialista di onirocritica, l'arte di
interpretare il significato dei
sogni.
Senta che cosa dice a proposito del sogno di mangiar libri: «Questo
preannunzia benefici per i
professori,
i sofisti, e per tutti quelli che si guadagnano da vivere con le parole
e con i libri. Ma per tutti gli
altri
uomini, tale sogno predice morte». Come vede, un tempo sofisti e
professori si preoccupavano solo del loro
nutrimento
e del loro guadagno. Se poi le persone comuni morivano, tanto peggio
per loro. Oggi invece, per
merito
di noi critici...Io per esempio, oltre che alle mie ricerche mi dedico
molto anche a sviscerare i testi
per
la scuola". Quell'uomo, oltre che disgustoso, era anche ipocrita.
"Spero che avrete almeno un po' di rispetto per la poesia!" sbottai
"Perché?"
Mi resi conto che non avrei saputo rispondere a questa domanda, e
abbassai gli occhi. "Al
contrario"
continuò l'interprete felice del mio imbarazzo "il testo poetico è
molto più difficile da
assimilare,
e per questo ha un assoluto bisogno di essere sviscerato a dovere da
noialtri.
Non si faccia trarre in inganno dalla
sua
eventuale piccolezza, la poesia è come un tordo, un passerotto, un
beccafico.
Chiunque potrà
confermarle
che è molto più difficile starnare un tordo che non un fagiano. E anche
la dissezione, nel caso della poesia,
si
presenta particolarmente impegnativa perché occorre avere confidenza
con la forma metrica
del
testo, che è più complessa di quella prosastica. La procedura comunque
è questa: prima si individuano
i
«cola», cioè le «membra» della frase ritmica, poi si pratica la
«caesura», cioé il
«taglio»
all'interno dei singoli versi ovvero, a seconda del tipo di metrica
usata, la «diaeresis» cioé lo
«scostamento»
delle «membra» che sono state precedentemente individuate dal taglio.
In questo modo il testo poetico appare
già
sezionato secondo le sue principali linee anatomiche. Poi viene la fase
più difficile, si procede
cioè
all'amputazione dei vari «piedi» di cui il verso si compone, mentre, se
i «piedi» del verso contengono
«dattili»,
cioè «dita», è ovvio che bisogna procedere a una seconda amputazione.
Certe volte il verso potrà poi
presentarsi
già «acefalo», cioè «senza
testa»,
e in questo caso non ci sarà bisogno di decapitarlo...". Mi pareva di
assistere
al finale del Tieste, quando il padre riconosce sul vassoio teste,
piedi e dita dei figli che ha appena
divorato.
Pensavo a tutta la poesia che avevo letto, cioè assimilato, come diceva
lui, e invece me la sentivo
balzare
nello stomaco come se desse l'ultimo sussulto. "Io credevo che i testi
fossero solo dei libri" "Si sbaglia, sono dei
corpi"
ribatté seccamente l'interprete. Quando un autore muore, e non si può
più aggiungere altro
alla
sua produzione se non pochi scritti postumi, allora si
procede a comporre il corpus completo delle sue
opere,
ovvero
la raccolta di tutti i testi che riguardano l'autore" "Già sviscerati?"
"In genere sì.
Quando
si passa a redigere un corpus, i testi sono stati già ampiamente
sviscerati, in lungo e in largo" Questo suo modo
di
esprimersi, che un tempo avrei probabilmente trovato normale, mi fece
di nuovo venire i brividi. "Ma
dove,
scusi..." "Nell' introduzione, normalmente il corpus dei testi viene
sviscerato nell'introduzione" "E
dopo
aver composto questo corpus" mentre lo dicevo, mi accorgevo che anche
il cadavere, normalmente,
viene
composto nella bara "...ovviamente sviscerato come si deve, che cosa ne
fate?" "Lo
collochiamo
in uno scaffale, come del resto si è sempre fatto. Ha le opere di
Seneca?" Le avevo, e seppur
riluttante
mi alzai per andargliele a cercare. Con sgomento mi accorsi che le
possedevo in edizione completa, l'intero
corpus,
con ampia introduzione. L'interprete trovò rapidamente quello che
cercava. Stai a vedere
che
mi sviscera Seneca sotto gli occhi, pensai, ero già pronto a
impedirglielo.
Per fortuna non aveva
quella
intenzione "Si tratta del dialogo Sulla tranquillità dell'anima,
capitolo nove paragrafo sei. L'autore
parla
dell'abitudine, frequente anche ai tempi suoi, di riempire le
biblioteche con i corpora completi di tutti i
possibili
autori, noti ed ignoti..." "Sviscerati?" "Non si tratta di questo. E
poi di riporli in tecto tenus exstructa
loculamenta,
cioè in loculamenta costruiti fino all'altezza del soffitto. Capisce
cosa voglio dire?" "No" "Che gli
scaffali
delle librerie sono dei loculamenta, dei loculi, come le cellette di un
obitorio, o gli scomparti di un
grande
refrigeratore". "Si riprenda il coltello" gli dissi bruscamente "e stia
alla larga dai miei libri" "A me interessano
solo
i testi, dei libri non so che farmene". Il cane si era messo a
ringhiare.
"Mi è successo un
inconveniente" dice l'idraulico "il
flessibile
si è rotto e devo vuotare di nuovo l'impianto. Ha dei giornali?" Casa
mia rigurgita di giornali, ne raccolgo cinque o
sei
e li porgo all'idraulico. L'uomo li stende sotto l'acquaio e poi si
sdraia anche lui, per smontare il
flessibile.
"Sa, è molto vecchio..." "Che cosa?" gli chiedo "Il flessibile" "Ah,
credevo il giornale". L'idraulico non
mi
risponde neppure. Mentre lui si dà da fare con una grande chiave
inglese il mio sguardo si fissa su un
titolo,
proprio sotto il flessibile: Identificato l'assassino della donna
decapitata a Cattolica Accanto al titolo sta la fotografia di una casa
qualunque, una
specie
di condominio a terrazze, circondato da vecchi pini. Evidentemente è il
luogo del delitto o la casa
dell'assassino.
Ma è solo un attimo, perché una grande chiazza di acqua rugginosa si
spande sopra il giornale e
l'immagine
viene inghiottita. Credo di ricordare vagamente la storia, una ragazza
in vacanza, forse
una
maestra, comunque dalla vita irreprensibile. L'avevano trovata
decapitata nel bagno. Ma niente
più
di questo. Non ricordo né il nome della donna né i particolari della
vicenda. Dietro le spalle
dell'idraulico
cerco di leggere almeno la data del giornale, ma anche quella è
scomparsa sotto la chiazza. Come si chiamava
la
maestra? Per qualche tempo quella donna era diventata importante e il
suo caso aveva appassionato
migliaia
di persone. Ma adesso la sua storia si è dileguata, come tutte le altre
vicende di cronaca che
compaiono
sui quotidiani. La memoria non le trattiene, è impossibile ricordare
tutto quello che si stampa.
"Per
favore, altri giornali" dice l'idraulico preoccupato per l'acqua che
continua a spandersi. Glieli passo, lui li
apre
rapidamente uno sull'altro. Non saprò mai chi aveva ucciso quella
ragazza, e perché.
Sopra
il feroce omicidio di Cattolica si stende adesso una gigantesca
pubblicità della Macintosh, prontamente
inghiottita
dalla medesima macchia marrone, poi tocca alla cronaca di una giornata
politica, chissà quale, a un
articolo
culturale su revival di Omero...L'acqua continua a scendere, assorbita
da altre vicende che in quel liquido
marrone
trovano il loro oblio definitivo.
Veder scomparire tutte quelle parole
e quelle immagini mi procura
improvvisamente
un senso di dolore. "Ci vorrebbe della segatura" dice l'idraulico "i
giornali vecchi non
bastano".
E' vero, sono solo dei giornali vecchi, perché mi preoccupo
tanto? Sarebbe come preoccuparsi per
la
sorte della segatura. Basta che siano passate poche ore, e nessuno si
sognerebbe più di pensare che i
grandi
fogli di carta dei quotidiani contengano delle cose da leggere o da
ricordare. Sono già
diventati
segatura. Bisogna riconoscere che i giornali rispettano scrupolosamente
il loro nome, durano sempre e
soltanto
un giorno. Il mondo della parola scritta non ha mai conosciuto nulla di
così prezioso e di
così
effimero come i quotidiani, nessun prodotto dell'alfabeto ha mai
alternato fascinazione e disgusto a un ritmo
così
frenetico. I giornali vecchi sono un escremento, formano lo spurgo
della nostra società mediatica
proprio
come la segatura è lo spurgo delle segherie e la paglia quello della
trebbiatura. A volte i giornali
vecchi
li chiamiamo anche carta straccia, che è un altro modo per dire che
sono degli avanzi. Proprio come la
biancheria
che, anche la più fine, quando si logora diventa "straccio" e finisce
dal meccanico per asciugare le
ruote
degli ingranaggi. I giornali sono la biancheria che la nostra cultura
quotidianamente indossa, e
capricciosamente
getta via subito dopo essersene servita. "Se la ricorda la storia di
quella ragazza che avevano trovato
decapitata,
a Cattolica?" chiedo all'idraulico "No. Mi dia degli altri giornali,
per favore, guardi che qui si allaga
tutto..."
"Un delitto incomprensibile. La ragazza non aveva nemici, e non
frequentava ambienti sospetti. Una vita
esemplare,
un fidanzato che non era con lei..." "Perché non era con lei?" mi
interrompe
l'idraulico,
sempre ansimando. Il dado che stringe il flessibile è rugginoso, e non
vuole smuoversi. "Non era con lei
perché
- era imbarcato, capitano di corvetta della marina" "Ah, un militare"
commenta l'idraulico. Ormai è fatta, ho inventato. Non ricordo niente
di quella
vicenda,
soltanto che la ragazza era (forse) una maestra e conduceva una vita
irreprensibile. Però non sopporto
l'idea
che una sostanza futile e sporca come l'acqua rugginosa abbia
inghiottito per sempre la sua vita. Nata per
l'opera
infaticabile di qualche giornalista, la storia della maestra muore
adesso per il capriccio di un flessibile
e
(probabilmente) per la scarsa previdenza di un idraulico. Ma è giusto
questo? "Un bel
giovane..."
"Chi?" "Il fidanzato della morta" "Lei l'ha visto?" "No, ma c'erano le
foto sui giornali" "L'aveva ammazzata lui?"
"Al
contrario, fu subito escluso dalle indagini. Prima di tutto perché non
aveva alcun movente per
uccidere
la fidanzata, e poi perché il giorno del delitto era a largo di punta
Stilo, in navigazione" "E allora, chi l'ha
uccisa?"
Già, chi l'ha uccisa? A questo non sono preparato, la domanda
dell'idraulico
mi mette in difficoltà. Come i cantori antichi, quelli che
improvvisavano le gesta degli eroi nelle
regge
dei re omerici, cerco di tirare in lungo il racconto utilizzando delle
formule stereotipate. "Il caso si
presentava
difficile" continuo "anche perché chiunque avesse ucciso la ragazza non
era entrato da lei con la
violenza.
Le finestre erano tutte chiuse dall'interno, nessun segno di
effrazione. E la porta aveva la mandata.
L'assassino,
insomma, disponeva della chiave, che del resto non fu più trovata nel
mazzo della
maestra"
"La maestra?" "Sì, non gliel'ho detto? La ragazza era una maestra di
Vicovaro, Maria Luisa Gardoli, si chiamava,
una
bella donna di circa trent'anni" "Ah, era bella?" "Bellissima".
L'idraulico lascia la chiave inglese e
si
mette a sedere, guardando verso di me. L'acqua continua a gocciolare,
ed è sempre più rugginosa
"Vuole
altri giornali?" "Mi bastano. Ha detto che era una bella ragazza?" "Non
di una bellezza volgare, intendiamoci,
tutto
al contrario. Era alta, magra, con un viso piccolo ma molto vivace.
Somigliava un po'..." "A chi?" "a
Catherine
Spaak, se la ricorda?" "Certo che me la ricordo" esclama l'idraulico
con un sorriso "l'ho rivista l'altro
giorno
in televisione nel film Adulterio all'italiana. Che donna, la Spaak!"
Bel film, confermo, che donna.
Naturalmente
il film non l'ho visto. "E insomma, chi era stato ad ucciderla?"
L'idraulico insiste, io non
riesco
a escogitare nulla di plausibile. "La polizia non sapeva proprio che
pesci prendere. Anche l'unico indizio di
cui
disponevano era molto esiguo" "Sarebbe?" "Cioè, esiguo per modo di
dire. Avevano addirittura
l'arma
del delitto" "Ah, però" "La trovarono quasi subito. L'assassino,
fuggendo, l'aveva gettata dentro un
cespuglio,
nella pineta" "E la polizia non riuscì a scoprire a chi apparteneva?"
"Per la verità si trattava di
un'arma
così strana, così insolita, soprattutto in un posto come Cattolica..."
"Che arma era, un coltello da sub?" "Magari,
se
fosse stato così avrebbero potuto fare delle indagini nei negozi
specializzati. Era, era - un lungo
coltello
col manico di corno, piuttosto primitivo, con la lama di ferro ma
molto, molto affilata. Intervistarono subito
alcuni
esperti di armi da taglio, non fu difficile identificarlo come un
tipico coltello da gaucho argentino"
"Quelli
che vivono nella Pampa?" "Sì, quelli. Un coltellaccio che usavano i
gauchos di una volta per abbattere i capi
da
macello. Un'arma rara, gli stessi Argentini non usano più quel coltello
da molti anni. Ma non le
pare
che questo flessibile continui a perdere un po' troppo?" "Lo deve fare
finché la guarnizione non prende. Mi
passi
un altro giornale. E allora chi era l'assassino, forse un collezionista
d'armi anche lui?" "No" continuo, mentre passo all'idraulico altre
cronache dimenticate,
altre
recensioni di libri che nessuno ha letto "Maria Luisa aveva pochi
amici, tutti ben noti a Vicovaro.
Nessuno
di loro aveva passione per le armi. Lei del resto conduceva una vita
semplice e molto regolare, assieme al
ragazzino..."
"Quale ragazzino?" chiede l'idraulico meravigliato "Un figlio, che
aveva avuto anni prima
da
un uomo che non aveva voluto sposare" "Ma senti un po', anche un
figlio, aveva. E non poteva essere
lui,
l'assassino?" "Chi, il ragazzino?" "No, il padre" "Impossibile. Al
momento dell'omicidio era già
morto
da due anni in un incidente stradale". Squilla il telefonino
dell'idraulico, segue una breve conversazione in
cui
lui dice che in mattinata di sicuro no, perché deve finire un lavoro,
ma forse sarebbe passato nel
pomeriggio.
"Povero ragazzo!" esclama rimettendo in tasca il telefonino "che
sfortuna" "Davvero.
Chissà
come si sarà sentito, in tutta questa storia" "Quanti anni aveva?"
"Vuol dire quando la mamma fu uccisa? Sette"
"L'età
di mio figlio" dice l'idraulico "ma perché poi non si erano sposati?"
"Il padre del ragazzino aveva
già
una famiglia. Era un direttore didattico di Sarzana. Lui forse sarebbe
stato anche disposto a divorziare ma Maria
Luisa
si era opposta. Era molto religiosa. Aveva preso questa rinunzia come
una espiazione, un prezzo
da
pagare per l'errore che aveva commesso".
L'assassino ancora non vuole
venir fuori eppure continuo ad andare
avanti,
io stesso ne sono meravigliato. Sono certo che prima o poi troverò
anche chi ha ucciso Maria
Luisa.
Mi accorgo anzi che, da un po' di tempo a questa parte, ad ogni tappa
del racconto vedo come delle
immagini
di titoli e di occhielli: «Il figlio segreto della maestra»
«Parla don Pietrino, il
parroco
di Vicovaro» «Ritrovato il diario di Maria Luisa: so di aver
peccato»... Tutti questi grassetti, maiuscoletti, corsivi
scandiscono
nella mia testa i momenti di una vicenda del tutto inesistente, ma che
ha il potere di appassionare
l'idraulico
come se si trattasse di un autentico caso di cronaca. Ho l'impressione
che potrebbe durare
all'infinito.
"Secondo me era stato il fidanzato" azzarda l'idraulico "era geloso,
solo
l'idea che la sua donna aveva già un figlio da un altro! La gelosia è
una brutta bestia, molta gente
non
ragiona più, quando è gelosa" "Ma le ho detto che il fidanzato, al
momento del delitto, era in navigazione" "E
se
avesse preso un elicottero? Con un elicottero si va e si torna in pochi
minuti, e si atterra dove si
vuole"
"Non era mica un agente segreto, era solo un capitano di corvetta" "E'
vero "riconosce l'idraulico "e poi un
ufficiale
di marina non avrebbe mai usato quella strana arma per ucciderla. Ma
insomma, quel coltello da
gaucho,
hanno scoperto di chi era?" Siamo di nuovo al punto cruciale,
l'idraulico vuole sapere chi era
l'assassino
di quella bella donna, che rassomigliava a Catherine Spaak e che era
anche tanto religiosa. Non
posso
dargli torto, piacerebbe anche a me sapere a chi apparteneva quello
strano coltello. E anche chi aveva
ucciso
la maestra Maria Luisa. "A un certo punto lo hanno scoperto, ma
assolutamente per caso. Sembra
che
un tale di Albissola, che era emigrato in Argentina da ragazzo, quasi
cinquant'anni prima, fosse
inaspettatamente
ritornato in Italia. L'uomo aveva anzi cercato di rimettersi in
contatto con la sua
fidanzata
di allora, e l'aveva scongiurata di sposarlo. Ma lei non lo aveva
voluto perché nel frattempo si era
sposata
con un altro e aveva già figli e nipoti. Allora l'uomo aveva cercato di
rapirla, c'era stata una
colluttazione
col marito e l'argentino lo aveva ferito. Fu subito arrestato dai
carabinieri. Oltretutto la donna
giurava
che quell'uomo era un impostore, che il vero Andrea Barlomi..." "Andrea
Barlomi?" "L'argentino diceva di
chiamarsi
così. Ma secondo la donna il vero Andrea Barlomi, il suo fidanzato di
allora, era morto di tifo
durante
la traversata. Fosse o non fosse Andrea Barlomi, comunque, quell'uomo
in Argentina aveva fatto un po'
tutti
i mestieri, facchino, soldato, contrabbandiere, ballerino di tango.
L'Argentina di allora era molto
diversa
da quella di oggi. Poi Barlomi aveva aperto un locale notturno a Buenos
Aires e aveva fatto fortuna.
In
Italia era tornato ricco, questo Barlomi, ammesso che fosse lui,
naturalmente" "E come fu che lo
ricollegarono
al caso di Maria Luisa?" "I giornali, sempre i giornali. La stampa si
era subito interessata al
«Gaucho
di Albissola», come era stato definito, e avevano pubblicato dei
servizi su di lui. Gli inquirenti
del
caso di Maria Luisa si erano insospettiti, soprattutto quando avevano
letto che Barlomi aveva aggredito il rivale
con
un coltello. Decisero perciò di mandare un ispettore a interrogare il
sedicente Barlomi nel carcere di
Savona.
Non ci volle molto a farlo cadere in contraddizione e a fargli
confessare che era lui l'assassino
di
Cattolica" "Ma guarda che storia...Dunque era veramente Barlomi, o un
impostore?" "Ma non le
interessa
piuttosto sapere perché Barlomi aveva ucciso la povera Maria Luisa?"
"Certo che mi interessa.
Come
aveva fatto?" Il guaio è che, almeno per il momento, questo continuo a
non
saperlo
neppure io.
Non ho la più pallida idea del perché un ex-immigrante di
Albissola, magari un po' violento
di
carattere ma comunque già anziano, avrebbe potuto decidersi a lasciare
l'Argentina per venirsene fino a
Cattolica
e uccidere una brava maestra, bella come Catherine Spaak, molto
religiosa, che non aveva mai
incontrato
e di cui fino a quel momento ignorava l'esistenza. Forse potrei
guadagnare altro tempo dicendo
all'idraulico
che effettivamente quell'uomo non era Andrea Barlomi ma un impostore,
come del resto sosteneva
l'antica
fidanzata del Barlomi - ma allora che motivo avrebbe avuto, l'impostore
omicida, per andare poi
fino
ad Albissola e rapire una signora non più giovane, con tanto di figli e
di nipoti, sostenendo di
essere
il suo primo fidanzato? L'acqua continua a gocciolare, l'idraulico non
chiede neppure altri giornali. Quello che
gli
interessa, ormai, è solo che io gli finisca la storia e gli spieghi
perché Andrea Barlomi aveva ucciso Maria
Luisa.
Solo allora lui riaprirà finalmente il contatore dell'acqua e io potrò
rientrare in possesso della mia
cucina.
Prima però bisognerà togliere tutta quella distesa di giornali
inzuppati, che ormai è più
vasta
della Pampa su cui cavalcava un dì «Il gaucho di Albissola». "A volte
le vicende più drammatiche nascono da un'inezia" dico
finalmente
all'idraulico "una circostanza del tutto casuale. Sembra che Barlomi,
di ritorno dall'Argentina, avesse
deciso
di prendersi qualche giorno di vacanza prima di tornare ad Albissola.
Sbarcato all'aereoporto di
Milano
aveva lasciato la sua roba al deposito bagagli e aveva noleggiato una
macchina, per visitare la
riviera
romagnola. In Argentina aveva sentito parlare spesso di Rimini, di
Riccione, di Cattolica, e magari
avrà
pensato che uno come lui, avventuroso, esperto di locali notturni, da
quelle parti avrebbe anche
potuto
trovare qualcosa da fare". Il flessibile ha smesso finalmente di
gocciolare, e mi pare un segno di
buon
augurio, anche per la storia di Maria Luisa e del Barlomi. L'idraulico,
che dichiara di andare ogni
anno
a Cesenatico con la famiglia, conferma del resto che da quelle parti la
vita notturna non manca. "Giunto a Cattolica Barlomi noleggia un
ombrellone sulla spiaggia..."
"che
era proprio accanto a quello di Maria Luisa!" grida l'idraulico
tronfante. Non ho difficoltà a
dargli
ragione, anche se io, per motivi estetici, avrei preferito farli
incontrare più tardi al self service del
bagno.
"Proprio così, l'ombrellone assegnato al Barlomi era accanto a quello
di Maria Luisa. Ecco perché le
dicevo
che a volte le storie più drammatiche possono prendere le mosse da una
circostanza del tutto casuale. Maria
Luisa
prova subito simpatia per quell'uomo ormai anziano, così pieno di
nostalgia da aver
lasciato
una buona posizione a Buenos Aires per tornarsene alla sua cittadina
natale. E poi l'ha colpita il suo
linguaggio,
pieno di 'entonces' 'vamos' 'yo' e di forme dialettali liguri. E' una
maestra, inconsciamente è spinta
a
correggere i suoi errori e cerca di rieducarlo all'italiano di oggi. I
due passano alcune ore chiaccherando, poi si
salutano
e Barlomi dice a Maria Luisa che il giorno stesso sarebbe partito per
Albissola". "Invece non fu così" interviene l'idraulico che, per mia
fortuna,
adesso partecipa attivamente allo sviluppo della storia "il Barlomi
segue Maria Luisa, individua il luogo in cui
abita
e la sera va da lei" "Va da lei" continuo io "e le chiede di
correggergli una lettera che intende
spedire
alla sorella prima di tornare definitivamente a casa. I giornali ne
riportarono anche il testo,
perché
Barlomi, quel criminale, ebbe il coraggio di spedirla davvero. Una cosa
che fece molta impressione.
Dunque
Barlomi bussa alla porta di Maria Luisa e lei lo fa entrare.
Probabilmente Barlomi non pensava di
ucciderla.
Voleva davvero farle correggere la sua lettera, sentire la mano di una
maestra, giovane e
bella,
che lo aiutava a tenere la penna fra le dita. Poi però perde la testa,
è un violento, un
uomo
che ha corso molte avventure e ha ballato nei locali più equivoci.
Tenta di sedurre Maria Luisa, di farle
violenza,
e scoprendosi vecchio e incapace di sopraffarla la uccide con il suo
coltello..." "E la chiave?" Già, la chiave. Mi ero dimenticato della
faccenda della chiave
che
non fu più trovata nel mazzo della maestra. E pensare che questo
particolare l'avevo introdotto solo per
prendere
tempo, quando ancora ignoravo l'esistenza del «gaucho di Albissola» e
non avevo
la
più pallida idea di chi sarebbe stato l'assassino. Ma ormai vedo terra,
il caso è finalmente chiuso e questi sono
solo
gli ultimi strascichi della vicenda. "Per alcune settimane i giornali
avanzarono le ipotesi più diverse
sul
«Mistero della chiave scomparsa», come lo definirono, mettendo persino
in dubbio la ricostruzione della polizia e
negando
credibilità alla confessione di Barlomi. Si arrivò persino a insinuare
che non fosse lui
l'assassino
della maestra ma che fosse un mitomane, o addirittura un impostore che
convinto dal danaro coprisse la
responsabilità
di qualcuno molto, molto in vista.
Vecchio com'era, avrebbe avuto solo
una lieve condanna...Ma la
spiegazione
era più semplice di quanto si voleva pensare. Subito dopo aver ucciso
Maria Luisa, Barlomi sfilò la chiave dal
mazzo
di lei, controllò che le finestre fossero tutte serrate dall'interno e
si chiuse la porta dietro le spalle.
Sperando
così di far ricadere i sospetti sugli amici intimi che una ragazza così
bella, e così sola,
secondo
lui doveva per forza avere" "Non lo sapeva che era tanto religiosa..."
"Certo che no, avevano passato insieme solo
poche
ore" "Ma è possibile che nessuno li avesse visti parlare, sulla
spiaggia, quella mattina?" "Sì, un
bagnino,
il quale aveva dichiarato alla polizia di aver visto Maria Luisa
chiaccherare a lungo con un uomo anziano che
indossava
una camicia a fiori. Solo che quel bagno è frequentato in buona parte
da pensionati del
Nord
Italia, che hanno le vacanze convenzionate, e quindi la deposizione del
bagnino non era sembrata
molto
rilevante" "Ma guarda un po' che storia" dice l'idraulico "certe volte
la cronaca è ancora
più
incredibile dei romanzi" "E' a posto il flessibile?" gli chiedo "Certo,
guardi qua, ho riempito di nuovo l'impianto e non esce
più
neppure una goccia". Lo pago, sulla porta l'idraulico vuole darmi la
mano. "Senta" mi chiede
"ma
fu scoperto poi se quella canaglia del Barlomi era veramente lui o un
impostore?" "No" gli dico "non si
è
mai scoperto. O perlomeno" aggiungo esausto "i giornali non ne hanno
mai parlato".
"Antonio Rendine era solo
un imbecille. Spero che tu te ne
renda
conto".
Il mio dio ha sempre dei modi così cortesi, non mi aspettavo che
venisse a svegliarmi alle cinque del
mattino
per dirmi una cosa del genere. "Ma che c'è, non capisco..." balbetto,
cercando di accendere la
luce.
Finalmente trovo l'interruttore e lo vedo lì, seduto in fondo al letto,
con i suoi occhiali grandi e la faccia
simpatica
da vecchio zio. Ma questa volta sembra agitato. "Tutte sciocchezze"
continua "il vampirismo, il ventriloquismo, la
cultura
come opera dei pupi. Di persone come Rendine ne è pieno il mondo,
semplicemente non sopportano
di
leggere qualcosa di diverso da quello che hanno scritto loro. Sai come
diceva Benjamin Disraeli? Se voglio
leggere
un bel romanzo, lo scrivo". Provo a ribattere "Lui però non scriveva
romanzi, scriveva solo
sciocchezze..."
"Appunto. Solo uno sciocco può aver paura dei libri. I libri invece
sono sempre una grande
risorsa,
anzi, molto spesso salvano. Ma non ero venuto per dirti questo. Sembra
che il Gagliardo sia malato grave"
"E
di cosa?" Sono davvero stupito, non mi sarei aspettato che il Gagliardo
potesse ammalarsi, neppure di
influenza.
"Per ora non si sa. Lo hanno ricoverato ieri sera. Ecco qua, ti ho
portato i giornali, in ogni caso
farai
bene a guardare il primo notiziario alla televisione, dopo le sei". Il
mio dio si alza e si avvia verso lo
studio.
Attraverso il riquadro della porta lo vedo avvicinarsi a uno degli
scaffali, nonostante la luce incerta del
mattino
è già lì che fruga fra i miei libri. Ne tira fuori uno e si mette a
sfogliarlo. Poi ne prende un altro e
scompare
dalla mia vista. Dev'essere già entrato in qualche provincia del suo
politeismo librario, forse ha
scoperto
che la sera prima mi ero dedicato al dio Pasodoble, signore della
storia della danza, e si è
incuriosito.
Oggi il mio dio si comporta stranamente. Di solito quando viene a
trovarmi
mi porta dei libri, qualche romanzo dimenticato (che invece è molto più
bello di
quelli
che si leggono di solito), una raccolta di proverbi cinesi, il saggio
di un critico americano che dichiara di aver
finalmente
svelato il mistero dei Sonetti di Shakespeare. Invece questa volta mi
ha portato un pacco di giornali,
raccomandandomi
persino di accendere la televisione. Non lo aveva mai fatto. E poi,
arrabbiarsi così
per
la storia del diario Rendine! La malattia del Gagliardo deve averlo
sconvolto.
Nell'attesa del primo notiziario
televisivo
comincio a guardare i giornali. Che il Gagliardo sia malato dispiace
molto anche a me, e sono
preoccupato.
Su tutte le prime pagine sta la medesima foto del Gagliardo
rovesciato
su una barella, le mani immobili lungo i fianchi. I titoli: «Il
Gagliardo, improvviso malore»
«Il
Gagliardo d'urgenza all'Ospedale San Firmino, si teme per la sua vita».
Seguono le prime interviste ai medici. Si
può
supporre che si tratti di un infarto? Sembra di sì, in un'improvvisata
conferenza stampa il primario di
cardiologia
afferma però che ogni diagnosi è prematura prima di ...«ma siamo già in
grado di escludere categoricamente
che
possano presentarsi complicanze a carattere renale...» Questa frase
inaspettata mi fa sobbalzare. La televisione si
è
accesa da sola (che sia stato il mio dio ad azionare il telecomando?) e
la stridula voce del primario si spande
intorno
a me come se fosse uscita viva dal giornale. Adesso la stanza è
illuminata da una nuova luce,
l'inconfondibile
raggio aurale del piccolo schermo. Alzo gli occhi dai giornali e
comincio a seguire il notiziario. La sala
stampa
del San Firmino è piena di microfoni e di giornalisti. "Hai per caso le
opere di Montesquieu?" mi
chiede
il mio dio dal buio dello studio "Forse, nel terzo scaffale da destra,
vicino alla finestra". Il
primario
è letteralmente assediato, microfoni e telecamere sono protesi verso di
lui come un'onda che non riesce a
rovesciarsi.
Il dialogo è confuso, l'audio è imperfetto come le immagini, che
procedono a scosse «Ma non c'era
già
stato in passato qualche episodio del genere?» «A questa domanda non
posso rispondere»
«Ci
sarà un intervento chirurgico?» «Non prima di domattina» «Dunque ci
sarà?» «Non ho
detto
questo». I giornalisti prendono nota delle risposte del primario,
mentre il commentatore della rete, anche lui con in mano un taccuino,
interviene
per dire che, se il primario si esprime in questo modo, è facile
supporre che un intervento ci
dovrà
essere. Il primario esce dalla sala stampa, sempre seguito dai
giornalisti che spingono verso di lui i loro
microfoni
come se fossero dei tizzoni ardenti. Dopo la pubblicità, altre
immagini. Ecco il Gagliardo bambino.
Cammina
accanto a sua madre, su un sentiero di montagna. Finito il collegamento
col San Firmino sono subito
scattati
i servizi di repertorio. Deve essere un vecchio filmino amatoriale, il
Gagliardo bambino si volta verso
l'obiettivo
e fa una linguaccia. La mamma lo minaccia affettuosamente con la mano,
ha indosso scarponi, calze
pesanti
e una gonna a fiori. Sono certo che l'immagine di quella linguaccia sta
già facendo il giro del
mondo
via satellite e domani sarà su tutti i giornali. Specie se, speriamo di
no, le condizioni del Gagliardo
dovessero
aggravarsi. Ecco adesso il Gagliardo che si agita dietro il velo,
circondato da scribi e da
commentatori,
poi uno zoom sulla copertina del Libro dei Resolonghi, il Gagliardo a
una premiazione letteraria, in una
località
di mare, il Gagliardo che stringe la mano al Presidente degli Stati
Uniti. In pochi minuti la vita del
Gagliardo
è stata sezionata, tabulata, amplificata. Fra stacchi pubblicitari e
bollettini sanitari la
biografia
dell'illustre infermo si spande, come la maionese fuoriesce da un
tramezzino. «Siamo di nuovo collegati col San Firmino per un
aggiornamento»
compare il solito commentatore della rete col microfono e il taccuino
«il paziente ha riposato e ha orinato
regolarmente».
Domani ci sarà di sicuro polemica su questa frase. Si ha il diritto di
parlare così
esplicitamente
delle urine di qualcuno? Non c'è un limite all'informazione, che è dato
dalle barriere corporali e
dalle
regole della decenza? Prima però bisognerebbe decidere chi stabilisce
le regole della decenza e
soprattutto
quali sono. Anche di questo, comunque, ci sarà tempo per discutere a
lungo nei prossimi
giorni.
Il primario è tutt'ora introvabile, l'anestesista del reparto, stretto
fra due ali di cronisti, scuote la
testa
con un sorriso imbarazzato, non si rilasciano più dichiarazioni,
oltretutto non si sa neppure se
sarà
necessario un intervento e dunque se l'anestesista avrà o meno un ruolo
in questa vicenda. Intanto
«sono
arrivati i saluti del presidente della Repubblica». L'anestesista si
chiama Guido Baldini «ma non
è
lei che ha operato anche Gino Bartali?» Non è lui, è andata male. Però
adesso c'è il
giallo
delle rose. Pubblicità, pochi secondi di stacco. Il mazzo di rose è
stato recapitato, anonimo, al San Firmino
verso
le sette e trenta. In quel momento il custode stava parlando con un
cronista e l'enorme fascio di rose non
è
sfuggito all'attenzione della stampa. Per la verità, la tv riesce solo
a trasmettere un bagliore
amaranto,
appena un lampo, poi il camice bianco di un inserviente - «ma non si
può, non si
può...»
- si interpone fra le rose e la telecamera. Dopo un'oscillazione da
capogiro l'immagine va a conficcarsi sulle scale del reparto
cardiologia.
Chi sarà stato a inviare quelle rose? Intervistato dal commentatore
della rete, un noto cronista avanza
le
prime ipotesi.
Del resto io stesso aveva già notato, su uno dei
giornali che stamattina mi ha
portato
il mio dio, uno strano riquadro in terza pagina: «L'ansia di Pauline».
Adesso vado a riprendere
quella
pagina. Tanto c'è un altro stacco pubblicitario. Si era nel 1985 e il
Gagliardo non era ancora diventato così
famoso
come adesso. Aveva appena pubblicato il Libro dei Resolonghi e una sera
un giornalista mondano lo sosprese
in
compagnia di una ragazza fuori dalla porta di un cinema. Per quanto il
Gagliardo cercasse di coprirsi il
volto
col cappello fu riconosciuto subito. La ragazza, poi, rimase come
stranita dalla foto, una persona qualunque
che
non si aspettava un flash così accecante. Adesso la storia è ritornata
fuori. Si trattava di
Pauline
Sackermann, una ragazza di Freiburg che il Gagliardo aveva conosciuto
in una stazione sciistica. Finita la
pubblicità,
in tv già compare il portone di casa della ragazza, a Freiburg. Un
lussuoso palazzo a tre piani. La
telecamera
avvicina l'immagine e inquadra i campanelli, in effetti sul terzo
cartellino dal basso c'è
scritto
«Sackermann». Il dito di un giornalista schiaccia il pulsante, una due
tre volte. L'obiettivo si posa ansioso sul
citofono
in ottone lucidato. Nulla, Pauline non è in casa o forse non vuole
rispondere. Sarà stata lei a mandare
le
rose rosse? Il servizio da Freiburg si conclude con un certo senso di
delusione. Compare un critico famoso al quale viene chiesto di
tracciare un breve
profilo
letterario del Gagliardo. «Un'opera che travalica la narrativa» dice
«per
investire
l'intera cultura del nostro secolo e forse anche più in là...» Il
critico ha una gran pancia e siede sullo
sfondo
della sua biblioteca personale «Ci parli del velo del Gagliardo» Il
critico sorride «Non credo alla sua
esistenza»
dice pacatamente «il velo rappresenta solo l'impenetrabilità della
perfezione, è un puro simbolo
letterario....»
Bruscamente siamo di nuovo in collegamento col San Firmino «ci scusiamo
con i telespettatori,
torneremo
a collegarci col professor Tiranzi subito dopo che...ecco, il primario,
sì, l'informazione era
esatta,
il primario sta entrando nella sala stampa...» Solita ridda di tizzoni
ardenti, il primario avanza a fatica e si siede
dietro
il tavolo «siamo in attesa, ansiosi ovviamente...eccolo dunque, devono
aver finito...». Il primario
si
schiarisce la voce: «Posso dire che il paziente ha superato felicemente
la notte ed è fuori pericolo.
Si
è trattato di un semplice attacco anginoso, non ci sono infarti o
lesioni di sorta...» «Fra quanto
potrà
tornare dietro il velo?» lo interrompe una giornalista «Al più presto,
al più presto» sorride il
primario
«la prognosi è sciolta ma non voglio ancora pronunziarmi sulla
convalescenza» «Ha fatto colazione?» chiede un
altro
giornalista «Ha preso del the» «Ha chiesto i giornali?» «Non gli è
ancora permesso leggere, ma
posso
dire, sì, li ha chiesti...» «Aah...» L'audio
continua
a essere pessimo mentre altre domande rimbalzano fra i rumori della
sala
stampa:
quali sono state le prime parole che il Gagliardo ha pronunziato quando
ha ripreso conoscenza?
lei
conosce Pauline Sackermann? pensa che il Gagliardo scriverà un libro
sull'esperienza della
malattia?
è vero che il Gagliardo ha un coccodrillo azzurro tatuato sulla pancia?
La domanda ha un effetto paralizzante sul primario e su tutti gli altri
giornalisti.
Lo si percepisce dal silenzio in cui inspiegabilmente cade. E' come se
questa uscita, per quanto
assurda
e inattesa, avesse rovesciato il senso dell'evento, che ormai si avvia
ineluttabilmente a diventare
questo:
un coccodrillo azzurro tatuato sulla pancia del Gagliardo.
Il
misterioso tatuaggio interessa già
più
della salute stessa dell'infermo, più della sua ripresa, più della sua
futura attività letteraria. Ma
è
solo un attimo. Il primario esce dalla sala stampa, agitando le mani,
solita ridda di tizzoni ardenti, fino al prossimo
bollettino
non rilascerà altre dichiarazioni. Il commentatore della rete, con il
suo taccuino in mano e l'impermeabile
col
bavero rialzato, per far vedere che fuori ha cominciato a piovere,
passa la linea allo studio, dove il
professor
Tiranzi è ancora in attesa di riprendere il suo profilo letterario del
Gagliardo. Ma la faccenda del
coccodrillo
azzurro, appresa via monitor, deve aver turbato anche lui. In ogni
caso, le sue osservazioni
sull'importanza
dell'opera del Gagliardo suonano ormai fiacche e prive di interesse.
Un'altra notizia. Pauline
Sackermann
è stata rintracciata a New York, dove pare che abbia rilasciato una
lunga intervista in esclusiva
a
un settimanale americano. Avrà mandato lei il mazzo di rose ? Non
sapremo niente fino a domani. Torna
la
faccia del Gagliardo in sovraimpressione, poi una rapida immagine del
velo. Grazie professor
Tiranzi.
Pubblicità. Io mi alzo per andare in cucina a farmi un caffé. Segue un
servizio di
repertorio
sulle malattie di celebri scrittori. Vecchi baffuti con accanto
infermiere di stazza forte, giovanotti fotografati
alla
finestra di un sanatorio, «la volta in cui Hermann Hesse rifiutò una
trasfusione di sangue», la
malattia
più drammatica, più assurda, più protratta, fu comunque quella di
Cesare Pavese. Perché non fu vera
malattia.
Dino Campana in manicomio. Torno in camera con il caffé. Il primario è
di nuovo
nella
sala stampa. Dopo la terza o quarta conferenza ha assunto un tono molto
più sicuro. Ormai si sdraia letteralmente
fra
i microfoni e mette le gambe sul tavolino. Dal taschino del camice
penzola uno stetoscopio, sotto si intravede la
seta
splendente di una camicia di prezzo. «Posso confermare il bollettino di
un'ora fa. Il paziente
è
completamente fuori pericolo. Escludiamo qualsiasi complicazione di
carattere circolatorio. Le condizioni
generali
sono buone...» «Si prevede una rapida ripresa?» «Rapidissima» «I
familiari
sono
con lui?» Il primario sorride senza rispondere «Conosce Pauline
Sackermann?» Il primario sorride ancora «E' vero
che
il Gagliardo ha un coccodrillo azzurro tatuato sulla pancia?»
La voce è la stessa di pochi minuti fa e
intorno
si spande lo stesso, brevissimo gelo. E' ormai chiaro che l'attenzione
dei media si va concentrando
esclusivamente
sul coccodrillo azzurro. Lo stesso commentatore di rete, per quanto
privo di qualsiasi informazione
reale,
si sente costretto ad affrontare l'argomento. Già parla di camicie
Lacoste, di scarificazione
rituale,
di body piercing. In effetti nessuno avrebbe mai potuto sospettare che
il Gagliardo nascondesse un simile
segreto.
Ma se la notizia è circolata vuol dire che qualcuno, un infermiere, o
un dottore,
nell'intimità
dell'emergenza ha potuto notare la presenza di questo tatuaggio sul
ventre dell'illustre infermo. Altrimenti come
sarebbe
potuta nascere una notizia del genere? Anche se non lo si dice ancora
esplicitamente, si sospetta
l'appartenenza
a qualche società segreta, oppure il residuo indelebile di un'avventura
misteriosa che riemerge
dal
passato del Gagliardo. Che in effetti è così poco conosciuto. Bisognerà
scavare,
scavare.
Il Gagliardo è stato forse mercenario in Kenia?
La faccenda delle rose,
e di Pauline Sackermann, è ormai passata
del
tutto in secondo piano. A meno che la ragazza non sia in grado di
fornire rivelazioni anche sul coccodrillo
azzurro.
Speriamo che al prossimo notiziario, fra meno di un'ora, siano in grado
di dare qualche nuova
indiscrezione.
Il mio dio fa capolino dallo studio con un libro in mano. Ha
uno
sguardo
piuttosto ansioso. "E' fuori pericolo" grido "si è trattato di un
semplice attacco anginoso" "Ah, meno
male!"
dice con un sorriso. Sembra davvero sollevato "Che cosa pensi della
faccenda delle rose?" gli chiedo
posando
la tazzina del caffé "Quali rose?" chiede a sua volta lui, meravigliato
"Quelle che qualcuno ha mandato
all'ospedale.
Pensi che sia stata davvero Pauline Sackermann?" Il mio dio ha lo
sguardo di uno che,
sinceramente,
non capisce. "Ma non hai sentito? E questo è niente. Sembra che il
Gagliardo abbia un
coccodrillo
azzurro tatuato sulla pancia. Come puoi capire, se questa notizia fosse
confermata..." Il mio dio sembra
sempre
più stupito "Ma che cosa hai fatto in tutto questo tempo?" gli chiedo
"Ho cercato una frase, anzi un
verso
che cita Montesquieu nello Spicilegio..." dice il mio dio stringendosi
nelle spalle "Ma come, in
una
circostanza come questa ti sei messo a leggere? con tutto quello che
sta succedendo al San Firmino!" "E' un
bellissimo
verso" mi interrompe il mio dio come se volesse giustificarsi "dice «E
che? abitate a Delfi, e credete all'oracolo!» Era tanto tempo che lo
cercavo" "Ma non ti interessava sapere
come
stava
il Gagliardo?" "Certo, ero molto preoccupato. Ma ora so che è fuori
pericolo e sono contento"
"Però
non hai visto il mazzo di rose, la casa di Pauline Sackermann, e
soprattutto non sai nulla del coccodrillo
tatuato..."
Mentre continuo a parlare sento chiudersi la porta di casa. Il mio dio
dev'essere uscito. Credo che
come
al solito abbia ragione lui. Ma come, abito a Delfi, e anch'io credo
all'oracolo?
La foglia di alloro pende
sopra il suo naso. Ovidio non la
guarda,
non
la tocca, non la stacca, semplicemente la sgrappola: cogliendo una ad
una tutte le parole che la riguardano.
Verde
cupo, odore, taglio ondulato dei bordi, nervi duri, bambino che la
annusava (lui), narici (messa sotto
le)
fin quando il profumo non gli dava alla testa. E poi Daphne, statua di
lei a Sulmona, dita che si innervano di
rami,
e il sangue si fa linfa nelle vene (o dèi, è già un verso!) occhi
irrigiditi e alla
fine,
sul bordo estremo della vita, una chioma di foglie su cui posare un
bacio. Ecco che la foglia non sta più semplicemente sopra il suo naso.
Si
è fatta descrizione e racconto, le sue nervature a spina di pesce sono
già diventate un albero
sintattico,
una specie di grafo. In pratica lui sarebbe già pronto per scrivere su
una tavoletta cerata: "Amo le foglie
di
alloro, mi è sempre piaciuto annusarle e sentirne il taglio dell'orlo
sulle labbra. Se dovessi scrivere una
poesia..."
O meglio ancora, sarebbe già in grado di comporre direttamente dei
versi sulla metamorfosi di Daphne.
Eppure
ha semplicemente visto una foglia d'alloro che pende sul suo naso, solo
questo.
L'ha guardata
senza
neppure toccarla. Se fosse una persona come tutte le altre Ovidio
staccherebbe quella foglia dal ramo
e
se la passerebbe per un momento sulle labbra. Poi la getterebbe via.
Invece no, per vederla, per
toccarla,
per possederla, lui la mette automaticamente in forma di parole. Le
cose non gli sembrano vere finché non ne ha trovato tutti i
possibili
equivalenti verbali. E per grazia delle Muse possiede una capacità
straordinaria nello scovarli. Se la
foglia
di alloro che gli pende sul naso non avesse assorbito la sua attenzione
probabilmente sarebbe toccato alle
nuvole
che trascorrono nel cielo (bianche, spuma, fastose inesistenze,
rimbalzano nel vento) o al dolore
che
prova alla spalla sinistra. Perché neppure i dolori gli sembrano veri
finché non ha trovato il modo
di
enunciarli. Questo naturalmente non gli impedisce di sentire male come
tutti gli altri ma, fino al momento in
cui
non si è imbattuto nelle parole adatte (fiamma che nascostamente arde)
non riesce a sentir bene neppure il
dolore.
Perché accade tutto questo? La spiegazione è semplice. Ovidio ha una
vita scritta. Ha
passato
anni e anni, quasi tutti quelli che ha vissuto, a imparare a scrivere.
E ci è riuscito. Gli hanno insegnato che
scrivere
è l'unico modo per capire il mondo e, soprattutto, per capire se
medesimo. Ovidio è convinto che
capire
e scrivere siano la stessa cosa, proprio come vedere e scrivere,
sentire e scrivere. La scrittura viene prima di
ogni
altra cosa e la vita, se non è passata attraverso il suo filtro, è come
se fosse inesistente.
Non
ci sono sensazioni finché non sono chiuse dentro un giro di frase, non
esistono foglie finché non si siano
mutate
in un grappolo di parole meticolose, elastiche e sonore. Le persone
comuni pensano che la scrittura sia
qualcosa
che si aggiunge alla vita e al mondo, un di più, come la bravura nel
cavalcare o l'arte della
cetra.
Si sbagliano. La scrittura non si aggiunge alla vita, la contiene
tutta. Che hai, ragazzo? gli dicevano i vecchi quando lo vedevano
arrossire al
passaggio
di una fanciulla. Sei innamorato? E sorridevano al giovane Ovidio.
Subito il precettore lo
prendeva
per mano e lo trascinava a casa. Ecco le tavolette, ecco lo stilo, gli
diceva, scrivi se vuoi
capire
cosa provi. Scava la tua via dentro i sentimenti scrivendoli in tante
parole rapide e ordinate. Solo in
questo
modo potrai pretendere di amare.
Occorrono aggettivi, verbi attivi e
passivi, giochi di parole e di
sintassi,
figure di analogia - devi scriverti, Ovidio, e scrivere lei. Altrimenti
come potrai pretendere non solo di
amare
ma addirittura di esistere? E da allora lui, ininterrottamente, non ha
mai smesso di scrivere. I
suoi
compagni d'infanzia, come Marcello, hanno già conosciuto l'amore, la
guerra, poi la carriera
nell'esercito.
E continuano a vivere in questo modo. Marcello, per quanto abbia
ricoperto il grado di proconsole in Bitinia,
a
volte si concede persino la libertà di stare ore e ore senza far nulla,
specie quando rientra dai suoi lunghi
viaggi,
e va in cerca degli amici per raccontare le sue avventure. Ovidio
invece non smette mai di scrivere.
Non
solo quando traccia i caratteri sulla tavoletta ma anche quando parla,
quando soffre e quando mangia
oppure
quando gli capita sul naso una foglia d'alloro. Scribo. Quando quel
lampo di scrittura gli si accende
dentro,
cioè quasi ad ogni momento, c'è una parola segreta che utilizza per
dirselo (anche questa sensazione
deve
metterla in parole, se vuole davvero provarla): Robisc. E' come il
sibilo di un animale ignoto, il
colpo
di frusta che il padrone infligge ai gladiatori mentre si esercitano.
Che cosa cerca Ovidio ogni volta che scrive? Ovviamente è in
grado
di spiegarlo, anzi di scriverlo. Robisc! Quando subisce questa sua
insostenibile frustata alla scrittura Ovidio
segue
una voce che ha dentro, così rapida che spesso teme di non fare in
tempo a registrarne le parole. E'
la
voce di un altro? No, è la sua voce scritta. Talmente bella che a volte
stenta a credere che davvero gli
appartenga,
e sarebbe proprio un peccato che andasse perduta. Per questo la
registra con tanta
diligenza.
Questa voce che pure è sua ha il potere di raddoppiare lui, Ovidio, in
una seconda persona mentre
cammina,
mangia, si esercita al Campo Marzio, compie le sue funzioni fisiche. La
voce lo separa da sé,
scrivendo,
e lo rende straordinariamente bello e attraente. Ormai Ovidio non
saprebbe più rinunciare alla
gioia
di questo specchio che, nel gioco dei caratteri alfabetici, gli
restituisce un'immagine perfetta di
sé.
Non c'è soltanto l'Ovidio che beve o che ama, c'è anche l'altro Ovidio,
che scrive di bere o che, amando,
scrive
il seme che si perde in un flusso prima brusco poi sempre più lento, a
scosse, mentre le membra si
sciolgono
nel languore. Robisc. Ovidio sa che questa voce scritta, che
tanto lo rende più
bello
di sé, gli sopravviverà nel tempo e diventerà nei secoli la voce di
altre migliaia di persone. Non sbaglia. L'Ovidio
bello,
che scrive e sgrappola foglie di parole, l'Ovidio che spande seme in un
sussulto prima brusco poi a
scosse
sempre più lente, resterà, anche quando più nessuno si ricorderà
dell'Ovidio che
semplicemente
sedeva sotto una foglia d'alloro o si abbandonava al piacere con una
flautista. Ovidio diventerà la
voce
di altri, che attraverso di lui si raddoppieranno o apprenderanno il
modo di farlo. E' il miracolo che la
scrittura
riesce a compiere quando, con dolorosa e meticolosa privazione, fin
dall'infanzia si è
imparato
a duplicare in forma alfabetica qualsiasi momento della vita propria e
di quella altrui. E pensare che molte persone scrivono solo
eccezionalmente e in casi
disperati.
Per loro la scrittura è una forma di emergenza, di calamità naturale.
Non scrivono mai se
non
quando sono immensamente infelici o quando lasciano un biglietto sul
letto prima di tagliarsi le vene.
Scrivono
come un astemio si concede un boccale di vino forte per combattere un
dolore che altrimenti sarebbe
insostenibile.
Con quello che mi è successo, sembrano dire, posso anche permettermi
qualche frase! Magari
si
azzardano persino a scrivere delle poesie, pensano che in quei momenti
nessuno potrebbe biasimarli.
Che
errore.
Così la scrittura non li fa belli, ma brutti. Perché il
paradosso vuole che essi decidano di
raddoppiarsi
solo nei momenti in cui - amori infelici, disperazione della vita,
morte - il loro aspetto è
peggiore
e la loro voce più aspra. Che goffa immagine lasceranno di sé, ammesso
che qualcuno voglia davvero
ripeterla
e conservarla. Non hanno parole magiche per la scrittura, solo grida
strozzate, bofonchi o scoppi amari
di
risa. I loro racconti hanno trame brutalmente calcate sulla vita, le
loro poesie sono cariche di oggetti
come
la carretta di un emigrante. Scritture senza miracolo. Oh, Robisc!
Ovidio ha scritto anche cose brutte, specie da giovane. Il suo
castigo,
il suo saltuario inferno terreno, consiste nel ricordarsene. Egli non
dimentica una sola frase di quello che ha
scritto
e a volte le parole goffe e sbagliate che gli è capitato di usare
tornano a stormo verso di
lui.
Sono frasi che emergono da una distanza di trent'anni, un abisso pieno
di parole che la sua memoria è in
grado
di ripercorrere palmo a palmo con la precisione di un telescopio.
"Dobbiamo andar per funghi" -
perché
quella volta ho usato il troncamento? "Lo so, eravate stanchi e non
aveste più voglia alcuna di
filosofare..."
che verso presuntuoso. "Le farfalle son fiori / di primavera" che
metafora triviale e senza senso. Nelle notti
insonni,
quando lo stomaco stenta a digerire il vino bevuto, le parole sbagliate
bussano alla sua mente
come
parenti ignoranti di cui provare vergogna. Il rimorso per le parole
brutte è l'unica punizione
che
la scrittura ha inflitto al suo figlio più caro. Per il resto Ovidio ha
avuto tutto dalla scrittura. Anche se in cambio
le
ha consegnato l'intera vita e, addirittura, i suoi stessi occhi. "Ho
visto cose" gli ha detto Marcello di ritorno dalla campagna d'Asia
"che
altri mortali non vedranno mai. Fontane che versano fiamme, alberi
melodiosi, intere città
costruite
di foglie e di cristallo. Sui monti del Caucaso ho incontrato uomini
che ignorano l'uso del linguaggio e
fuggono
più veloci di uno stambecco..." Marcello ha visto, con i suoi occhi,
come tutti i viaggiatori. Ovidio
non
ha mai visto nulla, ha letto. E soprattutto ha scritto, perché per lui
leggere è sempre
stato
solo un mezzo per poter scrivere. Robisc. Con un colpo di frusta il
sibilo della parola magica gli ha distolto gli
occhi
da tutto ciò a cui avrebbe potuto rivolgerli e lo ha costretto a
fissarli unicamente sulla tavoletta
cerata.
Gli occhi di Ovidio non sono più distinguibili dall'alfabeto, è la
scrittura che per lui rende
visibile
la realtà. Marcello ha viaggiato e vagato, conosce l'orrore notturno
delle navi in fiamme, alla deriva, fuori
dalle
mura di Durazzo, mentre Ovidio non si è mai mosso da casa sua. Però
potrebbe scrivere tutto
quello
che Marcello gli racconta, anzi, mentre il suo amico parla Ovidio lo
sta già facendo. Che povere parole usa,
Marcello,
per descrivere ciò che ha visto! Espressioni grumose, opache, a una a
una Ovidio le diluisce, le lucida,
le
distende, finché la notte di Durazzo è diventata un immenso cristallo
che fiammeggia nel buio. La foglia d'alloro oscilla come la lancetta di
un pendolo.
Tempo che
scorre.
Ovidio chiude gli occhi, per un momento la voce della sua scrittura
tace e la parola magica non
è
pronunziata dentro di lui. Non ce n'è bisogno, l'anima oscilla come una
barca sospesa fra due correnti
opposte
e quindi immobili. Ovidio ha raggiunto il beato centro della sua
perfezione, altra immagine di
sé
più compiuta di quella che la sua scrittura adesso gli rimanda non
potrebbe esistere. Ovidio è felice. Che
grande
fortuna è la sua. Lui infatti non sospetta ancora niente.
Noi invece
sappiamo che, ormai, non c'è più alcun bisogno
di
sciogliere e legare in un fascio di sillabe quella foglia. Basta che
entri dentro un'immagine ed è già
diventata
milioni di altre foglie, pronte a vivere altrettante vite indipendenti
da qualsiasi parola scritta. La realtà ha
imparato
a duplicarsi da sola, senza più bisogno di ricorrere all'arte dei
fantasmi alfabetici. Scrivere non serve
più
per afferrare il mondo, così come non serve più per afferrare noi
stessi e tutti gli altri uomini. Tra breve
sarà
sufficiente mettersi di fronte a una delle infinite finestre luminose
che punteggiano la nostra vita e guardare
senza
mai distogliere gli occhi. Dopo pochi secondi, un brusco esplodere di
linee e di punti avrà
già
disegnato sullo schermo il nostro ritratto e quello di tutto ciò che ci
riguarda. Tra breve quella voce
scritta,
sonora, con cui Ovidio si distaccava da sé medesimo diventerà
indecifrabile e soprattutto inutile. Nessuno
avrà
più alcun motivo per dedicare tutta la propria esistenza all'arte di
imparare a scrivere. Forse sarà
addirittura
una liberazione. Anni trascorsi a sviluppare la musica mentale delle
parole, la trasparenza delle
immagini,
l'orrore per le ripetizioni e le stonature dello stile. A che scopo
continuare a farlo? Ci saranno altri
specchi
per noi, sempre più facili e più completi. La scrittura muore, e tanta
vita meticolosamente scavata nelle parole -
stilo,
penna, caratteri di stampa - è destinata a svanire né più né meno della
vita
ordinaria
di tutti coloro che non scrivono nulla. La scrittura muore e con lei i
libri si spengono, ad uno ad uno, come le lampade di
una
luminara che progressivamente cedono al buio della notte per semplice
consunzione dell'olio. Ma il
vento
sale, un altro soffio, un sibilo. Robisc?